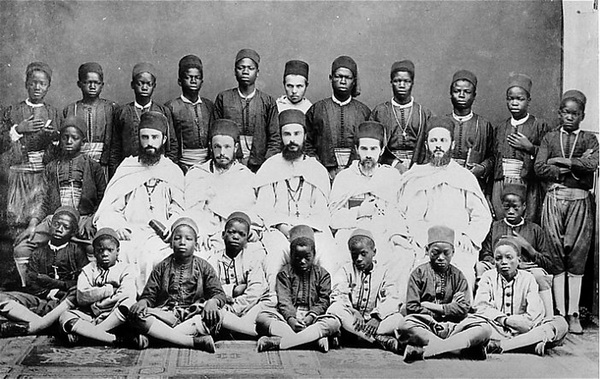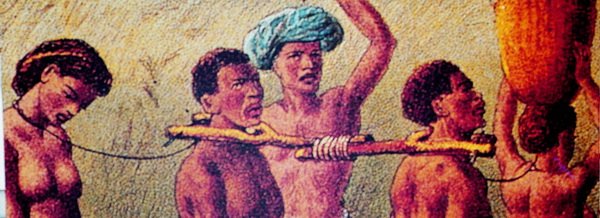Esperienze 1/ Borgata Liretta
Marito e moglie affiatati. Dopo una vita di lavoro e
volontariato decidono di dedicarsi totalmente agli altri. Ridando vita a una
borgata di montagna e ospitando coppie di sposi in cerca di tranquillità e
riflessione. E foendo un accompagnamento prezioso: calore ed esperienza.
Nell’essenzialità totale.
È sera, piove a
dirotto e il sentirnero verso borgata Liretta scorre in salita lasciando
intravedere, tutt’intorno, una natura selvaggia. È da Montemale (Cn) che
continuiamo a seguire le insegne di legno con raffigurata una piccola casa
tonda, tre finestre e un albero. Dopo qualche peregrinare eccoci giunti a
destinazione. Parcheggiamo l’auto e ci avviamo verso l’unica fonte di luce
circostante. La lucina ci conduce in una sala da pranzo in cui, con un gran sorriso,
ci accolgono Olga e Mario Garrone.

Non siamo soli a Liretta. Oltre la
figlia di Olga e Mario con la sua famiglia, c’è una giovane coppia con una
piccola di sei mesi e Maurizio Nai, responsabile del Circolo della Decrescita a
Cuneo.
È una bella tavolata, l’atmosfera è
calda e la zuppa servita in tavola ha un sapore veramente genuino. Olga ci
spiega qualche segreto culinario anche se il cuoco d’eccezione e per le grandi
tavolate è Mario che, non a caso, indossa un grembiule firmato «Il cuciniere».
La dicotomia è forte: fuori pioggia e fango imperversano, dentro l’umanità si
racconta. La convivialità sembra essere di casa e, approfittando di uno spazio
più appartato della mensa, cerchiamo di capie di più su questo angolo di
vita. La più ciarliera è Olga che, con fare entusiasta si racconta. «Le cose
non accadono mai a caso, Liretta è il frutto di un lungo cammino personale.
Mario e io abbiamo avuto la fortuna di conoscerci giovani e con un lavoro
sicuro. A 22 anni facevo già la maestra e Mario lavorava in banca. Facevamo
parte di un gruppo di giovani universitari post-concilio che si realizzava
fuori dagli schemi parrocchiali. Cercavamo di crescere nella fede e
nell’accoglienza verso gli altri. Il sabato lo dedicavamo all’aiuto dei più
bisognosi: disabili o ragazzi di strada. Il volontariato, l’approfondimento
della spiritualità e l’attenzione verso il prossimo era la molla che ci
accomunava e che non ci ha mai abbandonati».
I primi anni
Mentre Olga si racconta, l’atmosfera della sala da
pranzo si fa più raccolta. I più «piccoli» iniziano a dare cenni di cedimento e
si avviano verso le stanze per la notte. Approfittiamo della sosta per fare un
giro. Legno e pietra rallegrano la borgata anche nel cuore della notte.
L’accoglienza nottua di Liretta si compone di tre stanze dai nomi bizzarri:
oblò, chambre bleu e curiusa. A noi tocca quest’ultima, così
denominata per le sue grandi vetrate che spiano verso la strada. Nell’estrema
sobrietà, tutto è molto curato. Due bagni comuni sono a disposizione degli ospiti,
come anche un’altra piccola cucinotta, adiacente alle camere.
Toiamo nella sala da pranzo, oramai quasi solitaria e
anche Mario si siede al nostro fianco. La storia riparte: «Intoo al 1974,
appena sposati, abbiamo pensato di non chiuderci agli altri ma di essere una
coppia aperta. Abbiamo vissuto gli anni Settanta, anni di rivoluzione sotto
tutti i fronti, intensamente. Un ’68 vissuto al positivo con tutta la fatica di
sradicare un vecchio sistema ma anche il piacere di vivere la ribellione e il
sentirsi diversi. Di quel tempo ci è rimasto addosso il sogno del cambiamento.
Il nostro sentire comune e il nostro desiderio era di rendere il nostro amore
un punto di riferimento per gli altri. Su questo, qualcuno di lassù, ci ha
ascoltati e messi seriamente al lavoro».
Olga e Mario, già da neo sposi iniziano a collaborare
con la Pastorale Famigliare per la Diocesi di Cuneo e a organizzare gli
incontri prematrimoniali per giovani coppie. Quando arrivano i bambini (Olga e
Mario hanno 3 figli), non cessano certo il loro impegno nel sociale, anzi. Olga
e Mario, si ritrovano a dialogare delle loro scelte con i figli e a renderli
partecipi del loro agire. In quest’ottica di apertura, proprio dai figli
adolescenti giunge la richiesta di una maggiore attenzione da parte dei
genitori che per un paio di anni si dedicano così solamente ai loro ragazzi.
La famiglia chiama e Olga e Mario rispondono. Sono gli
anni delle baby pensioni e Olga pur utilizzando questa favorevole opportunità
anticipa la «ritirata» e attende quattro anni prima di percepire la prima
mensilità. Ecco che arrivano le rinunce per star vicino ai figli. «Anche in
questa occasione poter dialogare insieme ai figli è stato fondamentale. Meglio
una mamma più presente, che una serata in più in pizzeria. La vita insegna e in
questa fase abbiamo iniziato a rinunciare a tante piccole cose superflue,
accorgendoci che si viveva benissimo anche con molto meno. Pur non sapendo
nulla sulla decrescita, c’era la volontà di essere “sobri” e di praticare la
semplicità quotidianamente».

Il vero cambiamento
Come si arriva a una trasformazione così radicale della
propria vita? Questa volta a prendere la parola è Mario: «Alla base di tutto c’è
una propensione alla provvisorietà, al cambiamento. Per noi, il desiderio forte
è sempre stato quello della capanna e non del castello. Una dimora semplice,
con pochissime porte per dare la possibilità a tutti di entrare e uscire senza
problemi. La molla è stato il desiderio di scrollarsi di dosso le cose che non
servono, le occasioni di farlo sono giunte lungo nel cammino. Per costruire
qualcosa occorre prendere coscienza delle proprie potenzialità, sapere chi
siamo. In poche parole: conoscersi. Noi sapevamo di essere un punto di
riferimento per le coppie e le famiglie e su questo abbiamo posto le prime
pietre e costruito il nostro futuro. L’umiltà fa il resto».
Olga aggiunge con discrezione: «Una volta cresciuti i
figli ci siamo interrogati su cosa fare delle nostre esistenze e siamo partiti
da un’analisi. I giovani sposi dopo il matrimonio venivano «abbandonati».
Sembrava che tutto accadesse prima: i corsi di formazione, i cammini spirituali
e poi più nulla. Questo ci ha fatto riflettere e capire che il nostro supporto
doveva essere tanto pregnante prima quanto dopo, per non lasciare che tante
coppie si sentissero abbandonate a gestire i primi dissidi familiari.
Continuavamo a fare gli incontri pre matrimoniali in Diocesi ma avvertivamo in
maniera sempre più profonda la mancanza di uno spazio piacevole dove poter
dialogare in armonia. Ed ecco che entra in scena Liretta. Nostra figlia aveva
visto l’annuncio «vendesi intera borgata», ma noi eravamo vincolati
affettivamente a un’altra vallata e non eravamo ancora pronti. Passato un anno
e maturata l’idea di realizzare concretamente qualcosa, ci siamo decisi a
vedere la borgata. Era il 2002, Liretta era abbandonata da 20 anni ed era in
totale rovina ma è bastato uno sguardo per capire che era quello che faceva per
noi. Nella vita bisogna saper trasferire i propri sogni in avanti, essere lungimiranti.
Ci fossimo fermati solo alle macerie che presentava Liretta, saremmo scappati
subito. In quel luogo e in quel primo incontro con la zona, noi abbiamo
avvertito il profumo della trasformazione».

Reinventarsi a 50
Quella di Liretta è stata una scelta meditata e
coraggiosa. Per far tutto questo Mario, dopo 29 anni di banca, ha deciso di
licenziarsi e di reinventarsi a 50 anni di età. Un progetto che, afferma la
coppia all’unisono, non avrebbero mai fatto con i bambini piccoli per non
vincolarli o fargli subire una scelta non loro.
Mentre Olga e Mario raccontano, noi sfogliamo un album
di fotografie che ci rimanda ai primissimi tempi di Liretta. Come è stato
possibile portare avanti questo progetto con così tanto impegno fisico e
pratico? «Abbiamo dato subito accoglienza, seppur nella semplicità. Le giovani
coppie potevano venire in giornata a fare la loro formazione prematrimoniale».
Riprende Olga: «È sorprendente verificare come ci si abitua a vivere con poco.
Nell’autunno avevamo già realizzato un piccolo bagno e potevamo vivere in una
cucinotta della casa che ora è adibita all’ospitalità. Sicuramente è stato un
inverno freddo fuori ma caldo dentro: nel cuore e nelle intenzioni».
Vita «tipica» in borgata
Liretta: «Noi viviamo qui, ci siamo sempre 24 ore su 24
per chi è in difficoltà. La nostra accoglienza si rivolge alle coppie prima e
dopo il matrimonio ma è capitato che ci chiedessero di ospitare qualche
situazione di disagio e, ovviamente, abbiamo aperto la nostra porta. Diamo
conforto, amicizia, ascolto, pranzi e cene pronte e un letto caldo. Coccolare
la coppia e farla sentire a casa è il nostro compito. Attenzione: ci
concentriamo sulla crescita personale della coppia, sull’offrirle uno spazio
esclusivo, perché sono il marito e la moglie che fanno fatica a mettersi in
discussione. Quando i figli crescono e prendono la loro strada, la coppia resta
e se non si è alimentato un rapporto profondo e autentico negli anni, tutto si
sfalda e ci si ritrova soli. Abbiamo anche una buona rete di professionisti
della coppia e, per approfondimenti specifici su coppie in crisi, non esitiamo
a consigliare un parere più professionale del nostro».
Numericamente, quante coppie ospita Liretta? «È
difficile fare una stima numerica per la continua evoluzione degli eventi,
abbiamo iniziato con poche coppie e oggi ne abbiamo otto per il cammino
pre-matrimoniale, altre 15 che seguiamo dopo il matrimonio e tutta
l’accoglienza quotidiana».
Seppur sotto una pioggia incessante, quello che spicca
in armonia con il verde circostante è una piccola cappella di pietra. La
domanda sorge spontanea: a Liretta occorre essere praticanti o l’accoglienza è
per tutti? A rispondere è Mario: «Noi abbiamo deciso di costruire la cappella
per poter praticare la nostra spiritualità ma non obblighiamo nessuno a vivere
della stessa fede: i nostri ospiti devono sentirsi “liberi”. Sono stati i
nostri figli e i loro amici ad aiutarci a creare una dimensione laica ed è
stata proprio questa forma liberale che ha poi favorito un riavvicinamento alla
spiritualità anche da parte di alcuni giovani, da tempo lontani dalla fede».
 Desbarasuma: la decrescita non teorizzata
Desbarasuma: la decrescita non teorizzataL’accoglienza di Olga e Mario è semplice ma generosa,
anche nella quantità del cibo. Ci chiediamo come facciano con le spese e Olga
ci chiarisce che in ogni camera c’è una busta per le offerte. Ognuno offre il
suo contributo e se non ne ha la possibilità non importa, può offrire un aiuto
pratico viste le continue necessità in borgata. Nel corso degli anni la coppia
sostiene però di aver sperimentato che spesso le persone con maggiori difficoltà
economiche offrono il massimo.
Per Maurizio Pallante (vedi articolo) la
decrescita è una vita in crescita. Crescita di valori, di pienezza di
esperienze, di tempo per dialogare. Prima di ritirarci nel nostro rifugio per
la notte, domandiamo ancora a Olga e Mario di parlarci del loro modo di vivere
secondo la chiave della decrescita. Ci rispondono quasi in coro: «Il denaro e
il successo non ci dava la felicità. La mera produzione per il consumo ci
avviliva. Per noi decrescere è trovare un “posto al sole”, in senso metaforico,
dove star bene e poter aiutare gli altri. Questo esserci per gli altri può
esistere solo se si è raggiunta una certa armonia con se stessi, un equilibrio
che nei ritmi frenetici e nella rete del consumismo fine a se stesso, non
avevamo trovato. Decrescita indica per noi una crescita interiore e di
attenzione verso l’altro. In termini pratici abbiamo una macchina sola che
usiamo il meno possibile per recarci a Cuneo, accumulando più impegni, cinque
galline per le uova, un orto per l’autoproduzione, il riscaldamento a legno con
il camino e la stufa, un pannello solare e un’accuratissima raccolta
differenziata su cui cerchiamo di sensibilizzare il più possibile i nostri
ospiti».
La mattina seguente esce uno spiraglio di luce e Liretta
è allo scoperto. Il belvedere apre una finestra naturale sulle montagne, ancora
leggermente innevate e dall’altura della borgata si intravedono i tetti di
Cuneo. Tutto è in armonia. Entriamo nella cappella dove una vetrata è in
perfetta simbiosi con la natura circostante; una piccola madonna bianca dalle
grandi mani ci guarda da una nicchia e tre piccole finestrelle dipinte indicano
una sorta di cammino verso l’ascensione. Una cura artistica si avverte ovunque,
nelle fioriere multicolore, nei dipinti creati da Olga per le piastrelle dei
bagni e nella gradevole stanza per i giochi dei bambini, realizzata
appositamente per gli ospiti «in erba».
Non possiamo che concludere la visita con uno sguardo più
intenso verso il logo: «Un tetto amico, una casa rotonda perché senza spigoli e
conflitti, tre sole finestre e nessuna porta. Perché a Liretta le porte sono
sempre aperte per chiunque ne abbia bisogno».
Esperienze 2/
Co-housing
per con-dividere
Per parlare con autenticità della decrescita, occorre
sfatare un mito: decrescere non significa andare a vivere in campagna e
isolarsi tra gli elfi boschivi. Quello che si evince dalle interviste di questo
dossier è che l’assioma decrescita-relazioni umane non si cura dello spazio ma
interviene sul cambiamento più profondo delle persone. Da qualche anno è attiva
un’associazione, Coabitare, che si occupa di fornire conoscenze, informazioni,
idee e strumenti a chi desidera abitare in modo differente e decide di farlo
non solo in ambito rurale. Per strappare qualche curiosità in più
sull’argomento siamo andati a visitare il co-housing
«numero zero» a Torino in via Cottolengo n°4. Un antico edificio ristrutturato
con tutti i crismi ecologici ed estetici dove, da gennaio 2013, vivono otto
nuclei familiari. Fioriere sui balconi e una piacevole galleria di biciclette
parcheggiate all’entrata ci accolgono.
A raccontarci la scelta di una co–abitazione solidale
sono Matteo Nobili, fisico e fotografo 36enne, e Chiara Mossetti, architetto
35enne. Vivere insieme ad altre persone: come nasce questa scelta e perché?
Matteo inizia il racconto: «Sicuramente occorre essere propensi
all’aggregazione. In un co-housing si
condividono pensieri, ideologie e “saper fare”, ma ognuno mantiene la
riservatezza del proprio alloggio. A noi interessava l’ambito urbano, sia per
le nostre occupazioni lavorative e sia perché non concepivamo l’idea di abitar
fuori e poi dover utilizzare la macchina quotidianamente con un’elevata
produzione di CO2. La scelta del centro città è anche e soprattutto per potersi
spostare liberamente in bicicletta o a piedi».
Mentre parliamo del progetto, in uno degli otto
appartamenti è in corso un simpatico pranzo comunitario. Oltre agli
appartamenti privati, il condominio ha a disposizione uno spazioso terrazzo, un
laboratorio, un soggiorno e un’ampia sala semi interrata. La domanda sorge
spontanea: come rientra la scelta di un co-housing
nella decrescita? «Innanzitutto nel ridurre gli sprechi. Questo è alla base
della scelta di una co-abitazione. Nel co-housing
«numero zero» ad esempio la scelta preponderante è stata quella di mantenere
una metratura medio-piccola (circa 70 mq) per tutte le abitazioni ma di
privilegiare l’ampiezza di alcuni spazi comuni». Ma, in pratica, come si
traduce quest’attenzione verso i consumi? «La fortuna è stata avere un
architetto e un ingegnere nel nostro gruppo che ci hanno permesso una
ristrutturazione “secondo natura” e dall’estrema funzionalità. Non a caso rientriamo
nei canoni della bio-edilizia e siamo in classe A. Sempre nell’ottica
ambientalista, siamo provvisti di pannelli solari per l’acqua calda, integrati
con una caldaia a condensazione e, in ogni appartamento, è presente il riscaldamento
a pavimento che diffonde il calore e non comporta inutili dispersioni. Possiamo
usare la metafora del dimezzare: noi siamo in otto nuclei famigliari con due
grosse lavatrici a disposizione per tutti e quattro automobili. Una sorta di car-sharing tra coinquilini!».
Sbirciamo con interesse gli interni delle abitazioni.
Seppure diverse per gusti e personalità, si contraddistinguono tutte per un
buon gusto comune. E le travi di legno dei soffitti aiutano ad armonizzare il
tutto. Nella fattispecie, le pareti di casa di Matteo e Chiara ricordano i
colori del Mali e, infatti, non sono altro che una miscela naturale di argilla,
sabbia e paglia. In co-housing «numero
zero» abitano persone dai 30 ai 60 anni e, come ci spiega Chiara: «Fare una
scelta simile non significa semplicemente farsi casa propria risparmiando un
po’ ma deve includere tanta voglia di scambiarsi competenze. Se ho bisogno di
un orlo ai pantaloni o di una buona ricetta in cucina, posso chiedere a Piera
(che ha qualche anno in più di noi), mentre noi possiamo facilitarle la vita
con i mezzi tecnologici o i lavori più pesanti. C’è uno scambio paritario di
talenti e di competenze ma non è tutto. Per viver bene occorre una buona dose
di socialità: il più delle volte chi arriva prima a casa la sera, prepara cena
per tutti in un’ottica di risparmio del tempo, quello liberato, e di
condivisione».
Ma il «bello» aiuta o è solo vanità? «Decrescere non
significa imbruttirsi, anzi. La bellezza aiuta a vivere meglio e a trovare
anche il giusto equilibrio in noi stessi e con gli altri». (G.M.)
Gabriella Mancini
.jpg)
.JPG)
.JPG)
.jpg)
.JPG)
 «Non cambierete mai niente lottando contro la realtà
«Non cambierete mai niente lottando contro la realtà

 Rimettere al centro l’essere umano, in armonia con la
Rimettere al centro l’essere umano, in armonia con la


 Desbarasuma: la decrescita non teorizzata
Desbarasuma: la decrescita non teorizzata



 Qual è il meccanismo che fa funzionare i Gas?
Qual è il meccanismo che fa funzionare i Gas?

 Il cardinal Lavigerie non fu il primo nella lotta allo
Il cardinal Lavigerie non fu il primo nella lotta allo Nato nel Sud Est della
Francia nel 1825, Charles Allemand Lavigerie fu un brillante studente nel
seminario maggiore e poi in quello dei Carmelitani a Parigi. Giovane prete,
diresse con entusiasmo straordinario l’Opera delle Scuole d’Oriente. Lavorò per
alcuni anni nella curia romana, finché venne nominato vescovo di Nancy nel
1863, all’età di 38 anni. Fu lì che, senza dubbio, maturò la sua vocazione
missionaria, e quando gli fu chiesto di assumere la responsabilità della
diocesi di Algeri nel 1867, accettò immediatamente.
Nato nel Sud Est della
Francia nel 1825, Charles Allemand Lavigerie fu un brillante studente nel
seminario maggiore e poi in quello dei Carmelitani a Parigi. Giovane prete,
diresse con entusiasmo straordinario l’Opera delle Scuole d’Oriente. Lavorò per
alcuni anni nella curia romana, finché venne nominato vescovo di Nancy nel
1863, all’età di 38 anni. Fu lì che, senza dubbio, maturò la sua vocazione
missionaria, e quando gli fu chiesto di assumere la responsabilità della
diocesi di Algeri nel 1867, accettò immediatamente.





 1825 - Nasce a Bayonne
1825 - Nasce a Bayonne