La nuova via Birmana – 2
Idee e progetti della «Signora»
Nell’autunno 2013 Aung San Suu Kyi ha concluso il suo tour europeo in Italia, da cui mancava da quarant’anni. L’abbiamo incontrata prima
della sua partenza per il rientro nel Myanmar. Nel 2015 sarà lei il nuovo presidente del paese?

Signora San Suu Kyi, può fare un bilancio del suo viaggio in Europa?
«Ogni viaggio porta con sé dei ricordi indelebili. Sono stata in paesi in cui non ero mai stata, come la Polonia, e in altri, come il vostro, da cui mancavo da decenni. Ho incontrato persone meravigliose, persone che per anni si sono prodigate affinché in Birmania tornasse la democrazia, e persone da profondi principi umani e spirituali».
Quando parla di uomini dai profondi principi umani e spirituali pensa a qualcuno in particolare?
«Sicuramente esistono persone che ti colpiscono per la gentilezza e la spiritualità che sprigionano con la loro voce, il loro sguardo, le loro parole. Il papa, ad esempio, mi ha colpito molto. Con lui mi sono trovata subito in sintonia, in particolare sulla necessità di valorizzare sentimenti come amore e comprensione per fugare le paure che dividono i popoli. Purtroppo non abbiamo avuto molto tempo per approfondire la conversazione, ma gli argomenti toccati, il suo acume e la sua semplicità mi sono rimasti impressi. È una persona con cui mi sono sentita immediatamente in sintonia. Mi piacerebbe incontrarlo ancora».
Lei ha ricevuto tantissime promesse durante la sua visita, specialmente dai parlamentari. Penso sappia che i politici italiani non hanno la fama di mantenere le promesse fatte e l’Italia ha brillato più per la sua assenza piuttosto che per la sua presenza nelle vicende asiatiche. Non vorrei essere pessimista, ma pensa che una volta tornata in Myanmar ci si ricorderà del suo paese nel parlamento italiano?
«Spero vivamente di sì. L’Italia ha appoggiato con forza il movimento democratico e numerose personalità del mondo dello spettacolo, della cultura, della politica si sono esposte in primo piano nella difesa dei diritti umani in Birmania».
A proposito di diritti umani: a che punto siamo nel processo di pacificazione con i gruppi etnici?
«Ci sono alti e bassi: il governo insiste affinché sia il parlamento a discutere la questione etnica. In effetti ci sono diversi membri che rappresentano le etnie nel nostro parlamento ed è per questo che, in questa sede, il dialogo sta già avvenendo. Da parte loro, i gruppi etnici chiedono che la questione sia discussa al di fuori del parlamento e con terze parti che facciano da garanti. Ciò che è venuto a mancare durante gli anni della dittatura militare è la capacità del dialogo e del compromesso. Nessuno vuole cedere sulle sue richieste e questo porta inevitabilmente a uno stallo dei negoziati».
È ciò che sta avvenendo anche nello stato Rakhine tra musulmani e buddisti?
«In un certo senso sì, anche se lì non direi che si tratti di un conflitto etnico. È un contrasto completamente differente da quello in atto nelle altre parti del paese, alimentato da un senso di terrore che serpeggia in entrambe le comunità».
La paura è, quindi, secondo lei, una delle ragioni per cui nello stato Rakhine la comunità buddista e quella Rohingya musulmana si stanno fronteggiando violentemente. Nega, quindi, che vi siano ragioni più profonde nel conflitto etnico-religioso?
«Prima di tutto vorrei specificare che non siamo di fronte ad un conflitto etnico».
Su questo, organizzazioni che si occupano di diritti umani e di sviluppo umanitario non sono assolutamente d’accordo con lei e l’hanno anche duramente criticata.
«Ribadisco che è la paura la causa delle violenze in atto tra buddisti e musulmani e non la differenza etnica. La comunità internazionale punta il dito accusatore solo verso i buddisti, ma anche loro hanno subito violenze. Ci sono migliaia di buddisti che sono dovuti fuggire durante il regime militare e ancora oggi vivono in campi profughi».
Associazioni e movimenti che si occupano della questione all’interno dello stato Rakhine l’hanno accusata di non voler difendere i diritti della comunità islamica per un puro calcolo elettorale in vista delle elezioni presidenziali del 2015.
«Posso rispondere dicendo anch’io che le loro accuse sono un’assurdità. Io e il mio partito, la Lega Nazionale per la Democrazia, abbiamo sempre sostenuto che il governo avrebbe dovuto controllare e far rispettare il confine tra Birmania e Bangladesh. Per anni nessuno se n’è occupato con il risultato che migliaia d’immigrati clandestini oggi sono in territorio birmano. La radice del problema è tutta qui, oltre al fatto che in Birmania c’è la paura che elementi estei possano destabilizzare il paese».
È, però, un dato di fatto che vi sono movimenti buddisti, come il Movimento 969, che istigano alla xenofobia, se non addirittura alla violenza.
«Io condanno ogni tipo di violenza, ma se vuole che condanni solo la violenza dei buddisti contro i musulmani, allora non lo farò. Condannare una sola comunità serve solo a istigare altra violenza e se le mie parole fossero fraintese chi ne farebbe le spese sarebbe il popolo, non io che le ho pronunciate».
Qual è, quindi, la soluzione che propone?
«Il primo punto del mio programma politico è far rispettare le regole. In Birmania, come in altri paesi del mondo, si ha la percezione e la paura che vi sia un potere musulmano globale che possa destabilizzare i paesi in cui questo potere si insinua. Ciò significa che il problema di cui stiamo discutendo non è solo un problema birmano, ma internazionale. Lei mi chiede quale soluzione propongo. È semplice: io la chiamo rispetto della legge e della giustizia. Io e il mio partito, la Lega Nazionale per la Democrazia, abbiamo sempre sostenuto che il governo avrebbe dovuto controllare e far rispettare il confine tra Birmania e Bangladesh. Per decenni i regimi militari birmani non hanno controllato il confine con il Bangladesh lasciando che questo diventasse estremamente poroso e permettendo a migliaia di persone di entrare illegalmente in Birmania. Ora, io chiedo che si rispetti la legge di cittadinanza: chi ha la facoltà di diventare cittadino birmano, deve far valere questo diritto. Il governo, da parte sua, deve porre fine a questa immigrazione illegale e garantire la cittadinanza a chi ne ha diritto».
Lei sa bene che è difficile dimostrare, per chi non ha documenti, che risiede in Birmania da più generazioni. Inoltre il governo non riconosce a priori i Rohingya come gruppo etnico, ma li considera bengalesi, quindi cittadini del Bangladesh. Come vede, è una strada a vicolo chiuso.
«È per questo che chiediamo che ci sia un confronto non solo all’interno della Birmania, ma anche con il Bangladesh».
I discorsi enunciati in questo tour sono tutti focalizzati alla necessità di emendare la costituzione del 2008 che vieta a cittadini come lei, che ha parenti con passaporto straniero, di candidarsi alle presidenziali del 2015. Non pensa che ci siano punti ben più importanti da emendare, come il 25% dei seggi riservati ai militari nel parlamento o come la possibilità che il comandante delle Forze Armate possa, in caso di necessità, prendere il comando del governo?
«Sì e no. Per la percentuale dei seggi riservati ai militari non penso che sia un problema. Ho sempre detto che i militari devono essere inseriti nel contesto esecutivo e legislativo del paese. Nei limiti di una democrazia, naturalmente. Non mi preoccupa il 25% dei seggi riservati ai militari nel parlamento quanto, piuttosto, il pericolo che il comandante delle Forze Armate possa arrogarsi il diritto di amministrare l’intero governo; ebbene, quello, invece, è sicuramente un punto di pericolo che rischia di arrestare le riforme. Così come la mancanza di un potere giudiziario indipendente dal potere legislativo ed esecutivo. Capisco anche che la mia insistenza sull’emendamento per la candidatura presidenziale possa essere intesa come una battaglia personale. Ma non sono io che l’ho iniziata: è stata la precedente giunta militare che ha disegnato una costituzione nazionale prendendo come misura la necessità di allontanare la mia persona da ogni forma di governo. Io mi batto non per la mia candidatura, ma perché il popolo abbia il diritto costituzionale di scegliere liberamente la persona che andrà a rappresentarlo.
Mi permetta anche di evidenziare che l’emendamento della costituzione è solo il terzo punto del mio programma dopo il rispetto delle leggi e la fine delle guerre civili. Sono una politica e come tale ho degli obiettivi. Uno di questi è dare al mio popolo la democrazia. Questo è il senso dell’emendamento da me richiesto: permettere al popolo di decidere chi lo rappresenta».
Quale sarà il suo programma nel caso possa candidarsi?
«Non voglio fare promesse che non posso mantenere. Non voglio dire che, se diverrò presidente, il mio partito, la Lega Nazionale per la Democrazia (Lnd), porterà pace e benessere per tutti. Abbiamo sempre detto che faremo del nostro meglio e ciò che prometto è esattamente il meglio che posso offrire. I tre punti principali del mio programma sono tre: far rispettare le leggi, porre fine alle guerre civili ed emendare la Costituzione».
Il secondo punto sarà sicuramente il più impegnativo. Neppure il cosiddetto governo democratico che ha retto la Birmania tra il 1947 e il 1962 è riuscito a porre termine alle guerre etniche.
«Il grosso problema è che i regimi militari ci hanno fatto perdere la capacità di dialogare e di mediare. Sotto lo Slorc (State Law and Order Restoration Council, ndr) prima e l’Spdc (State Peace and Development Council, ndr) dopo, non c’è mai stata libertà di parola o di scelta. Tutto veniva imposto dall’alto, anzi, direi da una ristretta cerchia di persone. Oggi, con le riforme in atto, dobbiamo riacquistare la capacità di dialogare. Ma questo significa anche sapere che non si potrà mai ottenere il 100% di ciò che si chiede».
Le riforme in atto dal 2010 hanno già portato a notevoli cambiamenti in Myanmar. Oggi ci sono meno di 100 prigionieri politici nelle prigioni birmane, quando solo tre anni fa erano più di 2.000. Secondo lei c’è ancora la possibilità che i militari possano riprendere il potere e arrestare il processo democratico?
«Certamente. È per questo che ho chiesto anche all’Italia di appoggiarci nella strada verso la democrazia. Penso che vi siano frange all’interno del Tatmadaw (le Forze armate, ndr) che si oppongono alle riforme».
Chi potrebbe essere un partner fidato in questa transizione democratica? La Cina, gli Stati Uniti, l’India, l’Asean?
«La Birmania ha sempre avuto rapporti molto stretti ed amichevoli con la Cina e, personalmente, vedo gli investimenti cinesi come un’opportunità per il mio paese. Naturalmente, come ho sempre detto, bisogna che siano investimenti non finalizzati a esclusivo vantaggio di un solo paese o di una classe sociale. Penso sia questa la sfida che andremo ad affrontare nel futuro».
Lei, sin dal primo comizio tenuto alla Shwedagon nel 1988 (a cui io ero presente), ha sempre dichiarato di avere un immenso affetto per i militari, sostenendo che è indispensabile che il Tatmadaw entri a far parte della vita sociale della nazione. Queste sue dichiarazioni, ripetute oggi, sconvolgono non poche persone che l’hanno sostenuta. Sono loro che non hanno capito nulla delle sue idee o è lei che ha cambiato le idee?
«Direi che siamo più vicini alla prima risposta. Sono sempre stata convinta che i militari devono lavorare stretto contatto con la legislatura e l’esecutivo. Io ho sempre avuto un sentimento particolare per i militari e chi si scandalizza quando mi sente dire questo, rispondo che non ha capito nulla del mio pensiero. Non ho mai cambiato idee nei confronti dei militari e anch’io mi stupisco di come molta gente inorridisca quando affermo di avere grande affetto per loro. Ma dico semplicemente ciò che ho sempre detto da 25 anni a questa parte. Lo ripeto, ho sempre avuto molto rispetto per chi indossa una divisa. Tranne, ovviamente, per alcune persone. Ma sono un’esigua minoranza».
Piergiorgio Pescali
.JPG)
.JPG)
.JPG)




.JPG)
 Nei primi anni dopo l’indipendenza, l’Eplf si trasforma
Nei primi anni dopo l’indipendenza, l’Eplf si trasforma

 L’associazione parte con due motivazioni: portare avanti
L’associazione parte con due motivazioni: portare avanti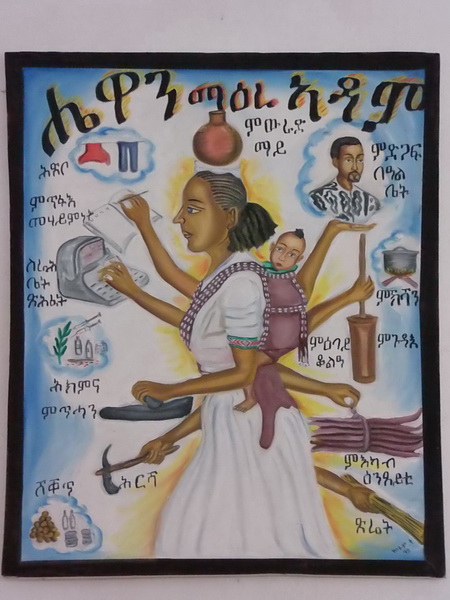 A Keren le suore cappuccine stavano aprendo in quel
A Keren le suore cappuccine stavano aprendo in quel













 Lo contattiamo via
telefono mentre viaggia in treno per raggiungere una scuola superiore in
Liguria. Da quando si è dimesso dalla magistratura, Gherardo Colombo spende
molte delle sue energie e giornate parlando con giovani e ragazzi di tutta
Italia di «regole»1, di cittadinanza responsabile. Ogni tanto
la voce cordiale che ci parla sparisce nelle gallerie insieme alla linea
telefonica. Ma il messaggio è chiaro: non si può educare al bene attraverso il
male. È necessario trovare una strada alternativa alla punizione e alle pene
tradizionali, perché queste, la carcerazione in primis, in molti casi non
sono condivisibili sul piano ideale e non sono efficaci sul piano pratico.
Lo contattiamo via
telefono mentre viaggia in treno per raggiungere una scuola superiore in
Liguria. Da quando si è dimesso dalla magistratura, Gherardo Colombo spende
molte delle sue energie e giornate parlando con giovani e ragazzi di tutta
Italia di «regole»1, di cittadinanza responsabile. Ogni tanto
la voce cordiale che ci parla sparisce nelle gallerie insieme alla linea
telefonica. Ma il messaggio è chiaro: non si può educare al bene attraverso il
male. È necessario trovare una strada alternativa alla punizione e alle pene
tradizionali, perché queste, la carcerazione in primis, in molti casi non
sono condivisibili sul piano ideale e non sono efficaci sul piano pratico. Il perdono responsabile
Il perdono responsabile

 Il perdono responsabile
Il perdono responsabile

 Sudafrica: la verità è più importante della pena
Sudafrica: la verità è più importante della pena
 Nato a Bra nel 1942,
Nato a Bra nel 1942,
