Senza la poesia di Chagall
 Ai confini dell’Europa (4): la Bielorussia
Ai confini dell’Europa (4): la Bielorussia
solo presidente: Aljaksandr Lukašenka, da molti considerato «l’ultimo dittatore
d’Europa». L’economia del paese si sostiene grazie a un forte intervento
statale e ai rubli di Mosca. Alla quale Minks guarda con deferenza.
.jpg) Marat fa
Marat fa
l’archeologo. O qualcosa del genere. Scava buche quadrate in campi di grano a
perdita d’occhio. Scava un quadrato di quattro metri di lato per 20 centimetri
di profondità, poi passa a un quadrato a fianco. Quando tutti i quadrati sono
allo stesso livello ricomincia dal primo scendendo di altri 20 centimetri. La
terra è nera come la pece, e morbida. Non è un lavoro poi così duro. Marat
scava le sue buche nella speranza di trovare qualche reperto che provi la
presenza di popolazioni stanziali in questa regione già nell’età del bronzo.
Non è una cosa da poco, perché dimostrerebbe che la civiltà bielorussa è antica
almeno quanto quella baltica. Marat e i suoi studenti volontari scavano già da
un paio di settimane, ma tutto quello che hanno trovato è un chiodo
arrugginito, difficilmente appartenente all’età del bronzo.
Marat ha meno di trent’anni. Insegna all’università a
Minsk, ma il suo campo archeologico è in un villaggio a nord, quasi al confine
con la Russia. Vive con 150 euro al mese e sogna città sepolte. «I professori
universitari guadagnano meno di tutti in Bielorussia», dice. «Sembra che di noi
qui non abbia più bisogno nessuno. Valgo meno di un cellulare o un computer».
Si infervora quando descrive ai suoi studenti la versione sovietica
dell’evoluzionismo (una teoria pseudoscientifica che rigetta il darwinismo) e
alla sera alza un po’ il gomito. Ecco, Marat è un po’ come il paese in cui
vive. Giovane e squattrinato, e costretto in un isolamento culturale che non è
mai venuto meno dalla caduta dell’impero sovietico. La Bielorussia guarda al
futuro, ma nello stesso tempo è appesantita dalla forza gravitazionale di un
passato di cui non si è mai del tutto liberata.
Lukašenko, padre e
padrone
La Bielorussia indipendente ha una storia di poco più di
vent’anni. Nata col crollo dell’Unione Sovietica non si è però mai distinta, a
differenza dei vicini paesi baltici, per una particolare voglia di indipendenza
da Mosca. Le ragioni sono molteplici e sicuramente legate alla vicinanza
storico culturale tra il popolo bielorusso e quello russo. Ma determinante è
stata la guida autoritaria assunta dal suo primo e tuttora unico presidente,
Aljaksandr Lukašenka (Aleksandr Lukašenko, nella traslitterazione dal russo)
che ha sin da subito impedito un’apertura della società civile all’Occidente.
Bene o male che sia, sembra che un torpore lungo due decenni affligga la
Bielorussia castrandone gran parte delle potenzialità.
Il regime di Lukašenka, che ama farsi chiamare batka, padre, ha
annullato sin da subito ogni opposizione politica, ridotto a zero la libertà di
stampa e soppresso sul nascere con la forza qualunque contestazione al suo
potere. Tutto in Bielorussia è accentrato nelle sue mani. Nonostante l’immagine
di uomo semplice e del popolo, a cui tiene tanto, è – secondo molte fonti –
l’uomo più ricco del paese. Un cablogramma dell’ambasciata americana a Minsk,
diffuso da Wikileaks, stima il suo patrimonio in 9 miliardi di dollari.
Covoni di paglia, boschi, isbe dai comignoli sbilenchi,
vacche per strada. Sono i paesaggi dipinti da Chagall, che proprio in questa
regione nacque e trascorse la sua infanzia. Paesaggi in cui gli amanti volano
tenendosi per mano e i violinisti suonano sui tetti. Ma non c’è più niente di
poetico, ora qui. Il villaggio dove scava Marat è a un tiro di schioppo da
Navapolatsk. Navapolatsk è una città artificiale. Fu fondata nel 1958 per dare
alloggio alle migliaia di lavoratori della raffineria che stava sorgendo tra i
campi di grano. Nata in un battibaleno grazie ai prefabbricati dell’edilizia
sovietica che si tiravano su come i Lego, oggi è una città di quasi 100mila
abitanti con ospedali, università e teatri. Ma la Naftan, il complesso
industriale che dà da vivere ai suoi abitanti, è persino più grande. Oltre alla
raffineria comprende una centrale elettrica e diversi stabilimenti dove
lavorano migliaia di persone. Come tutte le industrie bielorusse, la Naftan è
di proprietà dello stato. Così come la stragrande maggioranza delle terre
coltivate (secondo alcune fonti, oltre il 90%), ancora organizzata secondo un
sistema di collettivizzazione che non è cambiato dai tempi dell’Urss. Lo stato
in Bielorussia è tutto, e lo stato è batka.
Lukašenka è spesso definito l’ultimo dittatore d’Europa.
Alle ultime elezioni presidenziali del 2010 l’80% dei votanti ha scritto il suo
nome sulla scheda, relegando a un misero 2% il secondo candidato più votato,
Andrej Sannikov. L’esperienza è costata a Sannikov un anno di prigione, prima
di ricevere la grazia da Lukašenka. Ad ogni modo, batka può affrontare
serenamente le prossime elezioni del 2015 perché, anche se Sannikov è libero,
numerosi altri esponenti dell’opposizione riempiono le galere bielorusse. Le
elezioni che lo hanno confermato al potere per la quarta volta consecutiva, non
diversamente dalle precedenti, sono state giudicate dall’Osce lontane dagli
standard inteazionali. Per questo motivo, per aver azzerato l’opposizione
politica e per presunte gravi violazioni dei diritti umani, la Bielorussia di
Lukašenka è andata incontro alle sanzioni dell’Europa, che hanno colpito il
sistema di potere del presidente.
Un’economia di
miracoli e misteri
Un pulmino della Naftan porta Marat e i suoi studenti in
città per il giorno libero. È sgangherato e dimostra più anni di quelli che ha.
Forse è perché anche la Naftan è entrata nella lista delle sanzioni europee per
gli stretti legami con Lukašenka. Si va alla banja, la sauna russa.
Anche la banja è della Naftan, come gran parte delle strutture
ricreative di Navapolatsk. Potrebbe sembrare claustrofobica una città che vive
in funzione di uno stabilimento e in cui quasi tutto appartiene alla fabbrica, «ma
almeno qui tutti hanno un lavoro», dice Marat. È uno dei «miracoli» di batka, un tasso di
disoccupazione ufficiale che non arriva all’1%. Ma sono in molti, compresi
oppositori e critici al governo, a ritenere che la cifra reale sia molto più
alta. Comunque, andando in giro per il paese, la sensazione è quella di un
elevatissimo tasso di occupazione, soprattutto tra i giovani che, non appena
finiscono gli studi, ricevono spesso offerte di lavoro da enti pubblici. Lungi
dall’essere sintomo di una situazione florida, questa condizione è piuttosto
l’effetto di salari tra i più bassi d’Europa e di un’economia drogata, per
certi versi pianificata, che non si è mai realmente aperta al mercato. La
Bielorussia è, insieme al Kazakistan, parte della neonata «Unione economica
eurasiatica», guidata da Mosca. Dalla Russia Minsk dipende per un terzo delle
proprie esportazioni, per la metà degli investimenti esteri e per il 99% di
foiture di gas a un prezzo pari a quello praticato da Gazprom nel mercato
interno. Praticamente un regalo. Senza i rubli di Mosca, che oltre a finanziare
di fatto il mercato bielorusso ha recentemente iniettato liquidità per un
valore stimato in 3 miliardi di dollari sotto forma di prestito, il paese
guidato con pugno duro da Lukašenka rischierebbe il default.
In cambio, Lukašenka è da sempre il più fedele alleato di
Putin. Il primo a intravedere una forma di riunificazione con la Russia, il più
volenteroso a concedere suolo per le basi militari di Mosca, il più solerte a
favorire un’exit strategy dalla crisi in Ucraina offrendosi come mediatore tra il
Cremlino, Kiev e i separatisti del Donbass. E anche se, recentemente, ha fatto
un po’ la voce grossa con il suo mentore, criticando l’annessione della Crimea
e rifiutandosi di riconoscere l’autonomia delle regioni separatiste nell’Est
dell’Ucraina, il totale appiattimento sulla politica russa non è mai stato
messo in discussione.
Dopo le pianure, ecco
Minsk
L’autostrada che attraversa il paese da est a ovest è
noiosa come un mare in calma piatta. Pianure, pianure, pianure. E poi, dopo
ore, c’è Minsk. La capitale si staglia come una cattedrale sull’orizzonte
bielorusso. Una cattedrale laica fatta di asfalto e semafori. Minsk non è come
te l’aspetti. Non è come qualsiasi altra grande città ex sovietica a cui i
soldi hanno cambiato il volto: colori, insegne luminose, cartelloni
pubblicitari. Non è, per intenderci, una piccola Mosca. È piuttosto una
versione rimodeata di quella che è stata per decenni, dopo essere risorta
dalle macerie della Seconda guerra mondiale, la capitale della repubblica
socialista sovietica di Bielorussia. Edifici magniloquenti, larghi viali tesi
come rette, piazze d’armi.
Le insegne al neon ci sono, ma sono perlopiù stelle rosse
o medaglie al valore militare. I cartelloni pubblicitari inneggiano alla gloria
della patria e gli striscioni alla vittoria della Grande guerra patriottica
contro il nazifascismo. Lenin è lì, saldamente al suo posto e l’emblema
nazionale, presente su edifici pubblici e non, non è altro che lo stemma
sovietico cui è stata aggiunta la sagoma dei confini nazionali. E poi di tanto
in tanto sorge un edificio in vetro e cemento, tra il kitsch e il postmoderno,
come la biblioteca nazionale, un dodecarnedro ricoperto di led colorati che di
notte s’illumina come la cassarmonica alla festa di San Rocco. E ancora
scheletri di edifici nascosti dalle gru e progetti riprodotti in gigantografie
che danno a Minsk l’immagine di una città rampante e in evoluzione. E forse lo è.
Super ricchi, ma non
oligarchi
Il fatto che il News Café sia su via Karl Marx non
sembra impensierire nessuno dei suoi clienti. È quel tipo di locale che si
definisce esclusivo solo perché per entrare bisogna avere il portafogli ben
ripieno. Tutti gli altri sono esclusi. Un uomo in abito scuro e occhiali da
sole, seduto all’interno del locale, scherza con due ragazze belle come delle
veline. Loro lo adulano e ridono alle sue battute, e forse non è solo merito
della bottiglia di Moët & Chandon nel secchiello. Se un insegnante come Marat guadagna 150
euro al mese qui a Minsk c’è una sparuta ma solida élite che ne guadagna
150mila o forse più. La cosa non sarebbe né strana né di per sé disdicevole – e
anche comune a tutte le grandi città dell’ex Urss – se non fosse per il fatto
che gran parte della ricchezza è in mani pubbliche e che Lukašenka ha sempre
fatto della lotta ai super ricchi una sua bandiera. In questo la Bielorussia
non fa alcuna differenza con altri stati post sovietici come la Russia stessa o
l’Ucraina. Benché, però, una cerchia di miliardari ruoti attorno al capo del
paese, non si può propriamente parlare di oligarchi. Gli oligarchi russi e
ucraini hanno soldi e potere, i super ricchi bielorussi hanno tanti soldi, ma
il potere è saldo nelle mani di batka.
Davanti al palazzo del presidente, sotto un Lenin che non
sembra particolarmente a disagio, sorge uno dei più grandi centri commerciali
sotterranei d’Europa. Con tre piani di negozi e ristoranti lo Stolitsa shopping mall è
il posto più amato dai consumatori compulsivi di Minsk. Ma è un posto a modo
suo democratico, perché non ti chiede un rublo per ammirare le sue vetrine, i
suoi pavimenti di marmo, i suoi ascensori di vetro e i suoi bagni con la musica
di sottofondo. Tre piani più sopra, in superficie, la vita vera scorre sotto
forma di un ingorgo di macchine e anziane signore che gettano molliche di pane
ai colombi, come a ricordare che ci sono due città e due mondi, uno sotterraneo
e uno che si sforza di vivere ogni giorno alla luce del sole.
Non sono solo un paio di palazzi stravaganti e qualche
grattacielo a fare della Bielorussia un paese che guarda al futuro. Nonostante
tutto, nonostante la profonda crisi, un’economia rigida e poco competitiva, gli
ostacoli posti all’impresa privata e l’arretratezza dell’industria, c’è una
Bielorussia tecnologica che cerca di venire fuori come un germoglio
dall’asfalto. Non lontano dal dodecarnedro luminescente della biblioteca sorge un
complesso molto più sobrio ma decisamente più all’avanguardia. Il Belarus Hi-Tech Park ambisce
a essere una specie di Silicon Valley bielorussa, un incubatore di giovani menti informatiche
che lì hanno la possibilità di sviluppare le proprie idee. Qualcosa come 140
imprese ad alto contenuto tecnologico sfoano software e servizi informatici
per clienti sparsi in 50 paesi. E attirano persino soldi dall’estero. Il merito
del Belarus Hi-Tech
Park non è solo di un guizzo di lungimiranza dei
consiglieri di Lukašenka, ma anche e soprattutto di una generazione di giovani
che assorbe il meglio di un sistema d’istruzione (con molte pecche) e che si dà
da fare per essere al passo con i coetanei dei paesi più avanzati.
Visto da qui, il mondo di Marat sembra lontano anni luce,
e forse lui lo sa. Per questo alla sera, quando alza un po’ il gomito, va fuori
sotto un cielo stellato e lancia il suo grido ai satelliti artificiali: «Sputnik!».
Danili Elia
 Storie e volti di radio / 4
Storie e volti di radio / 4.jpg)
 Il ricordo emozionato di un uomo che realizzava i suoi sogni
Il ricordo emozionato di un uomo che realizzava i suoi sogni.jpg)
.jpg) Tra fiori e un tocco di pili pili
Tra fiori e un tocco di pili pili.jpg)
 Giornata per le comunicazioni sociali 2014
Giornata per le comunicazioni sociali 2014
 Dialogo continuo, online
Dialogo continuo, online






 Incontro con il capo supremo del Vodù
Incontro con il capo supremo del Vodù  Un cartello segnala casa sua, il Péristyle de Mariani, ovvero il
Un cartello segnala casa sua, il Péristyle de Mariani, ovvero il












 Reportage «faticoso»
Reportage «faticoso» L’espansionismo cinese
L’espansionismo cinese




 Viaggio in Cile / 2
Viaggio in Cile / 2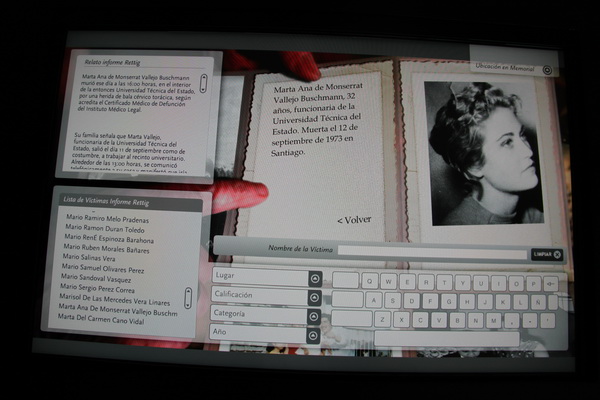



 Mons. Infanti, sul web si legge che HidroAysén – il consorzio tra
Mons. Infanti, sul web si legge che HidroAysén – il consorzio tra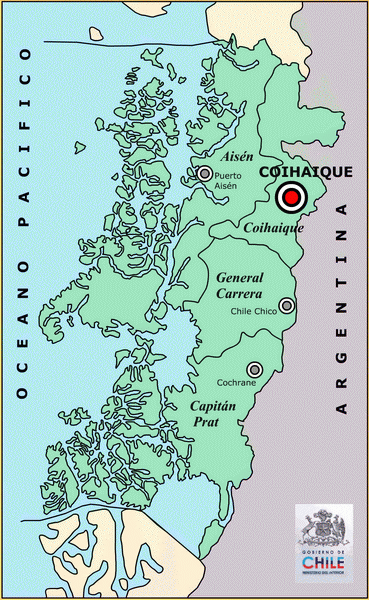 Il programma di governo di Michelle Bachelet parla – alla pagina 126 –
Il programma di governo di Michelle Bachelet parla – alla pagina 126 – Una parte della Chiesa cattolica e della gerarchia in particolare ha
Una parte della Chiesa cattolica e della gerarchia in particolare ha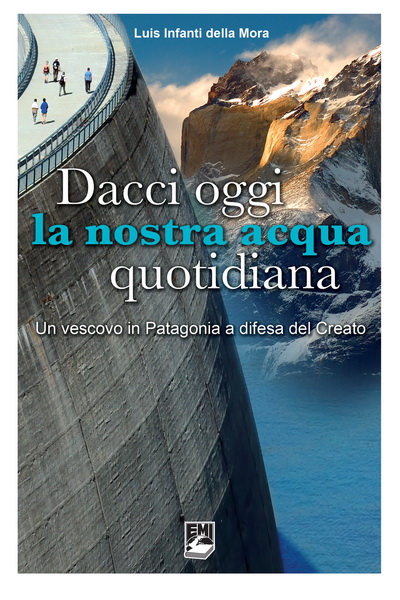 Siti web:
Siti web:
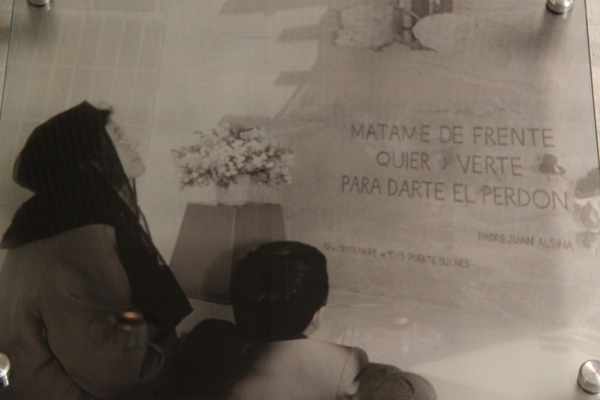
 Celebrare cent’anni di chiesa locale e un nuovo vescovo.
Celebrare cent’anni di chiesa locale e un nuovo vescovo.  La
La








