Purus: Senza uscita
 Ucayali, Purús / costruire una strada nella
Ucayali, Purús / costruire una strada nella
foresta?
La possibile costruzione di una strada di
270 chilometri in mezzo alla foresta amazzonica della provincia peruviana di
Purús accende le discussioni e le polemiche. Ospitiamo le opinioni di padre
Miguel Piovesan e di monsignor Francisco González Heández, favorevoli alla
realizzazione dell’opera.
Puerto Esperanza. Esiste
una zona del Perú – la provincia di Purús – che è geograficamente isolata. Non
si può accedere se non per via aerea. Una via aerea sporadica e incerta. E
anche discriminante dato che pochi privilegiati possono permettersi di
affrontae l’altissimo costo.
L’isolamento geografico ha impedito lo sviluppo degli
abitanti della zona, in maggioranza indigeni (vedere box). L’isolamento
geografico di Purús ha determinato anche un isolamento sociale, mentale,
tecnologico con conseguenze di sfruttamento da parte di «usurpatori» e
conquistatori di tuo. Nel 2004 forze schierate dietro una ecologia finta e
manovrata hanno creato un parco – Parque Nacional Alto Purús – che ha
circondato e rinchiuso la provincia in maniera assurda e vergognosa impedendo
lo sviluppo e la comunicazione di questi gruppi etnici con il resto della
nazione e dell’umanità.
La chiesa cattolica – io sono parroco della parrocchia
di Santa Rosa del ![]() Purús a Puerto Esperanza – ha sempre cercato di denunciare
Purús a Puerto Esperanza – ha sempre cercato di denunciare
questi soprusi, gli inganni e la diffusione di notizie false come la questione
degli «indios isolati volontariamente» che serve alle Ong multinazionali per
farsi una pubblicità funzionale ai loro scopi.
Fintanto che si presentano come i protettori di queste
popolazioni «in isolamento volontario» hanno sempre molti soci che sostengono
il loro ritornello. Avendo tutti i mezzi di comunicazione a disposizione le Ong
sono riuscite a propagare un’immagine irreale sia degli indigeni che utilizzano
al soldo, che di quelli impegnati a difendere i diritti umani, il progresso e
la dignità di ogni essere vivente.
I vescovi del posto – mons. Larrañeta, mons. Francisco
González Heández, oltre al vicario episcopale padre Ignacio Iraizoz – hanno sempre sostenuto, senza paura, che
tutti sono figli dello stesso Padre e hanno gli stessi diritti di evoluzione e
accesso a tutte le opportunità. Qui di seguito si può leggere il pensiero di
mons. Francisco González Heández, vicario apostolico di Puerto Maldonado (a
cui la mia parrocchia appartiene). Le sue parole fanno capire, a chi vuole
capire, l’influenza di gruppi e associazioni «mascherati di ecologia».
padre
Miguel Piovesan,
parroco di S. Rosa del Purús, Puerto Esperanza, Purús, Ucayali, Perú

Il Vicario Apostolico di Puerto Maldonado
Risulta triste dover ammettere che la situazione della
vita e delle genti del Purús non è cambiata per niente rispetto alla secolare
prostrazione. Fin dall’epoca del caucciù e prima e dopo e adesso, continuano a
succedersi aggressioni di diversi soggetti contro la vita, la dignità, la
libertà e i diritti dei diversi popoli indigeni che abitano la provincia.
La maggior parte di chi è arrivato nel Purús non è
arrivata per dare, condividere, insegnare, imparare o liberare. Costoro sono
arrivati per usurpare, schiavizzare, scommettere, sfruttare, imporre.
Davanti a questa aggressione poco hanno potuto fare ieri
e poco possono fare oggi, alcuni fratelli indigeni che sono stati privati e si
continuano a privare del diritto ad avere una formazione, delle conoscenze, una
professione che li renda capaci di vedere, giudicare e attuare secondo criteri
propri, indipendenti e liberi. Prima sono stati i signori del caucciù che li
hanno schiavizzati, poi sono venuti altri sfruttatori, oggi a ingannarli sono
gli «assessori», i «tutori ecologici».
Con l’adulazione e varie regalie, i padroni sceglievano
alcuni indigeni perché fossero gli esecutori della schiavitù tra i loro popoli.
Li sceglievano tra i più ambiziosi o crudeli perché agissero con ferocia contro
i loro stessi fratelli. In cambio questi padroni ricevevano un trattamento
particolare e proprietà come se fossero dei colonizzatori.
Oggi, assessori travestiti da ecologisti, sociologi, antropologi,
scelgono tra gli stessi indigeni i rappresentanti di varie Federazioni, li
promuovono a cariche pubbliche e fanno loro credere che la loro consulenza è
assolutamente imprescindibile per proteggere i popoli indigeni dai tanti nemici
(immaginari) che sono pronti ad andare nel Purús (per quale via?) per
sterminarli.
Se i trafficanti del caucciù soddisfacevano la loro
avarizia strappando il lattice all’albero della gomma, se i padroni cercavano
la ricchezza nello sfruttamento della terra, del legno, delle pelli di animali,
oggi gli ecologisti delle «multinazionali ambientaliste» semplicemente si
appropriano delle terre del Purús. Le fanno diventare «i giardini privati del
Primo Mondo», sebbene le chiamino Parchi nazionali, Riserve, Zone intangibili.
Alla fine – e mi riferisco solamente e puramente al Purús – costoro si sono
convertiti nei nuovi «padroni». Loro stabiliscono ciò che si deve e ciò che non
si deve fare nel «loro giardino». Agli indigeni, che sono i padroni naturali,
un giorno diranno che ormai non è possibile né pescare, né cacciare, né far uso
del legno, né camminare come e dove si vuole.

Ad alcuni indigeni daranno una credenziale nominandoli «guardaboschi»
e assegnando loro un piccolo salario la cui quantità sarà molto lontana dal
salario primomondialista che starà ingrossando il conto bancario di ecologisti,
sociologi, antropologi, assessori nelle banche di Pucallpa o meglio di Lima o
di qualsiasi altra città europea o nordamericana.
Mi
spaventa rileggere quello che ho scritto fino adesso, soprattutto pensando ad
altri amici e fratelli, a ecologisti, antropologi, sociologi onesti e
impegnati. Per questo voglio chiarire che tutto quello che dico lo applico alla
provincia del Purús, ingiustamente maltrattata. Là dove il tempo sembra essersi
fermato, dove gli unici a poter vivere sono
malandrini e truffatori e dove si offre l’unica esperienza di un Parco
giurassico, dove si condanna l’uomo a vivere isolato, impoverito, privato dei
suoi diritti a una educazione vera, a un lavoro degno e retribuito, a una
salute accessibile, ad uno sviluppo che, partendo dalla sua propria cultura,
gli permetta di vivere come un cittadino del Perú e del Mondo in questo terzo
millennio.
È in tutto questo intreccio che si collocano i tristi
avvenimenti che, ancora, succedono nel Purús. Gli «assessori» stanno provocando
– come in altre circostanze – le aggressioni e minacce contro la Chiesa
cattolica, e in particolare contro padre Miguel Piovesan, parroco di Puerto
Esperanza.
Non ci sono dubbi per nessuno, e ancora meno per loro,
che la nostra Chiesa in Purús è una delle poche istituzioni che – senza
protezione alcuna e alla luce del sole – si sta prodigando per reclamare
giustizia e denunciare abusi e corruzione.
Invece del dialogo e del confronto di idee e interessi
che diano soluzioni oneste, trasparenti e dignitose, si ricorre alla
persecuzione sistematica e ingiusta di padre Piovesan, lo si diffama, lo si
minaccia. Si diffondono contro di lui documenti falsi, usciti da assemblee
false e firmate da persone che non hanno partecipato e che poi si indignano
vedendo i propri nomi usati per sostentare un attacco a una persona che,
invece, essi riconoscono e rispettano.
In diverse circostanze, questo Vicariato di Puerto
Maldonado ha ricevuto visite di delegazioni purusine che sollecitavano appoggio
per una connessione fisica del Purús con il Perú. Che colpa si può imputare a
una intera provincia che voglia semplicemente rimanere connessa con lo stato al
quale appartiene? È giusto che per andare al distretto abitato più vicino,
Sepahua (provincia di Atalaya), si debba camminare 22 giorni attraverso la
foresta o 30 giorni per arrivare fino alla strada di Iñapari-Puerto Maldonado?
Di che cosa vivranno gli abitanti del Purús se non
possono beneficiare del loro legno, cacciare i loro animali, pescare i loro
pesci, vendere i loro raccolti? Quale lavoro devono svolgere per ottenere
denaro che permetta loro di alimentarsi con qualcosa di più che manioca e
banane, comperare i vestiti, acquistare il materiale scolastico per dei bambini,
la benzina per il motore della canoa, pagare il proprio documento di identità,
gli studi superiori dei figli, gli occhiali, le scarpe, la radio, le medicine
eccetera? Dove procurarsi il denaro per salire sull’aereo per Pucallpa e
pagarsi vitto e alloggio in città, nel caso ci sia necessità di andarvi per
un’urgenza ospedaliera, un giudizio, un affare qualsiasi?
L’insensibilità
di Wwf e organizzazioni associate davanti al problema umano del Purús potrà
squalificare la sua azione nel resto del mondo? In particolare colpiscono i
metodi mafiosi usati in modo spregiudicato, come la compera di coscienze
stuzzicando gli interessi individuali dei dirigenti indigeni senza alcun
rispetto per l’indigenza della grande maggioranza. Estranei e lontani dalla
inumana situazione indigena, con una presenza sporadica, interessata e
retribuita, questi ecologisti ci feriscono. Davanti al problema costoro
pretendono di convincere la gente del Purús che non sa, non può, non ha bisogno
di niente perché già vive nel Paradiso e tutto quello che c’è fuori di esso è
brutto, è vizio, delinquenza, civilizzazione detestabile. Loro devono
continuare a vivere così, isolati, in riserva, esclusi.
Un paio di manifesti recenti – suppostamente realizzati
dalle comunità indigene – hanno denunciato davanti a tutte le istanze mondiali
la malizia e perversità di un sacerdote cattolico che è il «Satana» del Purús.
Eppure, soltanto voi Wwf-ecologisti avete la possibilità di arrivare nel Purús
in aereo, sempre e ogni volta che sia necessario. Arrivate e vi portate
succulenti stipendi nelle città dove avete le vostre mogli, figli, la vostra
bella casa, la vostra potente automobile. Al contrario di voi, il padre Miguel
va nel Purús e resta là, vivendo le scomodità e le mancanze dei purusini. Non
portando via niente, ma anzi portando là, per condividerlo con gli altri, il
poco o molto che può raccogliere quando si reca in altri paesi. Il padre Miguel
si preoccupa per l’educazione dei giovani, la salute degli ammalati,
l’indigenza degli indigeni, la mancanza di futuro per i giovani e per le donne.
Lo sdegnano le menzogne dei «signori di tuo» che continuano a vivere
magnificamente alle spalle dei soliti poveri o la furbizia e i pochi scrupoli
dei nuovi «capi».
Perché costoro addirittura si impegnano a minacciare di
morte qualcuno che cerca soltanto di affermare il diritto che tutti abbiamo di
vivere dignitosamente? Come osano redigere documenti minacciosi e farli firmare
a chi non sa le conseguenze di tale scemenza? Il padre Miguel non è nemico
degli indigeni; al contrario è voce profetica e fastidiosa contro il potere
abusivo e corrotto, l’ingiustizia istituzionalizzata, gli interessi nascosti,
la bugia, l’inganno, la strumentalizzazione, la paura e la prepotenza.
Per
tutto questo, raccomando con decisione a tutti i credenti, agli uomini e donne
di buona volontà, ai fratelli e sorelle indigeni, alle varie Comunità, che non
lascino solo il padre Miguel in questa lotta. A tutti loro dico: non abbiate
paura, so che vi minacciano, vi licenziano dal lavoro, vi etichettano e vi
impediscono di far uso dei voli «incivili», ma continuando a procedere nella
giusta direzione, alla fine la giustizia divina finirà per darvi qualcosa di
migliore, superando il maltrattamento, la miseria, l’esclusione a cui siete
ancora sottoposti.
mons.
Francisco González Heández,Vicario apostolico di Puerto Maldonado, Perú

Localizzazione: la provincia amazzonica di Purús si trova
nel dipartimento peruviano di Ucayali (Pucallpa) e confina a Nord con il
Brasile e a Sud con il dipartimento di Madre de Dios (Puerto Maldonado).
Capoluogo di provincia: Puerto Esperanza.
Popoli indigeni: Cashinahua, Culina, Sharanahua,
Chaninahua, Amahuaca, Mastanahua, Ashaninka, Yine, Piro; i Cashinahua
costituiscono l’etnia più numerosa, gli Amahuaca la meno (con soltanto una
ventina di membri).
Comunità indigene: 44, soltanto 8 con più di 100
componenti.
Economia: gli indigeni vivono di caccia, pesca e
agricoltura di sussistenza; l’unica attività economica rilevante è quella
legata al commercio del legname pregiato (cedro e caoba).
Attrattive: il «Parco nazionale dell’Alto Purús»,
istituito nel 2004, è il più esteso del Perú (www.pnaltopurus.pe).
Collegamenti attuali: voli aerei da Pucallpa, capoluogo
di Ucayali, a Puerto Esperanza (600 chilometri) attuati, due volte a settimana,
da North American Float Plane Service Sac per 140 soles a tratta (il salario
minimo peruviano è di 750 soles); i voli militari costano meno, ma non hanno
una frequenza prefissata.
Progetto: è in discussione un progetto di Legge (n.
1035/2011-Cr) per collegare con una strada di 270 km Puerto Esperanza con Iñapari
(vedi mappa); a causa dei territori amazzonici e indigeni che la strada
attraverserebbe, il progetto è fonte di un accesissimo dibattito.
Su posizioni opposte: sono favorevoli al progetto
alcuni politici (capeggiati da Carlos Tubino, congressista di Fuerza Popular,
il partito di Keiko Fujimori) e la Chiesa locale nelle persone di padre
Piovesan e di mons. Francisco González Heández, vicario di Puerto Maldonado;
tra i contrari ci sono: le organizzazioni indigene Feconapu, Fenamad, Aidesep;
le organizzazioni inteazionali Wwf, Global Witness, Survival Inteational e
Survival Italia.
Per comunicarecon gli autori*:
www.parroquiapurus.org
misionpurus@yahoo.es
(*) La rivista ha
dato spazio alle opinioni di padre Miguel Piovesan e mons. F. G. Heández,
dopo che gli stessi avevano letto e criticato un reportage di Paolo Moiola
(pubblicato in 3 puntate a giugno, luglio, agosto 2012) sul confinante
dipartimento di Madre de Dios. In esso si parlava anche di vie di comunicazione
(Carretera Interoceanica Sur) e della Fenamad, una delle organizzazioni
indigene contrarie al progetto di strada tra Puerto Esperanza e Inãpari.
Miguel Piovesan eFrancisco González Heández
 L’isola dell’oceano indiano
L’isola dell’oceano indiano «Quattro anni dopo la fine del conflitto,
«Quattro anni dopo la fine del conflitto, Il 23 luglio 1983, con l’uccisione di 13
Il 23 luglio 1983, con l’uccisione di 13 Il governo di Colombo finora ha sempre negato
Il governo di Colombo finora ha sempre negato




 La Somalia di oggi tra business, Al Shabaab e tentativi di democrazia.
La Somalia di oggi tra business, Al Shabaab e tentativi di democrazia. 




 Dal 2012 la Somalia vive un complicato processo politico.
Dal 2012 la Somalia vive un complicato processo politico. Monsignor Giorgio Bertin, vescovo di Gibuti e amministratore apostolico della
Monsignor Giorgio Bertin, vescovo di Gibuti e amministratore apostolico della


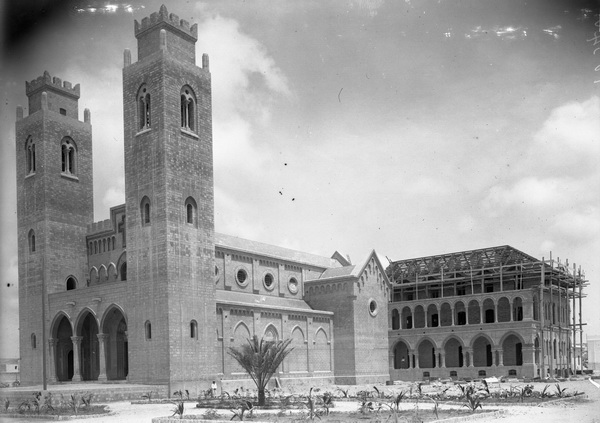
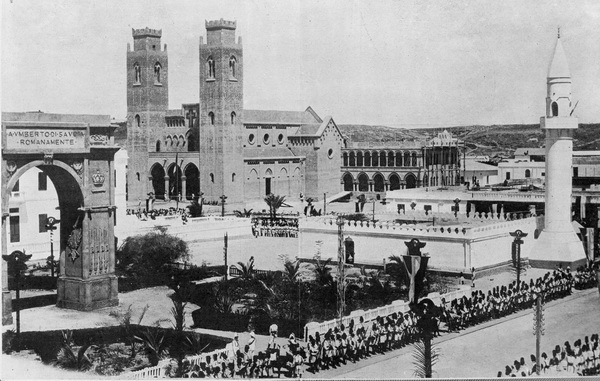








 Reportage dalla missione di Tartagal.
Reportage dalla missione di Tartagal.





 Tra gli indios wichí
Tra gli indios wichí



 Bertolinia. «Il Piauí è lo stato più cattolico della federazione brasiliana.
Bertolinia. «Il Piauí è lo stato più cattolico della federazione brasiliana.




 Le politiche del Pt, al governo da 10 anni, hanno ridotto
Le politiche del Pt, al governo da 10 anni, hanno ridotto
 Storie dall’ex Villaggio olimpico di Torino, occupato dai
Storie dall’ex Villaggio olimpico di Torino, occupato dai














 Il diritto
Il diritto Mael fa parte dei 62 bambini beninesi operati
Mael fa parte dei 62 bambini beninesi operati





