Missionari di «frontiera» Aperta la nuova missione Imc in provincia di Tete

e un tanzaniano. Tre continenti. Tre culture. Un solo approccio: stare con gli
ultimi, i più isolati e lontani. Condividendo
il più possibile. Nello spirito dell’Allamano. E nel ricordo dei primi
missionari della Consolata giunti a Tete nel lontano 1925. Prima «fotografia»
da Finguè.
Venti anni dopo gli accordi di pace di Roma, il Mozambico
sta vivendo ancora la ricostruzione post-bellica. Dopo la guerra civile, il paese si trovò in una precaria situazione economica,
con quasi tutte le infrastrutture distrutte. In passato si colpevolizzava la
guerra, ora sembra quasi tutto tranquillo e pacifico, nonostante ogni tanto ci
sia qualche atto di guerriglia. La bomba a orologeria è il divario sempre più
crescente tra la classe borghese dominante e la povera gente. I poveri lasciano
le campagne e si riversano in città alla ricerca di un lavoro che non trovano.
Chi soccombe in tutto questo sono sempre vecchi, bambini e ammalati.
Il
governo sembra schiavo delle multinazionali e delle donazioni dell’estero.
Fondi che non sono mai disinteressati, così si rischia una dipendenza cronica,
illudendosi di risolvere i problemi.
Per
farsi un’idea basta pensare che la paga minima legale mensile è di 3.000 meticais
(moneta locale) al mese (circa 77 euro).
Il
governo ha dichiarato «guerra alla povertà». L’intenzione è ottima, ma la realtà
è ben diversa, e sono numerose le persone che sopravvivono con un reddito di un
dollaro Usa al giorno.
A
livello sanitario esiste un’organizzazione ben strutturata e abbastanza
funzionale, specie nelle città. Non altrettanto nelle periferie e nei villaggi,
dove le difficoltà si moltiplicano e le
strutture sono paurosamente carenti. Le malattie più frequenti sono malaria e
Aids.
L’educazione, in generale, lascia molto a desiderare,
anche se le università si moltiplicano. Le iscrizioni alla scuola all’inizio
dell’anno sono moltissime, ma passando i mesi, il numero dei frequentanti si
riduce, cosicché molti non finiscono l’anno scolastico. Il risultato è che
molti ragazzi non terminano neppure la scuola di base. Il fenomeno coinvolge
soprattutto le bambine.
Il livello d’insegnamento resta molto basso: dopo anni
di scuola talvolta si stenta a leggere e scrivere. Nonostante le molte denunce
di questo problema sembra non esserci soluzione. Il miraggio è sempre la città,
ma purtroppo molti vi soccombono. In questa lotta per la sopravvivenza è
favorita la prostituzione e il formarsi di gruppi sbandati di giovani.
In generale, la Chiesa ha un fascino morale rilevante.
Non ha grandi strutture perché nel periodo marxista-leninista ha subito una
purificazione che le ha fatto bene. A quel tempo si è sviluppata una Chiesa
molto viva in cui veramente si «camminava assieme». Con il passare degli anni
forse la freschezza iniziale si è affievolita, ma è senza dubbio una Chiesa
piena di ministeri (servizi alla comunità da parte di laici), con un ruolo
importante nella storia del Mozambico.
La provincia di Tete conta circa due milioni
di abitanti sparsi in un’area di 100.715 Km quadrati (un terzo dell’Italia, ndr),
ed è suddivisa in 12 distretti. Il territorio è molto vario: vi si trova una
zona fertile, molto popolata, l’altipiano di Agonia, e una zona secca e arida,
lungo il rio Zambesi e il lago artificiale di Cahora Bassa. Centro propulsore
di tutta la provincia è la città di Tete.
Le popolazioni appartengono alla stessa etnia bantu, ma
sono differenti per lingua e tradizioni. Vi sono due strade asfaltate che
portano al confine con Malawi e Zambia. La gente vive di agricoltura
tradizionale e, quando può, di commercio informale, con bancarelle lungo la
strada. L’altipiano di Angonia ha un livello di vita superiore alle altre parti
della provincia.
A 170 Km da Tete si trova la diga idroelettrica di Cahora Bassa,
che potrebbe dare energia a quasi tutta l’Africa australe. L’elettricità arriva
quasi ovunque, dando una potenzialità grande di sviluppo.
A 20 Km da Tete, a Moatize, è stato trovato
un enorme giacimento di carbone. Altrettanto pare stia accadendo nei distretti
di Magoè, Zumbo e Changara. Per questo fatto tutta la provincia di Tete sta
vivendo un momento di esplosione economica e di «occupazione» da parte delle
grandi compagnie minerarie, soprattutto quella del carbone.
Le enormi potenzialità energetiche e minerarie della zona hanno
attirato qui le multinazionali. La gente locale è costretta a lasciare le terre
per cedere posto alle miniere. Viene in qualche modo indennizzata, ma perde il
suo habitat naturale che gli garantiva una vita dignitosa. Ci si trova così
immersi in un flusso caotico di gente che si sta spostando, con i prezzi che
crescono vertiginosamente. A questo si deve aggiungere l’invasione di tecnici e
di personale delle grandi compagnie minerarie, come la Vale e la Rio Tinto, che
arrivano dall’estero con l’unico scopo del profitto e completamente estranei al
mondo africano. Nei loro insediamenti vivono isolati e allergici a tutto ciò
che capita attorno, chiusi e aggrappati alla propria sicurezza culturale.
Dalla città di Tete parte una strada che va alla frontiera con lo
Zambia. Percorsi 163 Km, si apre a sinistra una strada sterrata che si snoda in
mezzo alla foresta fino al rio Capoce, da dove inizia il distretto di Marávia.
Di qui la strada incomincia a salire con un continuo saliscendi fino ad
arrivare, dopo 115 Km, alla cittadina di Finguè (scritto anche Fingoè o Fingwè).
Situata in un anfiteatro molto bello e con alte colline che le
fanno da corona, Finguè si presenta con un susseguirsi di capanne e casette e
offre un clima fresco e salubre, molto diverso dalla calura della città di
Tete. Lungo la strada incontriamo il mercato, ciò che vi si trova viene in gran
parte dallo Zambia e Zimbabwe, molto vicini. Finguè è la sede amministrativa
del distretto di Marávia (99.000 abitanti, dati 2007) e ha una popolazione di
circa 20.000 persone.
In Finguè è in costruzione un grande ospedale e in attività una
scuola secondaria che nei prossimi anni porterà gli alunni fino all’università.
Queste strutture servono tutto il distretto. Le ragazze e i ragazzi che vengono
dai villaggi vivono in continua precarietà. Sono sempre alla ricerca di un
alloggio o di una casa di parenti o amici, a fine settimana ritornano alle
proprie case per rifoirsi di cibo.
I missionari della Consolata sono arrivati
nel distretto e nella cittadina di Finguè il 16 febbraio 2013. Siamo venuti qui
per rispondere all’invito del nuovo vescovo di Tete, mons. Inácio Saure, anche
lui missionario della Consolata, che si è trovato con un territorio immenso
senza personale. Siamo arrivati in tre: i padri Hyacinth Mwallongo tanzaniano,
Eduardo Reyes colombiano e il sottoscritto Franco Gioda.
C’è anche un collegamento in spirito ai primi missionari della
Consolata, che nel lontano 1925, arrivarono nel distretto di Zumbo, confinante
proprio con quello di Marávia.
In questa grande area abbiamo trovato una realtà molto complessa.
Ci sono tre centri, Finguè, Unkanha e Malowera, attorno cui convergono molte
comunità e popolazioni con caratteristiche proprie, quindi con
l’esigenza di una pastorale diversificata.
A Finguè si trovano molti nuovi villaggi, ma le comunità
cattoliche sono poche, è il regno delle diverse chiese pentecostali. Unkanha,
sede di un’antica missione spagnola, è una zona molto abitata con varie comunità
cattoliche, ma lasciate a se stesse da decenni. A Malowera troviamo molte
comunità che in passato erano fuggite nello Zambia, e ora sono ritornate in
Mozambico, ma vivono molto isolate.


La cittadina di Finguè, e la sua zona, sono state toccate
dall’annuncio del Vangelo negli anni ’50 con i missionari spagnoli di Burgos
che iniziarono una missione a Unkanha, a circa 80 km. A quel tempo Fingoè era
un’area poco popolata, ma già un luogo strategico per il controllo della zona.
C’era un quartiere militare e dei commercianti che di qui partivano per le zone
dell’interno molto popolose. Dicono che allora l’ambiente non fosse molto
accogliente e abbastanza corrotto. I missionari intensificarono la loro attività
altrove. A Finguè fecero una cappella salone, ancora esistente, che serviva da
punto di appoggio per le attività missionarie, ma l’evangelizzazione rimase
molto superficiale e limitata a due o tre comunità.
I missionari furono costretti, a causa della
guerra d’indipendenza, a lasciare Unkanha nel 1971 e da allora non ci fu più
una presenza in tutto il distretto di Marávia. Ci si limitava a tenere contatti
sporadici con qualche messa, poi tutte le attività erano lasciate agli
animatori. In questi quattro decenni sono passate due guerre e un governo che
soffocava ogni dimensione spirituale. Ciò nonostante, la fede è continuata, le
comunità sono aumentate. Oggi ne stiamo trovando alcune aggrappate alla
preghiera, alla parola di Dio, alla carità. La presenza dello Spirito è
palpabile.
In questi anni nell’area di Finguè stanno sorgendo numerosi
villaggi, specie ai lati della strada. Ne contiamo una trentina, nei quali sono
presenti una quindicina di comunità cattoliche. Nella cittadina i cattolici non
sono molti. Possiamo dire che sia il regno delle religioni più disparate che si
rifanno in qualche modo alla Bibbia. I gruppi pentecostali pullulano. La
presenza dei Testimoni di Geova è la più numerosa e meglio organizzata, si fa
sentire con la sua tipica aggressività e con una struttura molto efficiente.
Ogni villaggio importante ha la «Sala del Regno», centro della loro attività.
Il marasma di fedi in questa zona, è dovuto senza dubbio
all’abbandono in cui furono lasciate le comunità e all’invasione di gruppi
religiosi provenienti dai paesi vicini: Malawi, Zambia e Zimbabwe.
La strada che passa a Finguè continua
inerpicandosi su una salita ripidissima, impossibile per i camion, per
diventare una spericolata discesa. Si prosegue poi in una valle per
un’ottantina di chilometri, per arrivare così a Unkanha. Questa era la sede
della missione degli spagnoli. Vi si trovava l’abitazione dei missionari e
delle missionarie, la chiesa, gli inteati (per 150 ragazzi e ragazze), un
posto sanitario e una mateità. Era il centro propulsore di tutto, anche se
l’amministrazione civile era in Finguè.
Ad Unkanha tutto è andato distrutto: restano
solo ruderi. Le popolazioni si sono stanziate a distanza di alcuni chilometri,
ritornano in questo luogo solo per qualche riunione che loro stessi organizzano
per sostenersi nella fede. Si adattano, servendosi di quanto è rimasto
dell’antica missione.
Accanto alla vecchia missione abbandonata, troviamo 34 comunità
molto vive: qui i cattolici sono numerosi e vivono in profonda comunione tra di
loro. Nel tempo della guerra civile molti fuggirono nello Zimbabwe, e al
ritorno hanno vivacizzato le comunità rimaste. Molte di esse ancora vivono
isolate per parecchi mesi all’anno, perché durante la stagione delle piogge è
impossibile ogni comunicazione.
Stiamo facendo una mappa della zona, ma non siamo ancora riusciti
a raggiungere tutte le comunità e speriamo di farlo prima di dicembre. Delle
comunità visitate, alcuni non vedevano da anni un missionario, o mai avevano
partecipato a una messa.
Prima di arrivare alla missione di Unkanha, lungo la strada si
apre un cammino che ci porta, dopo 75 km, alla frontiera con lo Zambia. Una
strada pessima, impossibile durante il periodo delle piogge. Qui c’è un centro
molto importante: la cittadina di Malowera. Attoo a essa si aprono a raggiera
alcune strade che ci portano a diverse comunità cristiane vissute, fin dalla
loro nascita, aggrappandosi alla diocesi di Chipata (Zambia). Qui si vive sotto
l’influsso del paese vicino, compresa la lingua (inglese) e il denaro (kwacha).
L’idea iniziale dei missionari della Consolata che hanno scelto di
venire nella diocesi di Tete, era quella di andare nel distretto di Zumbo, e
raccogliere in qualche modo l’eredità dei primi confratelli e consorelle giunti
in questa zona, precisamente a Miruru, una località vicina al fiume Zambesi a
una settantina di chilometri da Zumbo. Si fermarono per due anni poi, per
motivi politici e religiosi, furono costretti a lasciare quel luogo per andare
nel Niassa e a Porto Amelia (attuale Pemba). Finguè si trova a metà strada, per
noi è quasi un trampolino di lancio per quella zona, dove ci sono ancora una
ventina di comunità cristiane che sopravvivono, nonostante quaranta e più anni
d’abbandono. Sentiamo un dovere morale di essere presenti a Zumbo e Miruru. Lo
faremo nei prossimi mesi nel nome della Consolata.
A Finguè le uniche strutture sono
tre capanne di fango con tetto in paglia. C’è anche una piccola chiesa
costruita dai padri spagnoli di Burgos tanti anni fa per la minuscola comunità
cristiana che stava nascendo. Adesso ce ne serviamo per la preghiera, per
momenti di formazione e come punto d’incontro della comunità.
Si vuole fare il cammino con la gente in uno
stile comunitario e partecipativo e con strutture ridotte all’essenziale. In
questo momento la gente sta facendo i mattoni per offrire una mini struttura
per i missionari. Questo stile di presenza esige pazienza, ma garantisce una
partecipazione costante e attiva della comunità alla vita della missione.
Vorremmo andare avanti così rispettando i tempi e i metodi perché la gente
possa sentire sua la missione che iniziamo.
La nostra azione si basa su due linee orientative: presenza e
formazione. Come presenza intendiamo visitare sistematicamente tutte le comunità.
Come formazione, invece, intendiamo: fare incontri, riunioni «sonkhano»
e un cammino formativo per gli animatori e catechisti delle comunità e avere
per loro un’attenzione particolare. Ci interessano tre settori: formazione
umana, biblica/catechetica e liturgica.
Si parte dunque da una sola missione, Finguè, ma con tre aree
molto distanti l’una dall’altra, con caratteristiche e cammini di fede diversi,
con idiomi differenti. La stessa lingua portoghese non è molto conosciuta,
mentre in molte zone di frontiera si parla inglese. La moneta è differente, si
compra difatti con la kwacha zambiana. Tenendo presente questa
situazione e volendo conoscere bene gli animatori, si crede opportuno che,
perlomeno per questi primi anni, la formazione sia fatta separatamente nelle
tre aree: Finguè, Unkanha e Malowera. Ci si limiterà a un incontro assembleare una
volta all’anno per tutta la parrocchia. Per attuare questo abbiamo bisogno il
più presto possibile di alcune strutture essenziali nei tre centri di cui è
composta questa missione.


Una missione senza grosse infrastrutture. Con materiali e
tecnologia locali. Affinché non si crei distacco con la gente. E i parrocchiani
la sentano «loro». Ecco come inizia la missione di Finguè.
Se il nostro programma è riassumibile in due parole «presenza
e formazione», la metodologia per attuarlo è riducibile a una parola sola: «partecipazione»
cioè condivisione e corresponsabilità sempre e in tutto. Questo esige pazienza
e nello stesso tempo strutture semplici, a volte anche provvisorie. Vorremmo
che non si vedesse la nostra presenza come l’intervento di persone che fanno
tutto perché hanno denaro, ma fratelli di fede che camminano con semplicità con
loro. Quanto si sta facendo deve essere sentito come «cosa propria» dalla
comunità locale, non donazione che viene da fuori. Tutto ciò sarà forse utopia,
ma… lasciateci sognare!
Per l’andamento dei corsi di formazione: ogni comunità
provvederà il cibo per le persone che invierà. Per l’arredamento (coperte e
stuoie): ogni centro provvederà la quantità di cui si ha bisogno con il nostro
appoggio.
La mano d’opera in buona parte sarà soddisfatta dall’apporto
locale. La gente parteciperà alle costruzioni in tutto quello che potrà. I
nostri interventi riguarderanno solo quello che, di fatto, concretamente la
gente non è in grado di fare.
A Finguè vorremmo per questo primo periodo mantenere la
struttura attuale. In questo momento la gente è impegnata a preparare il
materiale per la casa in mattoni dei missionari. La partecipazione dei
parrocchiani continuerà a tutti i livelli, ma a un ritmo che rispetti le
esigenze delle famiglie e della comunità stessa. Il volere subito una casa
efficiente per i missionari ci sembra inopportuno. Così non ci pare il momento
di prospettare strutture grandi e definitive per la formazione degli animatori,
ci pare che il rispettare la semplicità e l’accoglienza della tradizione locale
sia la cosa migliore.
Vorremmo dunque costruire due case di tipo tradizionale per
gli animatori e animatrici a Finguè e Malowera.
Si vogliono poi realizzare tre «alpendre» nei tre centri. Si
tratta di una grande capanna circolare senza pareti con dei pali o colonne che
sorreggono il tetto. Nella circonferenza intea si possono fare anche due o
tre gradini per sedersi, è una specie di piccolo anfiteatro che può contenere
fino a 80 e più persone. Sostituisce molto bene un saloncino con il vantaggio
della frescura.
A Unkanha si possono riabilitare gli edifici della vecchia
missione per avere un complesso di costruzioni degne e confortevoli. Questo
servirà sia per gli incontri di formazione degli animatori, sia per dare
un’abitazione funzionale e tranquilla ai missionari che sistematicamente per
prolungati periodi vengono ad abitarci. In questa zona difatti si trova la
maggior parte delle comunità della missione di Finguè.
A Malowera fino all’anno scorso, oltre a un salone
polivalente che serve ancora adesso da chiesa, non c’era niente altro.
Le attuali strutture dove abitano i missionari sono molto
precarie, sembrerebbe logico intervenire innanzitutto in questo settore, ma la
scelta di stare con la gente e camminare con essa, comporta anche questo. Si
accetta tutto serenamente e con gioia. Si tenga presente del resto che questo
progetto contempla per i missionari la sistemazione a Unkanha di una casa
abbandonata.
Crediamo inoltre che si rimanga perplessi nel pensare di
intervenire in alcuni casi con materiale locale e quindi in qualche modo
provvisorio. Si vorrebbero costruzioni stabili e definitive. Siamo del parere
che, in questo momento e in questo luogo ciò sia sconveniente, sia perché la
missione inizia solo adesso sia perché ci si trova in comunità che hanno atteso
anni e anni l’arrivo dei missionari. Perdere altro tempo in attesa di strutture
efficienti ci pare un venir meno al nostro dovere e un deludere l’attesa della
gente.
Il progetto presentato sembra alquanto dispersivo perché gli
interventi che proponiamo si dirigono in tre centri distanti tra loro,
riguardano però un settore di capitale importanza per la realtà di queste
popolazioni, soprattutto per i cristiani per decenni abbandonati a se stessi.
Senza la formazione degli animatori il nostro lavoro non può riprendere e
andare avanti. Da troppi anni sono vissuti aggrappati solo alla fede e alla
loro buona volontà, senza momenti formativi e senza l’aiuto di sussidi per la
catechesi.


Franco Gioda











 Anni Sessanta.
Anni Sessanta.














.jpg) Fatuma è
Fatuma è.jpg)

.jpg)
 «Mamma – dichiara Aisatu -, Iba verrà a
«Mamma – dichiara Aisatu -, Iba verrà a Il diritto alla salute in Perù / 1:
Il diritto alla salute in Perù / 1:

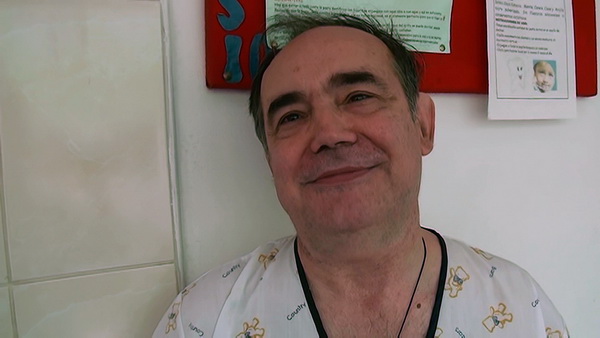
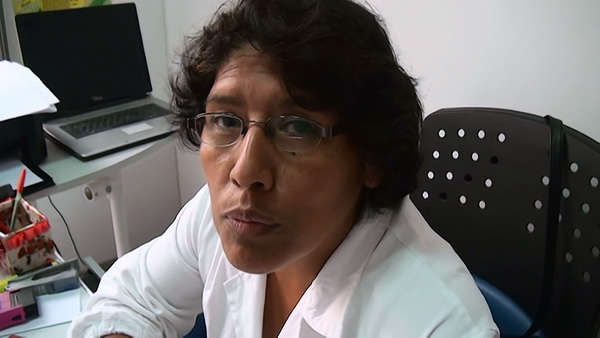

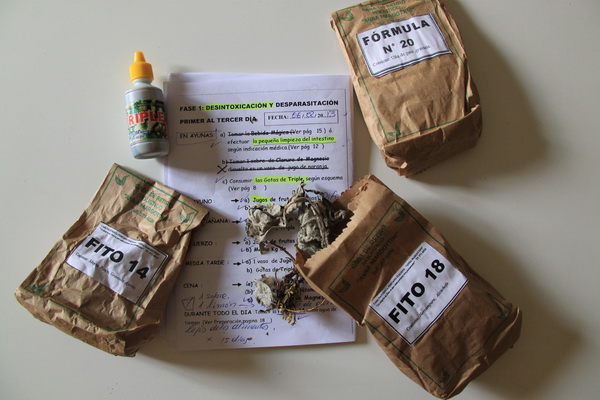



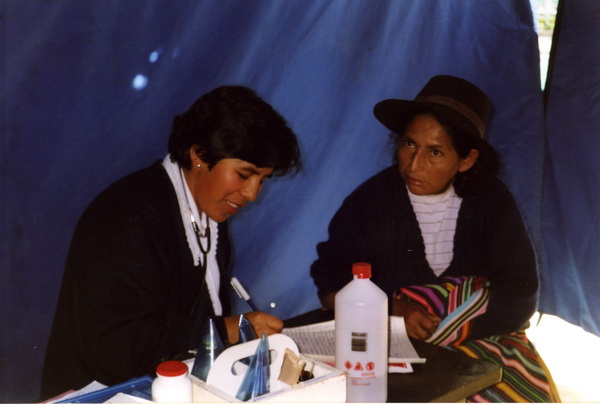


 Il racconto di
Il racconto di






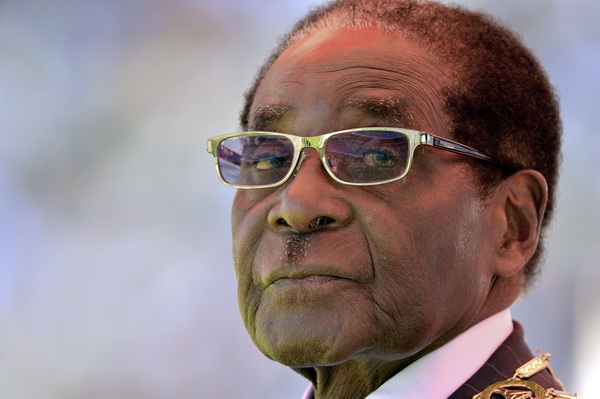



 Il passaggio
Il passaggio













 Padre Benedetto Bellesi: l’uomo,
Padre Benedetto Bellesi: l’uomo, Maestro di «cucina redazionale»
Maestro di «cucina redazionale»



 Ho conosciuto padre
Ho conosciuto padre

 Padre Paolo Dall’Oglio
Padre Paolo Dall’Oglio Padre Paolo Dall’Oglio, gesuita, classe 1954, è stato
Padre Paolo Dall’Oglio, gesuita, classe 1954, è stato
 I libri di padre Dall’Oglio
I libri di padre Dall’Oglio
.JPG) Questione indigena / Incontro con fratel Carlo Zacquini
Questione indigena / Incontro con fratel Carlo Zacquini.JPG)


.JPG)

 La cronologia
La cronologia
.JPG) Gli Yanomami
Gli Yanomami La
La
 I «nuovi» ribelli
I «nuovi» ribelli




