Scivolando nel baratro
Neppure il tempo di riprendersi da una guerra civile durata 15 anni. Un presidente vuole ricandidarsi, a dispetto della Costituzione. Un popolo che non ci sta e chiede vera democrazia. La repressione è violenta. Intanto c’è chi si arma nella foresta.
«Aspetta, senti questi colpi?», stiamo parlando via computer con un giornalista di Bujumbura, capitale del Burundi, quando sento in cuffia diversi spari singoli, seguiti da almeno tre raffiche di mitra. «Stanno sparando vicino a casa mia», continua un po’ turbato, ma non troppo. Poi torna il silenzio e la conversazione riprende normalmente. «Ieri ho rischiato di cadere in un’imboscata. Ero in auto con mia moglie, di passaggio su una grossa arteria di Bujumbura. Alcuni poliziotti inseguivano dei motociclisti e volevano ucciderli. Altri poliziotti sono sopraggiunti e stavano per sparare verso i fuggiaschi, ma noi eravamo in mezzo. Poi si sono fermati perché i loro colleghi sarebbero stati sulla traiettoria. Sono scene che si vedono nei film!».
Il piccolo paese dell’Africa centrale, da nove mesi a questa parte, sta vivendo una crisi politica sempre più acuta e sta, di fatto, precipitando in una nuova guerra civile.
Le premesse
Dopo una guerra fratricida durata dal 1993 al 2003, con strascichi fino al 2008, gli accordi di Arusha (2000) e Pretoria (2003) misero le basi per una nuova Costituzione che ha portato alla coabitazione delle diverse forze in campo. Il paese ha vissuto quindi un decennio di relativa pace.
Con le prime elezioni del nuovo corso (2005) sale al potere Pierre Nkurunziza, ex comandante guerrigliero, ora capo politico del partito Cndd-Fdd (Consiglio nazionale per la difesa della democrazia – Forze per la difesa della democrazia). Ma è alle elezioni successive, nel 2010, che il partito di Nkurunziza viene accusato di brogli elettorali (cfr. MC maggio 2011 e giugno 2013). Lui tira dritto e, mentre l’opposizione boicotta il secondo tuo, il suo partito prende la quasi totalità dei seggi in parlamento. Nkurunziza diventa presidente-padrone del paese, iniziando a imporre metodi da «partito unico». Restrizioni alla libertà di stampa, violenze verso i leader di opposizione e i giornalisti, uso della tortura tornano a essere all’ordine del giorno, così come le fughe all’estero dei perseguitati.
La nuova Costituzione prevede un limite di due mandati di cinque anni per il presidente della Repubblica. L’uomo forte di Bujumbura non vuole lasciare il potere e si inventa un cavillo per potersi ripresentare. Così il 25 aprile dello scorso anno presenta ufficialmente la sua candidatura. Immediata è la reazione della società civile e della gente comune che scende in piazza per manifestare il proprio dissenso.
Ma le manifestazioni erano state proibite, e subito si registrano scontri tra polizia e popolazione indifesa.
Nei giorni seguenti il governo impone il silenzio alle radio private, prima fra tutte la scomoda Radio pubblica africana (Rpa). Sono una decina le vittime dei primi giorni. La comunità internazionale si schiera all’unanimità contro la terza candidatura, ma non riesce a far desistere il presidente.
Tentato golpe ed elezioni farsa
Il 13 maggio, forti della pressione popolare che continua nelle strade e di una visita all’estero del presidente, un gruppo di generali tenta di rovesciarlo. Ma i fedelissimi di Nkurunziza riescono ad arginarli e ad arrestare diversi golpissti, mentre alcuni riescono a scappare.
Nel frattempo oltre 100.000 burundesi fuggono nei paesi confinanti: Tanzania, Repubblica Democratica del Congo e, soprattutto, Rwanda. Qui, appoggiati dal presidente rwandese Paul Kagame, alcuni esuli si organizzano e si armano.
Anche questa volta Nkurunziza va avanti, gestisce le elezioni di luglio, alle quali non partecipano gli osservatori inteazionali, e si conferma al potere. Ormai la stretta sugli oppositori politici e sui media indipendenti è totale. Inizia una vera e propria caccia all’uomo: chiunque si opponga, o si sia opposto, alla terza candidatura, diventa un potenziale «nemico della patria», a cominciare dagli stessi compagni di partito del presidente non allineati.
Verso la guerra civile
Il conflitto sale di livello l’11 dicembre scorso. I gruppi dell’opposizione armata, ormai presenti nel paese, escono allo scoperto, attaccando tre campi militari, due a Bujumbura e uno nell’interno. Il bilancio si salda con 12 morti tra gli assalitori, che riescono a recuperare armi dell’esercito regolare. Questa data sancisce la presenza della ribellione sulle colline intorno alla capitale Bujumbura. Si fanno chiamare Forze repubblicane del Burundi (Forebu) e Resistenza per uno stato di diritto in Burundi. A capo del Forebu sarebbe il generale Godefroid Niyombare, leader del tentato golpe di maggio.
Anche la repressione fa un salto di qualità. Nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 dicembre la polizia rastrella i quartieri cosiddetti «contestatari» dove si annidano gli oppositori. La mattina sono oltre 150 i cadaveri di giovani trovati lungo le strade della città, che ben presto le autorità fanno scomparire.
«L’opposizione armata si è ormai dichiarata. Sono ben equipaggiati, hanno preso anche materiale radio dai depositi dell’esercito, e sono sulle colline intorno a Bujumbura», ci racconta un cornoperante straniero che chiede l’anonimato. «Ogni tanto fanno delle incursioni in città. L’altro giorno hanno assaltato la casa del presidente del Parlamento, nel quartiere Mutanga Nord». E continua: «L’esercito è diviso. Non tutti sono d’accordo con il potere. Ci sono disertori che raggiungono la ribellione. Chi resta non si esprime contro, altrimenti lo fanno secco».
Il lavoro di rastrellamento nei quartieri lo fa la polizia. Avviene ormai ogni notte. «Ai posti di blocco o a fare le perquisizioni sono sempre gli stessi poliziotti, perché molti si rifiutano. Inoltre ci sono diversi rwandesi tra loro, mercenari. Hanno le stesse divise, ma si capisce la loro provenienza perché parlano kinyarwanda e non kirundi (due lingue molto simili, parlate nei due paesi, ma con evidenti differenze, ndr)». Si tratta dei famigerati interamwe, gli hutu rwandesi che vivono nel confinante Congo Rd dai tempi del genocidio in Rwanda (1994), in costante guerra con il regime di Kagame.
«Questo spiega perché i quartieri a maggioranza tutsi, come Nyakabiga, sono maggiormente presi di mira», ci dice il nostro interlocutore. Intanto, a fine gennaio Amnesty Inteational mostra le prove di fosse comuni.
Conflitto etnico?
La questione etnica, che sembrava risolta grazie agli accordi di Arusha, rischia di riaffiorare.
Il giornalista burundese, raggiunto via computer, ci spiega: «C’è una piccola dose di etnicismo, ma in realtà è piuttosto un problema politico. Ovvero tutti quelli che sono contro il terzo mandato sono messi nello stesso gruppo e sono da eliminare, che siano essi hutu o tutsi. Però se vivi in un quartiere come Musaga, Nyakabiga, Jabe, a maggioranza tutsi, è più facile che, una volta arrestato, tu sia ucciso».
E continua: «La polizia cerca oppositori nei quartieri, tutti i giorni e le notti. E se sei un giovane tra i 15 e i 20 anni vieni subito arrestato». I giovani fermati sono picchiati e drogati, alcuni finiscono in carcere, altri vengono rilasciati.
«Un giovane che conosco, di 15 anni, si trovava in centro per caso, e durante un rastrellamento lo hanno preso. Dopo averlo picchiato e imbottito di pasticche lo hanno liberato. Ora è a casa in stato di choc», ci racconta il cornoperante. «Qualche giorno fa hanno arrestato 104 ragazzi nel quartiere di Mutakura. Alcuni li rilasceranno, altri li terranno in prigione. Ci sono 26.000 prigionieri nelle carceri».
Continua il giornalista: «Oltre alla polizia, i miliziani imbonerakure sono molto attivi. Si tratta della lega dei giovani del partito al potere. Sono potenti e pattugliano i quartieri soprattutto la notte. In un grosso quartiere, Ciarama, a Nord della capitale, ogni famiglia deve pagare loro 1.000 franchi (60 centesimi, nda) per assicurare la sicurezza dell’area. È un quartiere nuovo, ci sono molti militari e dignitari e vogliono mantenere questa milizia». Gli imbonerakure sono una vera e propria milizia al servizio del potere, utilizzata per i lavori più sporchi e agiscono nella totale impunità.
Verso il collasso
Il presidente vive ormai nascosto: «Nkurunziza non risiede quasi mai in capitale, ma resta nella sua città natale, Ngozi, nel Nord del paese», conferma il giornalista.
Rincara il cornoperante: «Non può neanche fidarsi dei propri compagni di partito. I soldi sono finiti e avrà difficoltà a pagare la polizia, i funzionari, i ministri e il loro entourage. Per ora cerca di recuperare soldi dalle Organizzazioni inteazionali, obbligandole ad aprire conti in valuta alla Banca della Repubblica del Burundi. Il resto lo farà la corruzione. Inoltre, alle Ong inteazionali arrivano insolite ingiunzioni di pagamento di tasse non giustificate».
I finanziatori, per prima l’Unione europea, hanno congelato i fondi, mentre gli investitori hanno rallentato. L’economia è bloccata: «I prezzi degli alimenti sono raddoppiati in città, perché i contadini non si arrischiano a venirli a vendere. Nelle campagne si sopravvive con l’agricoltura di sussistenza, ma in capitale diventa difficile e comunque dispendioso, procurarsi da mangiare», continua il cornoperante.
Dialogo, tra sordi
Dei tentativi di «dialogo» si svolgono il 28 dicembre 2015 a Kampala, in Uganda. Qui si incontrano governo burundese, opposizione e società civile. Questo incontro fa seguito a quello tenuto poco prima delle elezioni e fallito perché abbandonato dai rappresentanti dell’esecutivo.
Il governo burundese rifiuta di riconoscere, e quindi dialogare, con il Consiglio nazionale per il rispetto dell’accordo di Arusha e il ritorno dello stato di diritti in Burundi (Cnared). Si tratta di una piattaforma composta da ex compagni di partito del presidente, oppositori e società civile che chiede al presidente di farsi da parte. Ci racconta il giornalista burundese: «Nel dialogo a Kampala, il governo ha detto che non può sedersi con il Cnared. Alla testa della piattaforma, nella quale si incontrano tutti gli oppositori in esilio, c’è Léonard Nyangoma, anche lui ex ribelle. Tutti i vecchi del Cndd che si sono opposti al terzo mandato. Il governo non vuole parlare con loro. La situazione si complica. La mediazione del presidente ugandese Museveni non è abbastanza forte». Il governo accusa i membri del Cnared di aver partecipato al tentato golpe del maggio 2015. Così la data successiva prevista dalla mediazione per il dialogo, il 6 gennaio, salta.
Intanto il Consiglio di pace e sicurezza dell’Unione africana (Ua) vorrebbe mandare una missione multinazionale di interposizione per bloccare l’escalation di violenze, ma il governo di Nkurunziza non ne vuole sapere e la vede come una «forza d’invasione straniera».
«Sì, l’Ua vuole inviare delle truppe, ma il governo le ha rifiutate. L’ultima parola è all’Ua, ma per intervenire in un paese membro sono necessari i due terzi dei voti favorevoli dell’assemblea. Io non penso che si potranno avere, perché la maggior parte dei presidenti sono dei dittatori, e sono al potere da decine di anni. C’è Kagame che ha ufficializzato il suo terzo mandato (potrà governare fino al 2034, nda), Museveni ha più di 20 anni al potere, Mugabe è il più vecchio».
Così pure l’iniziativa dell’Ua, decisa il 18 dicembre, rimane senza seguito.
Tre scenari per il futuro
Anche l’Onu vuole evitare il peggio e potrebbe finanziare la missione dell’Ua. L’operazione più veloce sarebbe spostare in Burundi parte dei caschi blu della Minusco, presenti nel vicino Congo.
Un rapporto confidenziale per il Consiglio di sicurezza dell’Onu, realizzato da Hervé Ladsous, capo delle operazioni per il mantenimento della pace in Burundi, diventato pubblico a inizio gennaio, ha ipotizzato tre possibili scenari futuri. Primo: la situazione resta stabile, con gravi ripetute violazioni dei diritti umani. In questo caso occorre favorire una missione dell’Ua. Secondo: la violenza sale di livello, in seguito a una scissione nell’esercito o a un assassinio politico. La guerra diventa aperta tra fazioni e si diffonde in tutto il paese. Non ci sono negoziati politici. Il rischio umanitario interessa due milioni di persone. Terzo: le violenze divampano e assumono una connotazione etnica, con incitazione a crimini contro l’umanità, crimini di guerra e genocidio.
Il memorandum ipotizza l’invio di una missione di caschi blu, possibile solo con risoluzione del Consiglio di Sicurezza. Fatto più allarmante, secondo l’autore del testo: «L’Onu non sarebbe attualmente in grado di proteggere la popolazione burundese senza un aiuto degli stati membri». Un primo effetto del rapporto è la missione del consiglio di sicurezza nel paese il 20 gennaio.
Il consigliere per la comunicazione della presidenza del Burundi, Willy Nyamitwe, reagisce immediatamente con un tweet: «Il rapporto mente». Anche il cornoperante ci confida la sua visione: «Può essere un periodo che durerà. Può instaurarsi una guerra civile. Sono andati troppo oltre. A livello internazionale gli interventi economici per mettere in difficoltà il governo sono stati fatti. Ma questi sono ex guerriglieri, abituati a stare in foresta, a vivere con poco, ad ammazzare. Quindi resisteranno fino alla fine».
Marco Bello



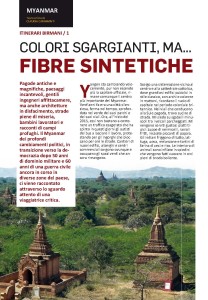

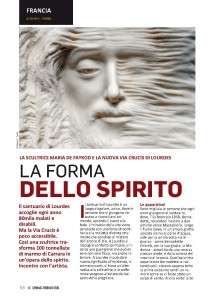
 Laurent Lompo, il
Laurent Lompo, il














 Gli interessi di Istambul
Gli interessi di Istambul


