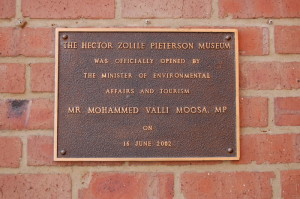Timor est piccoli imprenditori crescono
Un piccolo paese, indipendente dal 2002, con appena 1,2 milioni di abitanti, in maggioranza cattolici, cerca di uscire dalla povertà e dall’isolamento. Vi raccontiamo le storie di alcuni giovani imprenditori locali.
«Adoro cucinare all’aria aperta. Mi piace che le persone possano vedermi mentre preparo i miei piatti. Questo crea un rapporto più diretto tra me e loro». A bordo di un pick up di seconda mano Cesar Gaio passa le sue giornate lungo le ventose strade che costeggiano il mare di Dili, fermandosi nelle zone più affollate per vendere deliziosi wrap. Una piccola cucina a gas montata sul retro del furgone gli basta per preparare questi sandwich fatti con morbido pane basso arrotolato intorno a un ripieno di patate dolci viola e pesce fresco. La scritta «Dilicious Timor» che si legge sulla fiancata del camioncino è la stessa che si trova sull’insegna del piccolo ristorante che ha aperto alcuni mesi fa, sempre vicino alla costa, nella capitale di Timor Est. E anche nel suo locale vengono serviti esclusivamente piatti preparati con prodotti freschi del luogo.
Cesar Gaio ha 32 anni, le idee chiare e la voglia di costruire qualcosa di stabile per sé e per il suo paese. È uno dei sempre più numerosi giovani imprenditori che, tra mille difficoltà, hanno deciso di scommettere sulle risorse e la popolazione locale per avviare attività che possano trascinare l’isola in cui è nato e cresciuto fuori dal baratro del sottosviluppo e della povertà in cui secoli di dominazione portoghese e 25 anni di occupazione indonesiana l’hanno sprofondata. La sua storia, raccontata dal sito latestnews24, dimostra che gli abitanti di Timor sono chiamati ad affrontare quotidianamente problemi di ogni sorta ma non hanno perso la speranza nel futuro.
Un caffè da Gally
L’anno scorso Gally Soares Araujo ha lasciato il suo ben retribuito lavoro da impiegato statale e, con i soldi messi da parte, ha aperto Kaffe Out, un piccolo bar costruito con mattoni rossi che offre diversi tipi di pregiati caffè, accompagnati da torte di carota e altri dolci, nel centro di Dili. A 29 anni Gally ha sentito il «bisogno di iniziare a fare qualcosa di mio». E siccome a Timor Est l’industria del caffè ha un enorme potenziale ancora poco sfruttato ha deciso di investire in questo settore. Nel suo locale, arredato in modo essenziale e colorato, particolarmente richiesta è la miscela prodotta nella zona del Monte Rameleau, che con i suoi 2.962 metri è la montagna più alta di tutta l’isola (curiosità: in passato è stata la vetta più alta di tutto l’Impero portoghese). Nella lingua locale, il tetum, il rilievo è chiamato Tata Mailau, che significa letteralmente «Il nonno di tutti». «Il particolare microclima della zona consente di coltivare un eccellente caffè, che ha un aroma molto particolare», ha spiegato Gally alla Bbc. «Penso che si possa veramente dare un contributo al cambiamento di cui il paese ha bisogno. Quando le Nazioni Unite hanno concluso la loro missione di pace nel 2012 abbiamo capito che avremmo dovuto iniziare da soli a ricostruire. Ed è quello che stiamo facendo».
Invasione straniera
Non tutti gli imprenditori hanno scommesso sul settore del cibo e della ristorazione. Rui Carvalho ha utilizzato i suoi risparmi e ha venduto alcuni terreni di famiglia per aprire nel 2009 Rui Collections, una boutique di moda made-to-order. L’azienda produce principalmente tais, un panno di cotone tradizionale che viene utilizzato per confezionare abiti, scarpe e borse. «Quando vedo le donne che vivono nelle zone rurali, che non sanno leggere, non sanno contare e non hanno neppure gli strumenti per produrre il tais mi accorgo di quanto sia difficile la strada che abbiamo davanti», ha sottolineato Rui nel corso di un’intervista a latestnews24. «Ma sono molto orgoglioso di quello che sono riuscito a realizzare fino ad ora con tanti sacrifici». L’imprenditore ha 42 anni e da quando ha avviato la sua attività ha potuto assumere più di una dozzina di dipendenti, in maggioranza vedove, giovani che avevano abbandonato la scuola e persone in difficoltà.
Quella di Carvalho è stata una scelta particolarmente coraggiosa in un paese in cui l’80% degli 1,2 milioni di abitanti vive di agricoltura, quasi sempre di sussistenza, e meno di 200mila persone hanno un impiego effettivo. Ma anche gli altri «colleghi» devono dimostrarsi molto determinati, essendo chiamati a fronteggiare difficoltà enormi collegate alla povertà diffusa, alla carenza di infrastrutture e alla mancanza di istruzione. Ostacoli cui si è aggiunto nell’ultimo periodo quello della concorrenza proveniente dall’estero.
La catena statunitense Burger King, ad esempio, ha deciso di raddoppiare entro i prossimi cinque anni i punti vendita presenti sull’isola, portandoli a otto. Beard Papa, franchising giapponese specializzato in bignè alla crema, ha appena aperto un negozio a Dili e ne avvierà altri quattro a breve. L’australiana Gloria Jean’s Coffee ha in programma di espandere la sua per ora modesta presenza e anche l’olandese Heineken ha iniziato le procedure per costruire una fabbrica di birra in loco. La speranza degli imprenditori stranieri è quella di attrarre non solo i turisti ma anche gli abitanti più giovani, inevitabilmente influenzati dallo stile di vita e di consumo occidentali.
Basta paura e rassegnazione
Filipe Alfaiate gestisce Empreza Diak, un’organizzazione che ha trascorso gli ultimi cinque anni cercando di incoraggiare l’imprenditorialità locale come una forma di cambiamento sociale. Secondo lui il popolo di Timor Est ha davanti a sé una sfida epocale, quella di riuscire a creare un’economia di mercato in grado di reggersi sulla domanda intea. Impresa di per sé non facile per un paese così piccolo, e resa ancora più complicata da decenni di sfruttamento da parte di potenze straniere che hanno contribuito a rendere le persone rassegnate e avverse a ogni tipo di rischio.
«Dopo tutto quello che hanno passato, gli abitanti di Timor preferiscono aggrapparsi a quello che già hanno. Questo li porta nella maggior parte dei casi a scegliere la sicurezza di una paga mensile, per quanto misera, piuttosto che assumersi il rischio legato all’avvio di una nuova attività», ha sostenuto Alfaiate alla Bbc.
Negli ultimi tempi però la situazione ha iniziato a cambiare. «I giovani hanno cominciato a capire che non ci sono abbastanza posti di lavoro per tutti. La metà della popolazione dell’isola ha meno di trent’anni e quindi una mentalità più aperta rispetto alle precedenti generazioni. Sempre più persone si stanno orientando verso scelte imprenditoriali, assumendosi dei rischi per avviare nuove attività che possano portare a un cambiamento e a uno sviluppo».
Per Alfaiate il primo scoglio da superare è proprio di tipo culturale. «Serve un grande cambiamento nel modo di pensare. Per secoli gli abitanti di Timor sono stati abituati a coltivare i campi, producendo cibo appena necessario al proprio sostentamento». Il piccolo sviluppo dell’economia avvenuto di recente è stato legato quasi esclusivamente al turismo e alla presenza del personale delle Nazioni Unite. «Si importano cose e si vendono. Quello che è necessario sono invece persone pronte a scommettere sulle risorse e sui lavoratori del luogo. Per essere un imprenditore nella nostra isola serve un mix di grande talento, accesso al credito e sostegno a livello locale. Ci vorrà del tempo ma le cose si stanno muovendo nella direzione giusta. Ci sono possibilità di crescita concrete, anche se ancora limitate».
L’ottimismo di Alfaiate è confortato dai numeri. Florencio Sanches, il capo dell’ufficio governativo incaricato di registrare nuove imprese ha dichiarato, sempre alla Bbc, che i giovani imprenditori negli ultimi anni sono andati aumentando, anche grazie allo snellimento delle procedure burocratiche, che ha reso più facile per gli abitanti avviare un’attività. Dal 2013 sono state costituite 11mila nuove imprese, in grandissima parte proprietà di persone sotto i trent’anni, mentre nel lustro precedente le registrazioni erano state in tutto 5mila.
La vera svolta, però, secondo Sanches si vedrà solo se si riuscirà a garantire alla popolazione un più ampio accesso al credito. «Il governo dovrebbe impegnarsi a sviluppare politiche che incoraggino banche e istituti a prestare denaro alle persone». Servono tassi e condizioni agevolate per l’ottenimento di finanziamenti, «senza i quali a Timor non potrà mai svilupparsi un tessuto imprenditoriale abbastanza robusto per consentire la nascita di un’economia locale solida». Anche volendo però, l’esecutivo non potrà fare tutto da solo. «Abbiamo bisogno della partecipazione del settore privato. Devono essere studiate in breve tempo delle soluzioni, perché solo risolvendo questo problema potremo dare alla nostra isola la speranza di un futuro migliore».
Paolo Tosatti*
Cronologia essenziale
Dai portoghesi agli indonesiani
XVI-XX Secolo – Timor Est è sotto il dominio del Portogallo, che sfrutta l’isola a fini commerciali.
1975 – Il 28 novembre fazioni filo-comuniste presenti nel paese dichiarano l’indipendenza da Lisbona. A dicembre il timore di vedere un governo comunista indipendente all’interno dell’arcipelago indonesiano porta il governo di Jakarta a invadere Timor Est su vasta scala, con il supporto dei governi occidentali.
1976 – Il 17 luglio l’Indonesia dichiara Timor Est come la propria 27esima provincia con il nome di Timor Timur. Inizia un lungo periodo segnato da scontri tra l’esercito clandestino degli indipendentisti, le forze regolari indonesiane e le milizie civili anti-indipendentiste. Nei combattimenti vengono spesso coinvolti anche i civili.
1996 – José Ramos-Horta, rappresentante del Fretilin, il partito che conduce la lotta clandestina contro l’occupazione, si vede assegnare, insieme a monsignor Carlos Filipe Ximenes Belo, il premio Nobel per la pace per il proprio impegno in favore dell’indipendenza del suo paese.
1999 – Dopo oltre 20 anni di occupazione il 30 agosto gli abitanti dell’isola votano in favore dell’indipendenza in un referendum organizzato dalle Nazioni Unite. Timor diventa così la prima nazione a raggiungere l’indipendenza nel XXI secolo. Nel paese si scatena un’ondata di violenze che si interrompe solo a seguito dell’intervento della forza di peacekeeping Interfet («Inteational Force for East Timor») formata da 10mila uomini di 17 paesi, Italia compresa. Successivamente subentrano le Nazioni Unite con Untaet prima e Unmiset poi.
2002 – Il 20 maggio Timor Est diviene indipendente. Xanana Gusmão, leader del movimento di guerriglia indipendentista Falintil, viene eletto presidente.
2006 – Nel mese di marzo metà delle forze armate si ribella al primo ministro Mari Alkatiri, che le aveva forzatamente congedate. I soldati ribelli si rivolgono a Gusmão che, sconfessando l’operato del premier, assume il comando dell’esercito. Il paese precipita nella guerra civile. L’intervento di 2000 soldati australiani, 500 malesi e di alcune unità neozelandesi e portoghesi limita i danni nei confronti della popolazione.
2007 – Il Nobel Ramos-Horta viene eletto capo di stato. Xanana Gusmão diventa primo ministro.
2008 – L’11 febbraio un gruppo di militari ribelli tenta un golpe, attaccando Ramos-Horta, che resta gravemente ferito, e Gusmão, che esce invece illeso dall’attentato. Il colpo di stato non ha comunque successo.
2012 – Taur Matan Ruak, ex leader della guerriglia antindonesiana, viene eletto presidente.
2015 – Il 2 febbraio Xanana Gusmão rassegna le dimissioni dalla carica di primo ministro. Gli subentra Rui Maria De Araujo.
2016 – A fine marzo prende possesso della diocesi di Dili il nuovo vescovo Virgilio Do Carmo Da Silva.
Pa.To.