Solo Dio può salvare il Centrafrica
Centrafrica, dal Carmel di Bangui ci scrive padre Federico Trinchero |
Il primo maggio 2018, durante la messa a Notre Dame de Fatima, – una parrocchia di Bangui capitale della Repubblica Centrafricana (Centrafrica) – un gruppo di miliziani ha lanciato un attacco con granate sui fedeli. Sedici i morti – tra i quali il sacerdote – e un centinaio i feriti. È l’ennesimo atto di una guerra di potere iniziata nel 2012, e che è stata trasformata in conflitto etnico-religioso. La testimonianza di un missionario a Bangui.
«Nei momenti più difficili emergono degli eroi e non dubito che degli eroi esistano nel Centrafrica per alzarsi, come un solo uomo, per dire no alla violenza, no alla barbarie, no alla distruzione di se stessi». È questo l’appello che l’arcivescovo di Bangui, il cardinale Dieudonné Nzapalainga, ha rivolto alla capitale e all’intera nazione in questi giorni drammatici, carichi di tensione e di tristezza.
![]()
Cos’è successo a Bangui?
La mattina del primo maggio, durante una celebrazione nella parrocchia di Notre Dame de Fatima (a poca distanza dal nostro convento), un gruppo armato proveniente dal quartiere Km5 (Pk5 è un’enclave a maggioranza musulmana, da anni il focolaio principale delle tensioni della capitale) ha aperto il fuoco sulla gente in preghiera provocando 16 morti e un centinaio di feriti. L’incursione è avvenuta come rappresaglia in reazione a un tentativo da parte delle forze dell’ordine di catturare alcuni elementi di questo gruppo armato che, di fatto, tiene in ostaggio la capitale e alcuni degli stessi musulmani del quartiere.
I fedeli a Fatima avevano appena proclamato la loro fede e stava per iniziare l’offertorio. Ma la messa è continuata con il sacrificio di sedici cristiani, tra i quali un sacerdote, l’abbé Albert Tungumale Baba. Lo scontro è poi continuato per giorni in altri quartieri della città provocando altri morti, altri feriti e la distruzione di due moschee.
nella Repubblica Centrafricana un massacro tira l’altro
L’episodio del primo maggio, che ha ferito e lasciato quasi incredula l’intera città, è avvenuto inoltre a poche settimane dell’uccisione a Séko (nel centro del paese) di un altro sacerdote, l’abbé Désiré Angbabata, insieme a undici suoi parrocchiani (assassinio avvenuto il 21 marzo 2018).
L’abbé Albert, settantun anni, tra i sacerdoti più anziani del clero di Bangui, era un pastore stimato e conosciuto per la sua semplicità e simpatia, e soprattutto per la sua opera discreta e infaticabile in favore della riconciliazione tra cristiani e musulmani. Durante le fasi più acute della guerra aveva accolto per diversi anni, nella sua parrocchia vicinissima al Km5, migliaia di profughi provenienti dai quartieri vicini. L’abbé Albert, inoltre, era a tutti noto per il suo grande amore per il sango, la lingua nazionale della Repubblica Centrafricana, non particolarmente ricca di vocaboli. L’abbé Albert riusciva a tradurre ogni parola (senza usare il francese), con soluzioni geniali o giri di parole divertenti. Una volta, mentre eravamo in macchina insieme, tradusse pure il mio nome, decretando che mi si doveva chiamare Bwa (che in sango significa sacerdote) Federiki.
![]()
Salvare il Centrafrica
In un’intervista l’abbé Albert aveva detto che solo Dio può ormai salvare il Centrafrica. Non aveva tutti i torti. A salvare il Centrafrica ci hanno provato, e ci stanno ancora provando, in tanti: l’esercito nazionale, le truppe dell’Unione africana, la missione francese (che ha comunque il grande merito di aver impedito che il conflitto diventasse un massacro), i soldati dell’Unione europea, poi la Minusca, la grande missione dell’Onu (che, pur con tutti i suoi limiti, resta al momento l’unica soluzione possibile) e ora sono all’orizzonte anche i russi. Ci ha provato pure papa Francesco che, con la sua visita nel novembre del 2015, era riuscito a regalare una tregua sufficiente per eleggere democraticamente un nuovo presidente. Con il tempo, purtroppo, l’effetto di quella visita è come svanito e l’occasione di voltare pagina è stata per l’ennesima volta sprecata. Gli scontri si sono moltiplicati su tutta l’estensione del paese e quella pace, che avevamo appena accarezzato, sembra quasi più lontana di prima.

Una guerra, perché?
Perché è iniziata questa guerra? E perché sembra impossibile arrestarla? Le guerre sono sempre complesse, iniziano per tanti motivi ed evolvono nel tempo. Anche per chi abita qui da anni è difficile spiegare le vere ragioni del conflitto e, ancor di più, suggerire la soluzione giusta per spegnere l’incendio evitando che si propaghi ora qui, ora là – quasi come i fuochi della savana – lasciando solo morti, distruzione, paura e scoraggiamento. Attualmente i due campi avversari non sono neppure così nettamente distinguibili, come nei primi anni della guerra, tra Seleka (la coalizione delle milizie a maggioranza musulmana, tra cui anche mercenari di altri paesi) e gli anti-balaka (le milizie di autodifesa, sorte a difesa della popolazione del paese, a maggioranza cristiana, ma dalle quali i vescovi hanno sempre preso le distanze). La Seleka è ufficialmente sciolta. Ogni gruppo di ribelli ha il suo capo, i suoi obiettivi e la sua zona d’influenza (ad esempio l’Unione per la pace in Centrafrica è il gruppo che ha compiuto l’attacco a Séko, ndr). Non c’è più quella guerra casa per casa, quartiere per quartiere che Bangui aveva conosciuto nel 2013 e nel 2014. Ora si tratta di battaglie che hanno per protagonisti gruppi di autodifesa, i soldati dell’Onu o le forze dell’ordine. Tre quarti del paese sono come fuori dal controllo dell’autorità dello stato.

Guerra per le risorse
La guerra nel Centrafrica, iniziata di fatto già nel 2012, non è uno scontro confessionale o etnico. Si tratta piuttosto dell’ennesimo conflitto per la conquista del potere e per lo sfruttamento delle ricchezze di cui abbonda il sottosuolo (ad esempio i diamanti, ndr). Purtroppo, l’elemento confessionale si è inserito violentemente, avvelenando quella convivenza tra cristiani e musulmani che faceva del Centrafrica – in un tempo ormai lontano – un esempio di coabitazione pacifica. Seko e Fatima confermano che per ritornare alla situazione precedente la strada è ancora lunga.
Durante l’omelia, in occasione dei funerali del sacerdote ucciso e di alcune delle vittime, il cardinale di Bangui ha messo tutti con le spalle al muro denunciando l’inerzia del governo, la lentezza dell’Onu e il rischio che i cristiani cedano allo sconforto o, peggio ancora, alla logica della violenza e della vendetta. C’è un nemico insidioso che sta distruggendo il Centrafrica. E questo nemico, ha scandito il Cardinale, è il diavolo. Solo le armi della fede possono vincerlo.
Bangui, ferita al cuore della sua fede, non è arrabbiata con Dio. È arrabbiata piuttosto con quegli uomini che non vogliono la pace e, quasi obbedendo a un’agenda nascosta, si ostinano a bloccare il paese, come se fosse ineluttabilmente condannato alla miseria e alla guerra. Bangui e tutto il Centrafica sono in cerca di eroi – tra i governanti, i soldati, i giovani – che si alzino come un solo uomo e dicano no alla guerra e sì alla pace.
Federico Trinchero*
carmelitano scalzo, è missionario in Rca e superiore del convento Notre Dame du Mont Carmel di Bangui. Avevamo scritto di lui nel luglio del 2014.
La voce del cardinale Dieudonné Nzapalainga

Dobbiamo essere le sentinelle
In seguito al massacro di Fatima, e al linciaggio di due musulmani per rappresaglia, il cardinale Dieudonné Nzapalainga invita alla calma: «Cosa abbiamo fatto di questo paese? Colpi di stato, ammutinamenti, ribellioni a ripetizione. I risultati sono davanti a noi: abbiamo morti, saccheggi e distruzione. Gli ultimi drammatici avvenimenti ci ricordano che la violenza non porta soluzioni ai nostri problemi».
Pubblichiamo parte della sua predica al funerale delle vittime del primo maggio.
Cari fratelli e sorelle,
l’arcidiocesi di Bangui è in lutto. Piange i suoi figli. Le nostre lacrime non si fermano da quando abbiamo saputo dell’atto terroristico, barbaro, commesso alla parrocchia Notre Dame de Fatima, durante la grande celebrazione eucaristica del primo maggio scorso. Un sentimento di tristezza, di collera, di desolazione abita il nostro cuore e ci fa sprofondare in una dura prova. Che fare?
Dopo alcuni momenti di preghiera e di riflessione, abbiamo la certezza che il Signore non abbandona mai coloro che credono in lui. Nei momenti di grande tribolazione viene in loro soccorso per liberarli, consolarli, medicare le loro ferite e asciugare le loro lacrime. Ecco perché abbiamo scelto di tenere gli stessi testi liturgici letti a Fatima. Non chiudiamo il nostro cuore, ma ascoltiamo la voce del Signore che ci parla, perché lui solo è nostro rifugio, nostra salvezza.
Nella prima lettura, Paolo ha subito l’aggressione dei giudei venuti da Antiochia. L’hanno lapidato e portato fuori dalla città pensando che fosse morto. Il loro piano era di mettere fine all’annuncio della Buona novella in quella città. Per questo, occorreva uccidere Paolo. Ma hanno fallito. Il testo continua: «Il giorno successivo con Barnaba, Paolo parte per Derbé. Annunciarono la Buona novella … e fecero un buon numero di discepoli». […]
Questo testo è una vera profezia. L’abbé Tungumale Baba è stato aggredito, ucciso. Il suo corpo trascinato nella città di Bangui. I suoi aggressori hanno pensato di aver vinto. No, non potranno mai eliminare la Chiesa cattolica. Non potranno mai mettere fine all’annuncio della Buona novella a Fatima. Paolo dopo l’aggressione diceva: «Dobbiamo passare molte prove, per entrare nel regno di Dio». Sì, nel nome della nostra fede, l’abbé Tungumale Baba e gli altri fedeli che hanno trovato la morte a Fatima, hanno vissuto le loro prove e sono oggi nel regno di Dio.
Nel Vangelo proclamato Gesù diceva ai suoi discepoli: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non è alla maniera del mondo che ve la do. Che il vostro cuore non sia sconvolto né spaventato». Ecco un’altra frase profetica che descrive la situazione che viviamo. Tutti noi siamo sconvolti. Tutti noi siamo spaventati. Il nostro vivere insieme, la nostra coesione sociale, la nostra unità nazionale è stata violata e rimessa in questione dai nemici della pace.
L’ora è grave, perché la crisi è profonda e multidimensionale, con aspetti nascosti, di chi tira i fili, nell’ombra, e chi non ha alcuna considerazione per l’uomo. I nemici della pace hanno il loro piano; è per questo che dobbiamo essere vigilanti per non cedere ad alcuna manipolazione. Dobbiamo prendere le distanze e giocare il nostro ruolo di sentinelle, di vedette, di chi guarda lontano e agisce con prudenza e virtù.
Il discorso di papa Francesco durante la sua visita a Bangui, può aiutarci a capire la nostra crisi. Il papa afferma che la violenza è un’azione del diavolo; le persone cadono sotto il potere del male: «Tutte le nostre comunità soffrono indistintamente dell’ingiustizia e dell’odio cieco che il diavolo libera», diceva il santo Padre. Per conseguenza, noi siamo impegnati in una battaglia spirituale […]. Il diavolo si scatena contro di noi, perché siamo la capitale spirituale del mondo. La prima Porta santa del giubileo della misericordia, la terra benedetta da Dio. Noi andiamo a combattere e vincere con le armi della fede. Per questo facciamo nostre le raccomandazioni di san Paolo […].
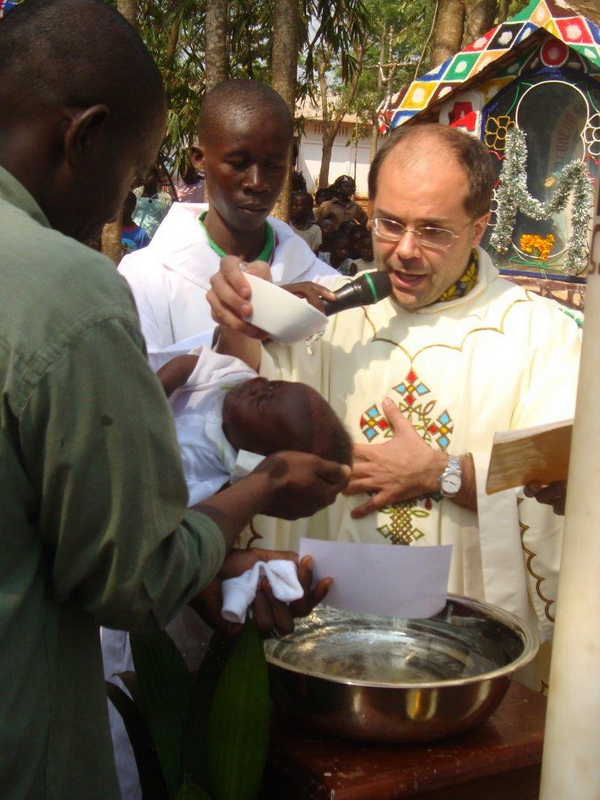
A coloro che ci governano noi esprimiamo la nostra riconoscenza per gli sforzi fatti nella formazione dei nostri militari. D’altronde noi vi lanciamo questo appello: prendete in maniera risoluta e determinata la vostra responsabilità. Il popolo soffre e chiede protezione. Domani rischia di essere tardi. Il nemico che abbiamo di fronte non ha pietà per nessuno. È pronto a colpire ad ogni occasione. Il ritardo nell’intervento ha lasciato il campo libero al nemico. Noi contiamo i nostri morti e i nostri feriti. Vi chiedo di rivedere il vostro sistema di difesa e la vostra strategia per un’azione coordinata ed efficace delle nostre forze di difesa nazionale.
Alla comunità internazionale, e in particolare alla Minusca (Missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione del Centrafrica, ndr): noi vi ringraziamo per la vostra presenza al capezzale della nazione centrafricana, e l’appoggio al processo di pace in corso. Ciò nonostante vogliamo attirare la vostra attenzione sulla lentezza degli interventi e la mancanza di professionalità di certi contingenti. Noi sappiamo che voi avete efficaci mezzi di comunicazione. Quando sentite il nostro Sos, per favore, venite presto per proteggerci e salvarci. E siamo convinti che Dio ci darà la forza di fare sempre meglio. Noi vi reiteriamo il desiderio della popolazione di vedere una buona coordinazione tra la Minusca e le forze di difesa nazionale. Assumetevi la vostra responsabilità, in nome di Dio.
Cari fratelli e sorelle, certo abbiamo perso dei cari membri della nostra famiglia, ma teniamo le testimonianze viventi del loro passaggio in mezzo a noi. […]
Figlio mio Baba, ci mancherai. Ho di te il ricordo di un pastore instancabile che amava il suo ministero. Un prete umile. Non una sola volta ti ho visto in collera. Tu accettavi volentieri gli scherzi dei tuoi confratelli. Il tuo amore per il sango (la lingua africana più diffusa, ndr) ci appassionava. Tu eri un prete coraggioso. Amavi l’Eucarestia e la celebravi ogni giorno. In carica nella Commissione diocesana giustizia e pace, operavi per il dialogo interreligioso e per la pace. Hai fatto la scelta di abitare in una casa molto vicina alla tua parrocchia, anche se questa abitazione era vicina a Km5. Sì, figlio, tu hai vissuto quello che predicavi.
Il Signore ti ha dato la grazia. Hai trovato la morte durante la celebrazione dell’Eucarestia che amavi. Il Vangelo proclamato quel giorno parlava della pace per la quale tu operavi. Fedele servitore, entra nella gioia del tuo maestro. […] Non dimenticarti della tua famiglia. Due giorni prima di morire, a un funerale, all’omelia dicevi di non aver paura della morte, ma di considerarla come un’amica, perché ci permette di vedere Dio. […]
Liberamente tradotto da Marco Bello
![]()
![]()
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=EZutxP5mo6I?start=2&feature=oembed&w=500&h=281]
















