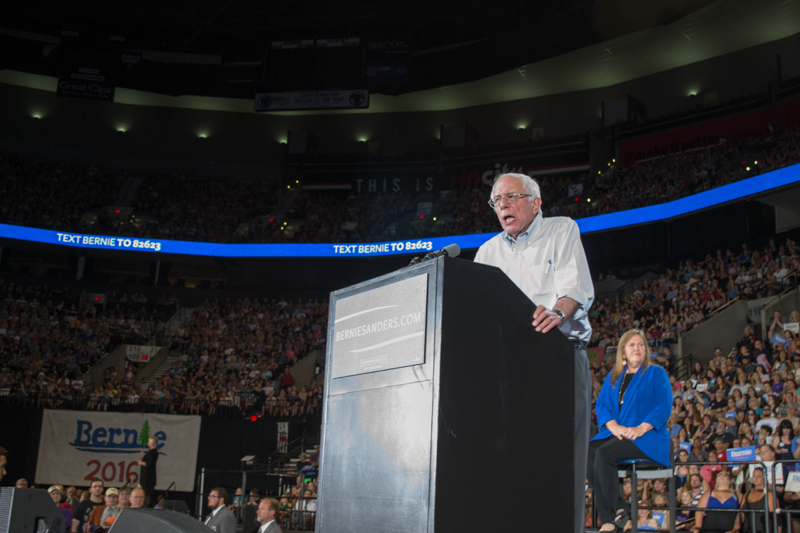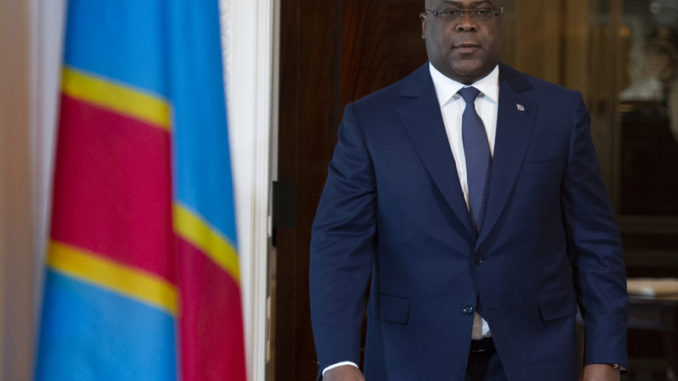Esplorare lo spazio è uno spreco?
Testo di Piergiogio Pescali
Sono passati 50 anni (1969-2019) dall’arrivo del primo uomo sulla Luna. In questi decenni la «corsa allo spazio» è cambiata e si è allargata ad altri attori. La domanda però è sempre la stessa: è giusto spendere miliardi di dollari per esplorare lo spazio quando l’uomo non ha ancora risolto i problemi di sopravvivenza e convivenza sulla Terra? Con questa inchiesta cercheremo di fornire ai nostri lettori gli elementi conoscitivi per arrivare a una risposta.
ll cinquantesimo anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna è stato salutato con numerose commemorazioni e non solo da parte di istituzioni governative e scientifiche. Accanto a queste, però, si è nuovamente levato un interrogativo che, sin dagli anni Sessanta, ha stimolato un dibattito destinato ancora oggi a rimanere senza risposta: è giusto spendere miliardi di dollari per esplorare lo spazio quando l’uomo non ha ancora risolto i problemi di convivenza civile sulla Terra?
La domanda, chiara e diretta, non può avere un riscontro altrettanto univoco per il semplice motivo che si sta parlando di due attività e argomenti ben distinti e separati. È però possibile, proprio partendo dalla polemica innescata dai movimenti di contestazione, intersecare e spiegare che spendere una tal quantità di denaro, alla fine porta beneficio all’intera umanità, compresi quei paesi e quei popoli che, nel contesto della Guerra fredda, venivano chiamati Terzo e Quarto Mondo.

Dallo spazio, tanti vantaggi quotidiani
I viaggi nello spazio non ci hanno portato solo conoscenze più approfondite sull’Universo e nuove risposte sul nostro passato e sul nostro possibile futuro. A parte la famosa foto della Terra che sorge dalla Luna ripresa dall’Apollo 8 il 24 dicembre 1968, considerata dalla rivista Life come una delle fotografie ambientaliste più influenti della storia dell’umanità, sono moltissimi i vantaggi che quotidianamente, senza che neppure ce ne accorgiamo, abbiamo dalla ricerca spaziale: dall’abbigliamento per proteggerci dalle temperature calde e fredde, ai Gps, dagli smartphone alle lenti antigraffio.
Altrettanto importanti a livello globale sono le riprese fotografiche e video che ci pervengono costantemente dalle centinaia di satelliti che orbitano attorno al nostro pianeta. Sono immagini che aiutano a prevedere e a monitorare disastri causati dalla natura e dall’uomo aiutando una più efficiente attività di soccorso e di protezione. È accaduto nei terremoti di Haiti, nel disastro di Fukushima, negli incendi delle foreste in varie parti del mondo, nelle alluvioni.
Sono le informazioni che ci provengono dallo spazio a darci quotidianamente lo stato della condizione ambientale della Terra. Pensiamo ad esempio ai dati che vengono forniti dagli istituti di ricerca sui cambiamenti climatici e le loro conseguenze: in condizioni normali sarebbero solo semplici numeri di difficile comprensione per chi non abbia dimestichezza con essi o con la statistica. Le riprese inviateci dai satelliti trasformano questi numeri in realtà visive rendendo più fruibile e immediata la visione globale del disastro climatico a cui stiamo andando incontro. Non solo, ma grazie alle immagini all’infrarosso dei satelliti è stato possibile trovare falde acquifere sotterranee in regioni aride del Sudan, in Kenya e Afghanistan avviando programmi agricoli che oggi sostengono migliaia di famiglie.
La ricerca spaziale è stata determinante anche nello sviluppo medico: la sterilizzazione delle camere operatorie, la risonanza magnetica, le protesi o la microchirurgia per operare piccole parti di organi umani sono tutte tecniche sviluppate grazie all’esplorazione dello spazio.
Secondo uno studio della Nasa (National aeronautics and space administration), l’implementazione tecnologica dei risultati delle ricerche spaziali limitati al solo ente statunitense, dal 2000 ad oggi avrebbe creato direttamente 19mila nuovi posti di lavoro, profitti per 5,2 miliardi di dollari, una riduzione di costi di gestione per 18,6 miliardi e salvato le vite a 450mila persone.
L’Esa (European space agency, Agenzia spaziale europea) invece, tra il 1995 e il 2016 avrebbe prodotto ricchezza per 14,6 miliardi di euro (contro un finanziamento di 8 miliardi). Oggi si calcola che ogni euro speso nella ricerca spaziale dall’Esa genererebbe 2,3 euro di profitto nell’economia europea.

Terzi incomodi spaziali: l’Italia e altre sorprese
Al tempo stesso, però, nel corso dei prossimi decenni, la corsa allo spazio rischia di diventare una nuova guerra commerciale riservata a quelle nazioni che oggi investono più risorse nel campo della ricerca.
Almeno fino alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, la corsa allo spazio è stata appannaggio di due sole nazioni: Stati Uniti e Unione Sovietica. Il crollo del Muro di Berlino, oltre a sovvertire il mondo economico, sociale e politico, ha cambiato anche le regole d’ingaggio della ricerca spaziale. La rivoluzione geografica ha ridisegnato i confini e alcune nazioni, come la Russia, hanno dovuto stipulare trattati con nuove entità politiche per continuare a lanciare i propri vettori nello spazio. Altri, come l’Agenzia spaziale europea, utilizzano da decenni dipartimenti d’oltremare, in questo caso la Guyana francese, in cui sin dagli anni Ottanta la Francia aveva costruito il proprio centro spaziale. L’Italia è sempre stata all’avanguardia nell’esplorazione spaziale: il nostro paese è stato il terzo al mondo, dopo Usa e Urss, a lanciare un satellite in orbita ed ancora oggi l’Università La Sapienza di Roma è proprietaria di una base di lancio (ancora potenzialmente operativa, ma inutilizzata dal 1988) e di un centro spaziale («Luigi Broglio») off shore al largo delle coste kenyote (Malindi).
Oggi sono più di settanta le nazioni i cui governi hanno istituito agenzie spaziali e tra queste troviamo paesi che mai ci aspetteremmo di elencare nella lista dei programmi dedicati allo spazio: Indonesia (dal 1964), Bangladesh (1980), Mongolia (1987), Nigeria (1988), Vietnam (2006), Venezuela (2008), Bolivia (2012) e altri ancora. Gli ultimi arrivati, in ordine di tempo, sono Arabia Saudita e Filippine, che nel 2019 hanno inaugurato istituti di ricerca spaziale nazionali. Alcuni stati comunemente annoverati tra quelli economicamente meno sviluppati hanno anche propri satelliti in orbita (Nord Corea, Filippine, Bolivia, Venezuela, Colombia, Vietnam, Nigeria, Marocco, Indonesia), mentre altri hanno già inviato astronauti su stazioni spaziali internazionali (Vietnam, Indonesia, India, Brasile, Messico).
La rivoluzione spaziale è iniziata sin dagli anni Ottanta quando istituti universitari, sulla spinta del Programma sulle applicazioni spaziali lanciato dalle Nazioni Unite nel 1982, iniziarono dei corsi dedicati a studenti provenienti da paesi in via di sviluppo. Nigeria, Marocco, Turchia, Algeria, India furono i primi a rispondere, ma in breve numerose altre nazioni capirono quanto fosse importante partecipare con le proprie forze alla ricerca spaziale.
Insomma, lo spazio, pur essendo ancora un ambiente dominato dai pochi grandi giganti economici mondiali (Usa, Russia, Europa), è sempre meno monopolizzato da questi.

La Cina sulla luna
È pur vero però che un conto è organizzare e allestire un’agenzia che collabora alla ricerca spaziale, un altro è partecipare attivamente ai programmi di colonizzazione e di sfruttamento dello spazio.
Nel dicembre 2013 ha fatto scalpore l’invio del lander cinese Chang’e 3 sulla superficie lunare, in quanto era la prima volta che un oggetto terrestre che non fosse statunitense o russo atterrava sul nostro satellite rimanendo operativo (il 14 novembre 2008 l’India era stata la prima nazione dopo Usa e Russia a inviare un manufatto sulla luna facendolo intenzionalmente impattare al suolo confermando la presenza di acqua rivelata nel 1976 dai sovietici).
In altri contesti l’avvenimento cinese avrebbe avuto ben altra risonanza, ma il fatto che una potenza emergente considerata – a torto o a ragione – fautrice di un’economia anarchica, aggressiva e sprezzante di ogni regola che tuteli i diritti dei lavoratori, avesse raggiunto la capacità di deporre un lander e un rover sulla superficie lunare, destò più preoccupazione che ammirazione.
Nonostante Washington e Mosca avessero da tempo pensato di trarre profitto dallo sfruttamento di oggetti celesti, la presenza di un terzo incomodo come la Cina avviò una serie di speculazioni sulla colonizzazione dello spazio e dell’Universo più in generale che attecchirono profondamente sviluppando una serie di dibattiti.

Corsa alla colonizzazione
Esistono diversi trattati internazionali, stipulati tra il 1967 e il 2000, che regolano lo sfruttamento delle risorse naturali situate nello spazio. In questi si vieta ai singoli stati o enti privati di prendere possesso di qualsiasi corpo celeste, di installare impianti nucleari o di distruzione di massa. Con l’intensificarsi delle esplorazioni spaziali e l’aumento delle agenzie private inserite nel contesto (noi conosciamo principalmente la SpaceX di Elon Musk, ma ve ne sono circa altre trecento che operano nello stesso campo), in un prossimo futuro si renderà necessario approntare una legislazione più stringente. La geopolitica e le relazioni internazionali avranno sempre più a che fare con materie spaziali.
Ecco quindi che, mentre enti governativi come la Nasa e le altre undici agenzie spaziali statunitensi sono incoraggiate a sviluppare tecnologie che permettano loro di divincolarsi dai sovvenzionamenti pubblici, la spesa della ricerca spaziale nei paesi in via di sviluppo è più che raddoppiata tra il 2000 e il 2012, passando da 35 a 73 miliardi di dollari.
La corsa allo sfruttamento dello spazio è iniziata e promette di essere feroce quanto lo è stata quella dell’accaparramento delle risorse sulla Terra. La Nasa stima che solo i 9mila asteroidi che orbitano attorno alla Terra, potrebbero fruttare ciascuno tra uno e mille miliardi di dollari; la Luna è ricca di elio-3, isotopo che diverrà importantissimo quando, tra qualche decennio, sarà possibile ottenere la fusione nucleare considerata la risorsa energetica del futuro e in cui molti paesi stanno investendo sempre più risorse, mentre la corsa a Marte è sempre più affollata di contendenti che giocano anche sul low-cost con l’India che fa da capofila. La missione «Mars Orbiter Mission» dell’Isro (l’agenzia spaziale indiana) che è entrata nell’orbita di Marte nel settembre 2014 è costata solo 73 milioni di dollari, ma – come ha candidamente confermato lo stesso presidente dell’ente -, il risparmio è stato ottenuto con lunghi ed estenuanti orari di lavoro, una forte diminuzione di test a terra e tagli tecnologici. Se questa è la via che vogliono intraprendere i nuovi arrivati sarà molto difficile che possano competere con la sofisticata tecnologia, i livelli di sicurezza e i diritti dei lavoratori autoimpostisi da agenzie storiche come la Nasa e l’Esa o la stessa Roscosmos (l’agenzia spaziale russa).
Per competere economicamente con la nascente industria spaziale dei paesi emergenti, nel 2015 l’amministrazione Obama ha aggiornato lo Space Act per aumentare la competitività dello sfruttamento delle risorse spaziali (incluse acqua e minerali) anche nel settore privato, concedendo alle aziende il diritto di uso e utilizzo di pianeti e asteroidi.
Naturalmente la decisione del governo statunitense è stata oggetto di discussioni e di scontri a livello internazionale in quanto violerebbe il Trattato sullo spazio extra-atmosferico stipulato nel 1967. Questo accordo, accettato da 129 paesi, stabilisce che nessuno stato può arrogarsi il diritto di rivendicare sovranità e risorse di alcun corpo celeste; al tempo stesso, però, non proibisce ad alcuno di poter sfruttare in modo temporaneo le stesse. Il risultato è un elastico legislativo che può essere manipolato dalle nazioni e dai singoli attori privati a proprio piacimento. Basta che nessuno pianti una bandiera o un logo su un oggetto spaziale affermando di possederlo e il gioco è fatto.
La confusione delle leggi sulla colonizzazione umana dello spazio è ben esemplificata dagli impressionanti numeri di oggetti che circolano sulle nostre teste: attorno al nostro pianeta ruotano circa 128 milioni di detriti spaziali più piccoli di 1 centimetro, 900mila oggetti grandi tra 1 e 10 centimetri e 34mila oggetti maggiori di 10 centimetri.
![]()
Dallo Sputnik al Voyager
Dal 4 ottobre 1957 quando l’Urss lanciò il primo satellite artificiale – si chiamava Sputnik 1 – attorno all’orbita terrestre, l’uomo ne ha fatta di strada. Oggi la sonda lanciata dall’uomo più distante dalla Terra (Voyager 1) ha raggiunto lo spazio interstellare a 22 miliardi di chilometri dal Sole. Proprio questa sonda nel 1990 e a sei miliardi di chilometri dalla Terra scattò un’altra memorabile fotografia che è passata alla storia con il titolo datole da Carl Sagan di «Pale blue dot», pallido puntino azzurro. A molti quest’immagine non dirà molto: la Terra è un puntino di 0,12 pixel dispersa in una delle bande colorate dovute alla rifrazione della luce sulla lente della macchina fotografica. Ma proprio questa sua insignificante presenza ci permette di comprendere quanto sia delicato il nostro mondo. Quel Pale blue dot, quel pallido punto blu visto dalla periferia del nostro sistema solare a 22 miliardi di chilometri dal Sole, risulta ancora più irrilevante se rapportato all’intero Universo il cui diametro osservabile è pari a circa 8,8×1023 chilometri (880mila miliardi di miliardi di chilometri).
Su quel minuscolo, microscopico puntino disperso e sospeso nello spazio quasi otto miliardi di persone devono convivere assieme ad altre centinaia di specie vegetali e animali. Come disse Sagan, commentando quel Pale blue dot: «Non c’è nessun altro posto, per lo meno nel futuro prossimo, dove la nostra specie possa migrare (…). Vi piaccia o meno, per il momento la Terra è il luogo dove ci giochiamo le nostre carte».
È tutta nostra convenienza trattarla bene.
Piergiorgio Pescali
(prima parte – continua)