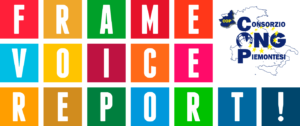Testo e foto di Paolo Moiola e Marco Bello |
Reportage dal centro autogestito dei migranti venezuelani
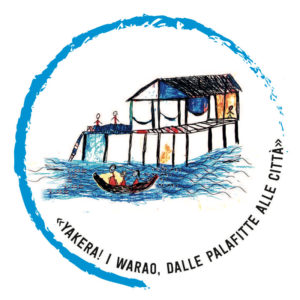 Nella capitale dello stato di Roraima (Brasile), alcune centinaia di migranti venezuelani di etnia warao, rifiutati dalle agenzie Onu, si sono organizzati dal basso e hanno creato un’esperienza unica di convivenza e resilienza. A fianco dei migranti non indigeni e superando varie difficoltà.
Nella capitale dello stato di Roraima (Brasile), alcune centinaia di migranti venezuelani di etnia warao, rifiutati dalle agenzie Onu, si sono organizzati dal basso e hanno creato un’esperienza unica di convivenza e resilienza. A fianco dei migranti non indigeni e superando varie difficoltà.
Boa Vista. Estrema periferia della città. Superata una scuola militare, arriviamo davanti a uno spazio chiuso da reti e muri. Varcato un cancello semi divelto, abbiamo subito l’impressione di entrare in un piccolo mondo a parte.
Alla nostra destra si erge un ex palazzetto sportivo costituito da due gradinate che circondano lo spazio di gioco in cemento, il tutto coperto da una tettoia di lamiera. Notiamo subito che, sui gradini, sono accumulate, borse, valigie, asciugamani e indumenti vari, utensili, suppellettili e oggetti casalinghi di ogni tipo. Tutto è posizionato con grande ordine. A terra, a fianco delle gradinate, ci sono dei materassi e anche un vecchio letto. Alcune amache sono appese alle colonne della struttura. Sul terreno da gioco è stata sistemata qualche tenda da campeggio. Il tutto ricorda un grande accampamento. Ai lati della struttura sono stesi dei teloni con l’inconfondibile scritta e logo dell’Unhcr-Acnur, l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
Proseguiamo quasi in punta di piedi, cercando di non invadere gli spazi con le nostre videocamere e fotocamere, come troppo spesso fanno i giornalisti. Però non possiamo diventare invisibili. Qua e là tanti bambini si rincorrono e giocano. Parecchi di loro si fermano a guardarci incuriositi. Mentre nei pressi di alcuni alberi ci sono dei focolari accesi con pignatte annerite appoggiate sopra.
Di fronte a noi e ai lati varie casette, meglio dire baracche, realizzate con materiali di recupero, cartoni, assi di legno, lamiere, danno al luogo un’aria di villaggio. Ci sono cartelli scritti a mano: «Si riparano biciclette», «Lavaggio». C’è pure un negozietto che vende piccole cose di utilità quotidiana, proprio come si fosse in un quartiere.
Siamo a Ka Ubanoko, che – ci viene spiegato – nella lingua dei Warao significa «dormitorio comune». Si tratta di un centro sportivo mai terminato e poi abbandonato, del quale sono rimaste in piedi diverse costruzioni tra cui un palazzetto, una piscina e altre strutture.
Ci accompagna padre Oscar Liofo, missionario della Consolata congolese, che da alcuni mesi segue la gente di Ka Ubanoko. In questo spazio occupato e autogestito (come capiremo in seguito) vivono oggi in 639, tutti migranti venezuelani, di cui 150 famiglie indigene, quasi tutte warao, ma anche altre etnie (E’ñepa, Cariña, Pemon), e 76 famiglie non indigene.
Padre Oscar ci guida dentro Ka Ubanoko, verso una zona di tende piantate sotto una tettoia di cemento. Anche qui ogni angolo è diventato un focolare domestico nel quale vive una famiglia, fianco a fianco con la famiglia vicina. Il missionario conosce tutti, saluta, fa battute in portoghese e gli viene risposto in spagnolo.

Fiorella, medico e leader
 Padre Oscar ci conduce da Fiorella Ramos, medico internista, indigena warao, «coordinatrice» di Ka Ubanoko. Parla spigliata Fiorella, ha 37 anni e due figli. In Venezuela era direttrice di un ospedale, e in contemporanea faceva visite private. «Con quello che guadagnavo riuscivo appena a comprare da mangiare, intanto correvo da un lavoro all’altro, senza poter stare con la mia famiglia e non restava nulla per aiutare i miei genitori. Nel 2018 ho deciso di partire, ma ci ho messo un anno a prepararmi psicologicamente e a mettere da parte i soldi». È stata una scelta difficile, confessa Fiorella, lasciare i parenti, parte della famiglia, un buon lavoro, il proprio paese. La sua è però una storia condivisa con molti connazionali.
Padre Oscar ci conduce da Fiorella Ramos, medico internista, indigena warao, «coordinatrice» di Ka Ubanoko. Parla spigliata Fiorella, ha 37 anni e due figli. In Venezuela era direttrice di un ospedale, e in contemporanea faceva visite private. «Con quello che guadagnavo riuscivo appena a comprare da mangiare, intanto correvo da un lavoro all’altro, senza poter stare con la mia famiglia e non restava nulla per aiutare i miei genitori. Nel 2018 ho deciso di partire, ma ci ho messo un anno a prepararmi psicologicamente e a mettere da parte i soldi». È stata una scelta difficile, confessa Fiorella, lasciare i parenti, parte della famiglia, un buon lavoro, il proprio paese. La sua è però una storia condivisa con molti connazionali.
L’8 gennaio 2019 Fiorella parte con la sorella e Fernando, il figlio più piccolo. Il viaggio dal Venezuela al Brasile non è pericoloso né troppo caro, anche se è molto stancante e, se non hai i documenti in regola, devi seguire strade alternative per passare la frontiera.
Fiorella e il suo gruppo arrivano a Boa Vista, capitale dello stato brasiliano più settentrionale, Roraima, la sera del giorno dopo. «Mio fratello – racconta – stava vivendo nell’abrigo (rifugio letteralmente, campo profughi in questo caso, ndr) chiamato Pintolandia, per cui speravamo di poterci sistemare lì, ma ci dissero che non potevamo entrare senza permesso. Ci accampammo non lontani per la strada, dove c’era già una famiglia indigena. Abbiamo vissuto 19 giorni riparandoci sotto le tettoie di una struttura locale. In quel periodo abbiamo chiesto almeno tre volte di entrare a Pintolandia, ma non ci lasciarono, dicendo che era pieno». Altre famiglie si uniscono e il gruppo in strada arriva a contare 38 persone. «Usavamo i bagni di una stazione di benzina non lontana, l’acqua la prendevamo da un rubinetto a cui si poteva accedere. Di giorno dovevamo stare in un parco lì vicino seminascosti, mentre di notte dormivamo sotto delle tettoie. Mio fratello riusciva a portarci del cibo cotto da dentro l’abrigo».
Del gruppo fa parte anche Anibal Pérez, un Warao della comunità di Mariusa. Tra lui, Fiorella e sua sorella nasce un’intesa e i tre, pensando al futuro, iniziano a scrivere un progetto di «Sviluppo integrale», come lo definisce il medico. È l’embrione di Ka Ubanoko. «Nel progetto si pensava a un’organizzazione, si parlava di salute, educazione, economia e infrastrutture. È in quel periodo che conoscemmo padre Jaime Patias e Luis Ventura, entrambi della Consolata, che iniziarono ad appoggiarci con alimenti e materiale per l’igiene personale. Anche quelli dell’Acnur venivano, ma dicevano che non potevano accoglierci nel centro». Intanto continua ad arrivare gente dal Venezuela, e anche indigeni espulsi da Pintolandia: «Eravamo ormai 150 famiglie».

Miracolo a Boa Vista
Poi accade una specie di miracolo. «Un brasiliano informò il cacique Wilson, uno di noi, che non lontano da dove eravamo accampati c’era un grande spazio abbandonato, un club sportivo in rovina, dove avrebbero potuto sistemarsi molte persone».
Un’avanguardia va a visitare il posto. All’epoca è invaso da arbusti ed erba alta. Vi sono nascoste tre famiglie venezuelane non indigene. Il centro è anche luogo di passaggio di malviventi e vi accadono cose strane. Ma la decisione è ormai presa: Fiorella e Anibal guidano il gruppo a prendere possesso di quel luogo. È il 3 marzo 2019, e per Fiorella e i suoi sono ormai due mesi di vita trascorsi all’addiaccio. Appena arrivati, i migranti iniziano a ripulire l’intera area e a dividersi gli spazi.
Fiorella e Anibal portano in questo luogo il modello che avevano pensato nel progetto di sviluppo e che avevano iniziato ad applicare dove erano accampati. «Già sulla strada avevamo sperimentato questa organizzazione. Anche perché erano iniziate ad arrivare donazioni da alcuni enti, ed è stato necessario formare gruppi per evitare conflitti e soprusi».
L’organizzazione si basa su un coordinamento centrale con una coordinatrice eletta, Fiorella, e una vice coordinatrice, Alida Gomez, anch’essa Warao. Le famiglie sono divise in gruppi, normalmente secondo la comunità di origine, che fanno capo a dei responsabili anch’essi eletti, detti cacique («capo», nel mondo indigeno). I cacique sono cinque, di cui quattro warao e una criolla (come vengono chiamati i non indigeni). C’è poi un’organizzazione per settore, tramite comitati, su tutto quello che è fondamentale per la comunità: educazione, pulizia, salute, alimentazione, sicurezza, sport, protezione del bambino e della donna, infrastrutture.
Eppure, la convivenza tra i vari gruppi non è così facile come sembra. Tra gli abitanti di Ka Ubanoko talvolta scoppiano dei conflitti. «Da quando siamo qui, ci sono stati cinque scontri fisici. Quando avvengono, si cerca di regolarli tramite i cacique dei gruppi di appartenenza dei soggetti coinvolti – ci spiega Fiorella -. Alcuni capiscono, altri no. In questo caso siamo costretti ad espellerli». A volte poi ci sono incomprensioni tra indigeni e non indigeni, soprattutto a causa dell’inevitabile distanza culturale.
Fiorella ci mostra dove abita. È un’abitazione improvvisata fatta di materiali di recupero, eretta nella zona perimetrale del centro sportivo, normalmente abitata dai non indigeni. Ci vive insieme a parte della sua famiglia.
Sopravvivere
Torniamo verso il palazzetto vicino all’ingresso. Qui, sulle gradinate, hanno il loro «angolo» Alida Gomez e suo marito.
 Alida viene da Tucupita (capoluogo del Delta Amacuro), è una signora di una certa età, con tre figli grandi rimasti in Venezuela. A casa faceva l’insegnante, ma poi ha deciso di partire: «Il Venezuela sta vivendo una situazione molto difficile in tutti gli ambiti: economia, educazione, salute. Ho preso la decisione personale di venire in Brasile per aiutare la mia famiglia – ci confida -. Speravo di poter trovare un lavoro rapidamente, ma la realtà è ben diversa. Essere indigena, avere la nostra cultura, significa essere respinti in tutti gli ambiti qui. Non abbiamo l’appoggio di nessuno, siamo soli». Oggi Alida aiuta la comunità facendo la vice coordinatrice di Ka Ubanoko, ma la vita a Boa Vista è molto dura. «Usciamo prima dell’alba e andiamo in giro a cercare rifiuti che si possono vendere, come le lattine di alluminio. Prendiamo anche i vestiti in buone condizioni. Mettiamo insieme più giorni di raccolta e vendiamo il metallo. In questo modo guadagniamo qualche decina di reais (la moneta brasiliana, ndr) che ci serve per comprare cibo. I vestiti recuperati li laviamo con il cloro. Se ci servono li usiamo, altrimenti li regaliamo ad altre famiglie». In effetti, in tutto Ka Ubanoko, in mezzo agli effetti personali portati dal Venezuela, si notano molti oggetti di recupero, trovati nei cassonetti della città brasiliana.
Alida viene da Tucupita (capoluogo del Delta Amacuro), è una signora di una certa età, con tre figli grandi rimasti in Venezuela. A casa faceva l’insegnante, ma poi ha deciso di partire: «Il Venezuela sta vivendo una situazione molto difficile in tutti gli ambiti: economia, educazione, salute. Ho preso la decisione personale di venire in Brasile per aiutare la mia famiglia – ci confida -. Speravo di poter trovare un lavoro rapidamente, ma la realtà è ben diversa. Essere indigena, avere la nostra cultura, significa essere respinti in tutti gli ambiti qui. Non abbiamo l’appoggio di nessuno, siamo soli». Oggi Alida aiuta la comunità facendo la vice coordinatrice di Ka Ubanoko, ma la vita a Boa Vista è molto dura. «Usciamo prima dell’alba e andiamo in giro a cercare rifiuti che si possono vendere, come le lattine di alluminio. Prendiamo anche i vestiti in buone condizioni. Mettiamo insieme più giorni di raccolta e vendiamo il metallo. In questo modo guadagniamo qualche decina di reais (la moneta brasiliana, ndr) che ci serve per comprare cibo. I vestiti recuperati li laviamo con il cloro. Se ci servono li usiamo, altrimenti li regaliamo ad altre famiglie». In effetti, in tutto Ka Ubanoko, in mezzo agli effetti personali portati dal Venezuela, si notano molti oggetti di recupero, trovati nei cassonetti della città brasiliana.
Alida continua a descriverci la vita quotidiana nel campo: «I bagni sono senza alcuna privacy. Sono senza porte, e pure insieme alle docce. L’acqua che beviamo è del filtro (ci sono due filtri con tre rubinetti ciascuno, installati da Acnur, per oltre 600 persone, ndr). Per cucinare e lavare usiamo l’acqua dell’acquedotto. Cuciniamo su fuochi con legna che recuperiamo in giro. Occorre fare sempre attenzione, perché qui ci sono molte mosche che portano malattie. Con la farina di grano facciamo arepas (delle specie di piadine, ndr). Mangiamo anche riso e salsiccia (wurstel di pessima fattura, ndr). Se abbiamo qualche soldo in più, compriamo del pollo o altra carne. Chi ha amici o parenti a Pintolandia, riceve talvolta del cibo avanzato da loro».
Anche la lingua può essere un problema. I venezuelani, indigeni e non, parlano lo spagnolo (qui detto castellano, ndr), mentre in Brasile devono imparare il portoghese. Alida, che è qui da quasi un anno, ammette di capirlo ma di non parlarlo.

Gli «amici» di Ka Ubanoko
Ka Ubanoko è quindi una grande realtà di migranti autogestita e autorganizzata. Nessuna delle agenzie delle Nazioni unite o delle grandi Ong, tantomeno il governo federale o dello stato di Roraima, o la municipalità di Boa Vista, la controllano e la gestiscono. Diversi enti intervengono con appoggi puntuali e specifici. Fiorella è molto brava a tenere le relazioni e si era già fatta conoscere dalle istituzioni quando il gruppo era accampato sui bordi della strada.
«Ci ha aiutato qualche istituzione civile e religiosa – ricorda lei -. Come la pastorale migranti della diocesi, le suore scalabriniane, i missionari della Consolata, la Caritas. E Ong come Medici senza frontiere e Adra».
Poco appoggio è invece arrivato da Acnur (i due purificatori già citati) e Oim (Organizzazione internazionale per le migrazioni). L’esercito brasiliano (che a Roraima controlla gli abrigos ufficiali come Pintolandia) è intervenuto ripristinando l’energia elettrica che il comune aveva tolto e mettendo in sicurezza la piscina (vuota) del centro sportivo.
«Cerchiamo di coinvolgere alcuni enti tramite progetti. I missionari della Consolata, ad esempio, sono attivi su un progetto di alimentazione, sia generale sia per i bambini. Con Fé e alegria (dei Gesuiti, ndr), abbiamo lavorato a un progetto di educazione, differenziato plurilingue, perché qui siamo di diverse etnie e lingue nazionali». Ci sono stati problemi perché Ka Ubanoko non è un posto ufficiale, anzi, è un’occupazione illegale, per cui molte attività non si possono realizzare sul posto, ma occorre appoggiarsi ad altri enti e luoghi. Come il progetto della Consolata che si svolge in un oratorio dei frati Cappuccini, poco distante.
«Con la Caritas abbiamo preparato un progetto di tipo economico: un appoggio per produrre artigianato e per l’agricoltura». Il progetto fornisce la materia prima e alcune donne confezionano prodotti artigianali che poi vendono. Mentre nel secondo caso dovrebbe fornire gli attrezzi per coltivare e le sementi, ma non è ancora partito.
Spiritualità migrante
Superato un campo in terra battuta usato per giocare a calcio o pallavolo, ci spostiamo verso la zona centrale di Ka Ubanoko, dove tante piccole tende a iglù sono appoggiate su un pavimento e riparate da un soffitto in cemento che pare precario. Innumerevoli fili corrono da tutte le parti con panni e vestiti colorati appesi ad asciugare.
 Qui incontriamo Leany Torres Moraleda, che coordina il comitato culturale e spirituale di Ka Ubanoko. Leany è una giovane mamma, 29 anni con una figlia di 8, originaria della comunità di Nabasanuka (nel delta del rio Orinoco, ndr), dove la sua famiglia è sempre stata impegnata al servizio dell’identità indigena. Suo papà e suo zio hanno ricoperto anche cariche politiche. È laureata in turismo e ha passato parte della sua vita in città, a Tucupita, dove insegnava nella scuola primaria. Allo stesso tempo era molto impegnata nella pastorale indigena della chiesa cattolica e con un gruppo culturale chiamato Eco Warao.
Qui incontriamo Leany Torres Moraleda, che coordina il comitato culturale e spirituale di Ka Ubanoko. Leany è una giovane mamma, 29 anni con una figlia di 8, originaria della comunità di Nabasanuka (nel delta del rio Orinoco, ndr), dove la sua famiglia è sempre stata impegnata al servizio dell’identità indigena. Suo papà e suo zio hanno ricoperto anche cariche politiche. È laureata in turismo e ha passato parte della sua vita in città, a Tucupita, dove insegnava nella scuola primaria. Allo stesso tempo era molto impegnata nella pastorale indigena della chiesa cattolica e con un gruppo culturale chiamato Eco Warao.
«Con mia figlia e mia nipote siamo partite a maggio e sapevamo già dell’esistenza di Ka Ubanoko. Arrivate a Boa Vista dopo un viaggio rocambolesco con un gruppo di altri indigeni, passammo la notte alla rodoviaria (la stazione degli autobus, dove c’è un centro di transito per migranti gestito dall’esercito, ndr), senza dormire. Quando riuscimmo ad arrivare a Ka Ubanoko, ad alcuni di noi parve molto brutto. La mia impressione invece fu positiva».
I primi tempi non sono stati facili. «La mia famiglia è conosciuta, così c’era qualcuno che non voleva vederci a Ka Ubanoko e ci diceva di andare a Pintolandia», racconta Leany. «Poi il cacique Camilo ci ha prese nel suo gruppo, e, vista la sua autorità, le acque si sono calmate».
Leany è sempre stata molto attiva nella promozione dei diritti e della cultura warao. Per questo si preoccupa subito della possibile perdita di identità, soprattutto dei bambini migranti. «In Ka Ubanoko stiamo lavorando con l’infanzia missionaria. E all’inizio abbiamo avuto delle incomprensioni con i criollos perché loro sostenevano che noi facciamo un’attività che li esclude. Abbiamo spiegato che la nostra visione è differente. Ovvero non è solo insegnare a pregare, insegnare la parola di Dio, ma stimolare i bimbi affinché conoscano la cultura warao, formino un sentimento di appartenenza, costruiscano un’identità».
Leany ci tiene a spiegare bene la propria filosofia: «In qualsiasi luogo noi siamo, non smetteremo mai di essere Warao: è nel nostro sangue. Anche se andremo in un altro stato del Brasile, fisicamente saremo uguali. Ci adatteremo alla società di questo paese, impareremo la lingua e avremo un lavoro. Ma saremo sempre indigeni. Qui a Ka Ubanoko stiamo facendo un buon lavoro, e ci siamo resi conto che i bimbi non indigeni, dopo aver ascoltato le canzoni e visto i balli warao, iniziano a cantare pure loro. Questo è molto importante. Bimbi warao che non parlavano la lingua madre, adesso iniziano a farlo. Il nostro impegno va molto più in là. Quello che ci unisce è che siamo venezuelani e siamo indigeni. Tuttavia, se non prendiamo in mano la situazione, la nostra gente smetterà di sentirsi indigena».
Ka Ubanoko è un’esperienza importante, anche se è difficile prevedere quanto durerà. Permette ai migranti di non cadere nell’assistenzialismo del campo profughi, di prendere in mano la propria vita e – allo stesso tempo – sentirsi parte di un qualcosa di organizzato, che protegge e permette di essere protagonisti. Per il bene comune.
Marco Bello e Paolo Moiola
(1.a puntata – continua)

Yakera!
La parola – «Yakera» – ci è subito piaciuta. Facile da pronunciare. Facile da ricordare. E, soprattutto, portatrice di un significato positivo. Gli indigeni warao la utilizzano in molte circostanze: per dire «va bene», ma anche per salutare.
I Warao sono l’etnia del delta dell’Orinoco, in Venezuela, che sta lasciando le proprie comunità per rifugiarsi in Brasile. Abbiamo percorso un pezzo del loro viaggio di migrazione (Boa Vista, Pacaraima, Santa Elena de Uairén, Manaus) e visitato i centri che li ospitano per cercare di capire dalla loro viva voce il perché di una scelta difficile, spesso drammatica. In questa indagine ci hanno aiutato i missionari della Consolata che da tempo lavorano con i Warao, sia in Venezuela che in Brasile.
M.B. – P.M.
Breve descrizione del popolo Warao
Un futuro senza canoe?
La gente delle canoe è nativa del delta dell’Orinoco. Oggi sono almeno 50mila, rappresentando la seconda etnia indigena del Venezuela.
I Warao costituiscono una delle principali etnie indigene del Venezuela. Per numero infatti sono il secondo gruppo più numeroso dopo i Wayú (Guajiro). Secondo il censimento del 2011, i Warao sarebbero 48.771, una cifra probabilmente sottostimata. Il loro nome è un’autodenominazione che significa gente (arao) di canoa o, secondo altri studiosi, gente delle terre basse. Gli indigeni chiamano i non Warao hotarao, gente delle terre alte. Sia in un caso che nell’altro il significato di Warao rimanda ai luoghi da essi abitati. Che sono i canali (caños) del delta dell’Orinoco nello stato Delta Amacuro e, dopo varie migrazioni, anche le aree adiacenti della Guayana Esequiba (un territorio conteso tra Guayana e Venezuela), nonché gli stati venezuelani di Bolivar, Monagas e Sucre.
Conoscere l’ambiente naturale in cui vivono i Warao è indispensabile per capire questo popolo. Anche se esso è cambiato e sta cambiando a causa dei mutamenti climatici e dei disastri prodotti dall’uomo e anche se una parte consistente dei Warao si è urbanizzata (soprattutto a Tucupita, capoluogo del Delta Amacuro) o è emigrata – non si sa se in maniera stabile o temporanea – in Brasile.
Come si diceva, la gran parte delle comunità tradizionali dei Warao è posta lungo i canali dell’Orinoco. Questo fiume, che nasce nella cordigliera di Parima (massiccio della Guayana), ha una lunghezza di 2.140 chilometri e una portata d’acqua imponente, seconda soltanto a quella del Rio delle Amazzoni. Prima di gettarsi nell’Oceano Atlantico, l’Orinoco forma un delta che raggiunge un’apertura di circa 400 chilometri. La vastità della regione deltica (circa 22.500 km2, poco meno della Toscana) determina diversità tra le comunità warao a causa dei maggiori o minori contatti con il mondo non indigeno (criollo) e delle diverse condizioni di ciascun microambiente. La vita è scandita dall’acqua. La stagione secca va da gennaio ad aprile, con molti canali che diventano salmastri. La successiva stagione delle piogge dura fino a settembre con una piena (detta creciente) che sommerge coste e isole del delta. Le case dei Warao – chiamate janoko, che significa il luogo della ja, l’amaca – sorgono lungo i canali, ma sono costruite su palafitte proprio per essere pronte a resistere alle maree. Per sopravvivere nel delta è necessaria una conoscenza precisa dell’ambiente naturale, che comunque oggi risulta meno gestibile e prevedibile di un tempo a causa dei mutamenti prodotti da fattori antropici (inquinamento delle acque fluviali e deforestazione, su tutto). Le attività tradizionali dei Warao sono la pesca (in particolare del morocoto o pirapitinga e dei granchi), la caccia e la raccolta di frutti silvestri. Ad esse si sono in seguito aggiunte alcune coltivazioni agricole, in primis quella del riso e poi la Colocasia Esculenta della quale vengono mangiati sia i tuberi (bolliti oppure grigliati) che le foglie (come verdure cotte). La pianta autoctona per eccellenza è la palma di moriche (conosciuta come palma di buriti in Brasile), una vera ricchezza della natura. Tutti i suoi componenti (foglie, frutti, semi, corteccia) sono infatti utilizzabili per fare prodotti di artigianato o come alimento. Dall’amido del moriche si ricava una farina (aru) che è alla base della dieta dei Warao.
Come sempre accade per i popoli indigeni, la cosmovisione e la vita religiosa dei Warao sono difficili da comprendere per i non indigeni. Quello che si può affermare è che tradizione orale e mondo magico-religioso sono strettamente legati all’ambiente naturale in cui essi vivono. La presenza e l’attività dei missionari sono cambiati nel corso del tempo, soprattutto in ambito cattolico. Dalla filosofia coloniale del «civilizzare l’indio selvaggio» si è passati a interventi nel campo dell’istruzione e della salute, rispettando i valori indigeni.
Negli ultimi anni, la situazione per le comunità warao si è complicata a causa della presenza di varie bande criminali che agiscono impunite lungo l’Orinoco trafficando con la droga, la tratta delle donne e il contrabbando di benzina.
Al momento, il futuro dei Warao non pare promettente. Molte comunità lungo l’Orinoco sono state abbandonate o si sono spopolate. Molti indigeni si sono urbanizzati, ma senza una vera integrazione con i criollos. Altri sono emigrati, ma si trovano a vivere in una condizione di isolamento e pura sopravvivenza. Una parte consistente dei Warao, popolo delle canoe, sembra dunque aver perso per sempre la ragione prima del proprio nome.
M.B. – P.M.

La voce del governo venezuelano
«I Warao si spostano perché nomadi»
A Boa Vista, non c’è semaforo o incrocio dove non ci sia un venezuelano. E gli indigeni warao si notano anche di più. Nella capitale di Roraima, abbiamo incontrato il console del Venezuela, per chiedergli i motivi di tanti migranti del suo paese e di tanti Warao per le strade delle città brasiliane.
Boa Vista. L’indirizzo è Av. Benjamin Constant 968, nel centro della città, capitale dello stato di Roraima. È una modesta casa su un solo piano, resa facilmente riconoscibile dal suo vivace color arancione e naturalmente dalla grande bandiera venezuelana che sventola sul pennone posto nel giardinetto antistante l’entrata.
A sorvegliare la sede consolare c’è una sola persona, una poliziotta brasiliana, seduta tranquillamente davanti a un tavolino a lato della porta d’ingresso. All’interno ci sono due impiegate e alcune persone in attesa. Sulla vetrata che separa le addette dal pubblico è appeso un foglio che informa del piano Vuelta a la patria: requisiti, documenti, condizioni. È un programma istituito dal governo di Caracas per tentare di far tornare a casa i migranti.
Il console si chiama Faustino Torella Ambrosini. Ci accoglie con cordialità ricordandoci subito le origini italiane: i suoi genitori arrivarono in Venezuela dalla provincia di Avellino. Prima di diventare diplomatico insegnava storia all’Università Centrale del Venezuela, il principale ateneo pubblico del paese. È console generale del Venezuela a Boa Vista dal dicembre 2018, dopo un’esperienza analoga di cinque anni a Manaus. Boa Vista non è una metropoli come quest’ultima ma è importante perché dista soltanto 215 chilometri da Pacaraima, porta d’ingresso in Brasile per molti venezuelani (indigeni inclusi) che infatti si vedono ad ogni incrocio, nei rifugi ufficiali (abrigos) e in quelli improvvisati.
Nello studio dove ci accomodiamo, accanto alla bandiera, il ritratto del presidente Maduro sta in mezzo a quelli, più piccoli, dell’eroe nazionale Simón Bolívar e di Hugo Chávez. Siamo qui per chiedere al console della migrazione dei Warao, ma non possiamo non iniziare dalla situazione generale del paese. Com’è?, domandiamo. «Difficile», risponde senza pensarci su un attimo. E aggiunge: «È la situazione che vivono i paesi e i popoli che soffrono a causa di un embargo illegale imposto da uno stato che si considera al di sopra di tutti gli altri. Il Venezuela è un paese la cui economia si fonda sul petrolio e con la valuta che ottiene dalla sua vendita compra alimenti e medicinali, come anche materie prime e prodotti industriali di uso comune. Non avendo libero accesso al mercato estero e ai nostri conti bancari in dollari, per il cittadino venezuelano la quotidianità si è fatta molto complicata».
Anche per la popolazione dei Warao. Il console parla di un numero di indigeni attorno alle 69mila persone, mentre l’ultimo censimento – risalente al 2011 – ne contava circa 49mila. Rispetto alla gravità del problema della loro migrazione, il nostro interlocutore minimizza. «Sono – ci spiega – una popolazione nomade e in quanto tale si muovono. Dal Delta Amacuro si sono distribuiti negli stati Monagas, Sucre, Bolivar, ma anche in Caracas, Valencia… Voglio dire che non è da oggi che stanno venendo in Brasile. Sono sempre venuti qui. In questo momento, semplicemente ne arrivano di più e si fermano più a lungo».
Chiediamo al console se i Warao abbiano lasciato i loro fiumi anche sulla spinta di fattori ambientali e invasioni di gruppi non indigeni. «Il mondo è cambiato ed è cambiato anche per i Warao. Le condizioni ambientali nel delta dell’Orinoco non sono certamente le stesse di un tempo, ma rimangono sostenibili. È possibile continuare a pescare e a seminare, soprattutto palme e frutta tropicale».
Facciamo notare al console come molte comunità warao lungo l’Orinoco e i suoi canali (i cosiddetti caños) si siano svuotate. «Abbiamo una popolazione che è indigena e vive nel proprio habitat e una popolazione indigena che è trapiantata in città. Lo dico perché molte persone che s’incontrano qui in Brasile sono indigeni urbanizzati. E poi vi chiedo: perché tra tutte le etnie indigene del Venezuela in Brasile arrivano soltanto i Warao? Perché – lo voglio ribadire – loro già venivano qui. Quasi tutti gli altri gruppi indigeni sono sedentari, nonostante l’embargo economico (che è la vera motivazione della migrazione dei venezuelani) valga per tutti».
Nomadi ma anche urbanizzati: sembrerebbe un ossimoro, o almeno una contraddizione in termini. Faustino Torella Ambrosini ribadisce i due concetti aggiungendo: «L’indigeno warao che è andato in città difficilmente torna indietro. Ha tutto il diritto di agire così: queste persone appartengono ai popoli tradizionali, ma sono anche venezuelani. E poi, in questo loro cambiamento, c’è un ministero che li aiuta».
Il console si riferisce al Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, attualmente guidato da Aloha Núñez, indigena Wayú (Guaijra). Cosa fa questo ministero?, gli chiediamo. «È stato creato per aiutare i popoli indigeni a integrarsi. A incorporarsi nella società venezuelana. Sempre con rispetto per la loro volontà». Incorporarsi come?, insistiamo. «Ad esempio, con la Gran mision vivienda para indigenas. Noi li aiutiamo a costruire le loro case utilizzando materiali e disegni tipicamente indigeni. Come per le palafitte». Il console ricorda anche l’esistenza di un’università, la Universidad indígena de Venezuela, istituita appositamente per gli indigeni negli stati Bolivar e Amazonas.
Chiediamo anche dell’operazione Vuelta a la patria pubblicizzata dal volantino affisso all’entrata. «È un progetto – spiega il diplomatico – del nostro governo per i venezuelani che non hanno avuto fortuna nei paesi – Ecuador, Perù, Panama, Colombia, Argentina e Brasile – dove sono emigrati e che vogliono tornare a casa. L’esecutivo favorisce il rimpatrio di queste persone. Hanno partecipato anche gli stessi Warao per una cifra importante: non meno di mille».
Mille indigeni che sono rientrati, tornando da dove erano partiti. Non possiamo verificare la veridicità di questo numero, a prima impressione piuttosto elevato. Il console Faustino Torella Ambrosini è un rappresentante ufficiale del governo di Caracas e, in quanto tale, non può che difenderne l’operato. A suo merito, va detto però che non è rimasto chiuso nella propria sede consolare, ma ha visitato di persona gli abrigos di Boa Vista (compreso quello spontaneo di Ka Ubanoko) e di Pacaraima, dove sono concentrati molti Warao. E gli indigeni ci hanno confermato sia la visita del console che la sua disponibilità.
Marco Bello – Paolo Moiola

Questo servizio rientra nell’ambito del progetto «The Warao Odissey» eseguito da Missioni Consolata Onlus e prodotto con il contributo finanziario dell’Unione europea e della Regione
Piemonte attraverso il bando «Frame Voice Report!» del Consorzio Ong Piemontesi.