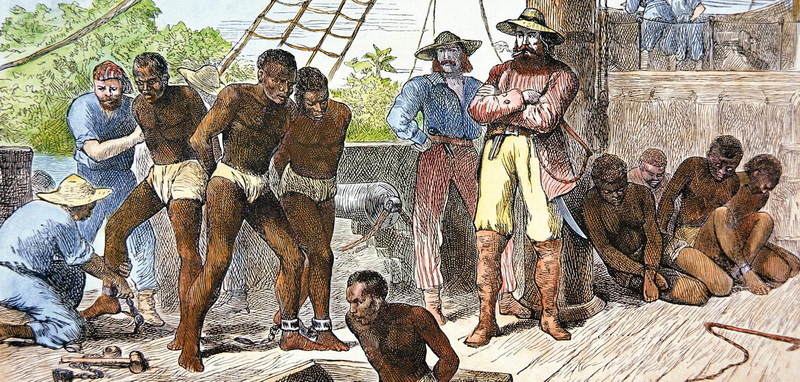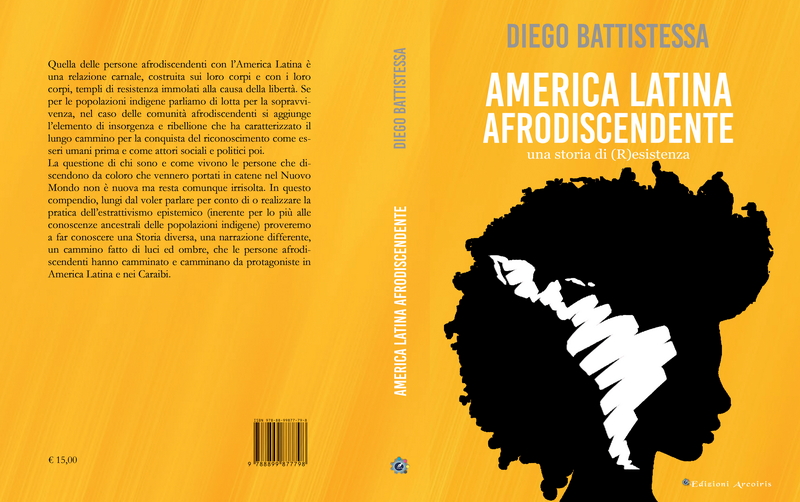Ucraina. Aggressione e resilienza
Per il presidente russo, l’Ucraina «non esiste» come stato autonomo. Un’affermazione smentita dall’incredibile resistenza degli ucraini all’invasione di Mosca. Una guerra – «operazione militare speciale», secondo i russi – che, dal 24 febbraio, ha cambiato il mondo.
Da mesi, la domanda che in tanti si ponevano era: ci sarà una guerra contro l’Ucraina o il presidente russo Vladimir Putin sta solo bluffando? La risposta è arrivata la notte del 24 febbraio, quando i convogli corazzati russi hanno attraversato il confine ucraino e i missili hanno iniziato a colpire prima obiettivi militari e poi civili. Mentre la guerra imperversava sempre più cruenta, tutti hanno cominciato a discutere sul perché. Speculazioni e mezze verità che non hanno senso se non si fa un passo indietro, analizzando il legame morboso che lega la Russia all’Ucraina e a come è nato il conflitto nel Donbass, dimenticato ma in atto da otto anni.

Un paese giovane con una storia secolare
La dissoluzione dell’Unione Sovietica, sancita ufficialmente nel dicembre del 1991, è stata sorprendentemente pacifica in Ucraina, che ha festeggiato il trentennale della propria indipendenza lo scorso 24 agosto. Festeggiamenti ormai dimenticati a causa dello scoppio di una nuova guerra, che sta lacerando questo paese giovane, ma dalla storia secolare e che, da Est a Ovest, si è ritrovato a lottare per rimanere unito sotto un’unica bandiera. L’Ucraina, infatti, non è nata ieri. Possiede da secoli un’identità propria, un sentito movimento nazionale e una profonda storia d’indipendenza che risale a ben prima dell’arrivo di Pietro il Grande. Un’identità che, spesso e volentieri, è stata vittima di deformazioni storiche: nonostante, infatti, ucraini e russi (insieme ai bielorussi) vengano da alcuni considerati fratelli inseparabili («un unico popolo», come ha sottolineato lo stesso Putin in un lungo scritto del 12 luglio scorso titolato «Sull’unità storica dei russi e degli ucraini»), i primi hanno una loro storia secolare e multiculturale, una loro lingua ufficiale e delle tradizioni culturali diverse da quelle dei secondi.
Tra «Russkij mir» e democrazia
Durante i primi 20 anni dalla dissoluzione dell’Urss, la Russia ha tenuto d’occhio gli sviluppi in Ucraina e ha interferito in vari modi nella politica interna del paese. Ma la presenza di una nutrita popolazione ucraina di lingua russa garantiva – o sembrava garantire – che il paese non si sarebbe mai allontanato troppo dalla sfera d’influenza russa, dal cosiddetto russkij mir («mondo russo»).
Tuttavia, il concetto di democrazia era già ben radicato nella mentalità e nella cultura politica del popolo ucraino, erede storico di quel particolare sistema statale dell’«etmanato cosacco» del XVII secolo (abolito da Caterina II di Russia nel 1764). Non sorprende, quindi, sapere che, al contrario della Russia, in Ucraina è sempre esistita un’opposizione. Senza equivoci, la politica ucraina era (e lo è tuttora) piena di conflitti interni: i cambi di potere e i rimpasti di governo sono stati tumultuosi in quanto riflettevano genuine differenze di opinione nella popolazione su ciò che l’Ucraina sarebbe dovuta essere e diventare. Inoltre, la mancata esperienza diretta di sistemi democratici ha minato la corretta applicazione dei principi di base (come la giustizia o la lotta alla corruzione e al clientelismo) soprattutto nei primi anni Novanta. Alcuni pensavano che il paese dovesse integrarsi ulteriormente all’Europa, altri che dovesse rimanere strettamente legata alla Russia. Una questione che ha portato prima alla «Rivoluzione della dignità» (nota anche come «Euromaidan», Europiazza) e, successivamente, a un conflitto ibrido nei territori orientali del paese, oggi trasformatosi in un bagno di sangue su scala nazionale.

La questione Donbass
L’Ucraina è in guerra dal 2014, ovvero dall’anno dell’annessione da parte della Russia della penisola di Crimea (avvenuta il 18 marzo dopo un referendum giudicato illegale a livello internazionale) e dello scoppio del conflitto nella regione più orientale del Donbass. Per otto anni, il paese è stato diviso da una linea del fronte lunga circa 400 km che separava, fino allo scorso febbraio, una parte dei territori del Donbass dalle autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk (Doneckaja narodnaja respublikae, Dnr, nella traslitterazione dal russo) e Luhansk (Luganskaja narodnaja respublika, Lnr), occupate dai separatisti armati e finanziati dal Cremlino. Si è sempre trattato, nei suoi otto anni, di un conflitto ibrido limitato a questi territori e poco noto internazionalmente, tanto che spesso veniva (erroneamente) considerato una guerra civile o addirittura una guerra tra clan mafiosi, data la grande presenza locale di potenti oligarchi.
Un conflitto definito «a bassa intensità» che, però, ha provocato migliaia di vittime e sfollati interni: dall’aprile 2014 e fino allo scorso dicembre, circa 13.300 morti (3.375 civili, 4.150 soldati ucraini e 5.700 separatisti). Vani sono stati i tentativi per trovare una soluzione diplomatica attraverso dei negoziati. Questi hanno visto protagonisti prima esclusivamente le due parti in causa – Russia e Ucraina (Accordi di Minsk del 2014) – e poi anche Francia e Germania («Quartetto Normandia»), in qualità di mediatori, nei cosiddetti Accordi di Minsk II del 2015. L’intento dei negoziati, svoltisi nella capitale bielorussa, era quello di concordare un cessate il fuoco bilaterale, effettuare scambi di prigionieri, fornire aiuti umanitari, demilitarizzare la zona e, soprattutto, decentralizzare il potere fornendo una maggiore autonomia alle regioni del Donbass e indicendo anche nuove elezioni sotto il monitoraggio dell’Osce. L’intesa, tuttavia, è fallita più volte a causa di ripetute violazioni del cessate il fuoco da entrambe le parti.
Uno dei maggiori ostacoli nell’adempimento dei negoziati è stata la mancata ammissione da parte della Russia di essere soggetto integrante del conflitto stesso: Kyiv ha sempre sostenuto che, nel Donbass, le forze armate separatiste provenissero anche da Mosca, ma la Russia ha sempre negato. Questa era la situazione fino allo scorso 22 febbraio, quando Vladimir Putin ha annunciato il riconoscimento ufficiale dell’indipendenza di Dnr e Lnr e ha cambiato le carte in tavola sulla scacchiera geopolitica internazionale.
Oggi, in seguito all’escalation e all’invasione russa, le parti sono tornate a fronteggiarsi apertamente, non solo violando il cessate il fuoco nei territori occupati e vicini alla linea di contatto, ma scatenando una guerra su larga scala e una crisi umanitaria di enormi proporzioni per l’Ucraina e per tutta l’Europa.

Il casus belli di Putin
Nel lungo discorso per giustificare il riconoscimento delle repubbliche secessioniste ucraine del Donbass, il presidente russo ha chiaramente detto che l’obiettivo principale del suo intervento militare in Ucraina è quello di «denazificare» il paese.
Per Putin, infatti, l’Ucraina sarebbe governata da un esecutivo di «drogati» e «neonazisti». Inoltre, ha sostenuto che, in Ucraina, sia in corso un vero e proprio «genocidio» nei confronti della popolazione russa e russofona, vittima dei nazisti al governo. Una descrizione della realtà infondata e assurda. Basta guardare ai numeri effettivi della presenza dell’estrema destra ucraina, alla popolazione che attualmente sta combattendo per la propria libertà, nonché al fatto che molti dei politici ucraini (come lo stesso presidente Zelenskyj) sono di madrelingua russa.
Come succede per ogni guerra, anche il conflitto in Ucraina ha dato origine a una sconcertante diffusione di verità parziali e a un controllo pedissequo della narrazione, soprattutto da parte dei media russi. L’affermazione di Putin, secondo cui la «Rivoluzione della dignità» del 2014 fu un «colpo di stato fascista» e l’Ucraina è uno stato nazista, è stata usata per anni come giustificazione per l’annessione della Crimea e il sostegno ai separatisti russofoni nell’Est del paese, guadagnando molto consenso anche sui social. Ma l’Ucraina è un autentico stato liberal-democratico, anche se imperfetto, con libere elezioni che producono significativi spostamenti di potere, compresa l’elezione nel 2019 del riformatore liberal-populista Volodymyr Zelenskyj. Inoltre, il partito che rappresenta i cosiddetti neonazisti non ha attualmente nemmeno un seggio in parlamento. L’Ucraina, quindi, non è assolutamente uno stato nazista, e il casus belli russo è l’ennesima bugia del Cremlino.
Le milizie ucraine di estrema destra

Stabilito questo, è vero che tra le milizie volontarie ucraine che partecipano a questa guerra ci sono anche quelle neonaziste. Tra queste, la più nota è il «battaglione Azov», un’organizzazione di estrema destra fondata da Andriy Biletskiy. Nato come gruppo paramilitare, nel 2014 il battaglione è stato inquadrato nella «Guardia nazionale ucraina», componente di riserva dell’esercito. Lo scopo principale di Azov era quello di contrastare le crescenti attività di guerriglia dei separatisti filorussi del Donbass. Il battaglione ha come base la città portuale ucraina di Mariupol’ (la più martoriata nel conflitto) ed è legato al progetto politico Nacional’nyj Korpus (Corpo nazionale) che partecipa alle elezioni e ha rapporti internazionali con altri gruppi di estrema destra. Nonostante tra il presidente Volodymyr Zelenskyj e il battaglione non scorra buon sangue, Azov combatte oggi in prima linea ed è molto utile al governo di Kyiv in quanto conosce bene il territorio, è ben organizzato e possiede capacità e conoscenze militari effettive.
Per ora, l’Ucraina e Zelenskyj hanno, quindi, bisogno delle capacità militari e dello zelo ideologico delle milizie nazionaliste e di estrema destra per combattere e vincere la battaglia per la sopravvivenza nazionale. Ma quando la guerra finirà, Zelenskyj e i suoi sostenitori occidentali dovranno stare attenti a non dare troppo potere a gruppi i cui obiettivi sono in netto contrasto con le norme basilari dei sistemi politici liberal democratici. Armare e finanziare Azov e compagni è una delle scelte difficili imposte dallo status di guerra, ma il loro disarmo dovrebbe essere una priorità a conflitto terminato.
Che significa neutralità?
Nessuno si sarebbe mai aspettato né un conflitto di tale portata, né una resistenza così motivata e organizzata da parte del popolo ucraino, caratteristica quest’ultima che ha colto tutti di sorpresa. Come sorprendente è stato il presidente Zelenskyj che, in Occidente e tra il pubblico internazionale, si è guadagnato un’immagine da vero eroe, un capitano che non abbandona la nave nel momento del bisogno ma che, al contrario, lotta con la propria gente.
Le truppe russe si sono trovate davanti un nemico «incapace» di arrendersi e di piegarsi all’aggressore. E Putin, che sperava di risolvere la questione ucraina con una guerra lampo, si è trovato a dover riformulare la propria strategia. Se prima il suo obiettivo principale era evitare che l’Ucraina si unisse a Ue e Nato per poterla tenere sotto la propria ala di influenza e, eventualmente, sostituire l’attuale governo, ai suoi occhi troppo filoeuropeo, con un team fidato, ora (mentre andiamo in stampa, a metà aprile, ndr) la sua priorità sembra essere quella di rendere il paese neutrale. Ma cosa significherebbe? Vorrebbe dire smilitarizzare l’Ucraina trasformandola in una nuova Austria o Svezia. Un’operazione che sarebbe, tuttavia, possibile esclusivamente in tempi di pace e in presenza di un cessate il fuoco, fattori assenti in questo momento: bombardamenti e assedi continuano in diverse città (Mariupol’, Sumy, Charkiv, Cherson) oggi completamente distrutte e dove i civili sono vittime di attacchi quotidiani.
Nel complesso, gli esperti sembrano essere d’accordo sul fatto che la neutralità è la strada da seguire. «Nel suo mondo ideale, Putin potrebbe aver sognato un’Ucraina unita alla Russia in un’unica forma statale, ma gli eventi delle ultime settimane hanno dimostrato che è un risultato altamente improbabile», ha commentato il prof. Graeme Gill, esperto di politica sovietica e russa, aggiungendo che «mentre c’è ancora un sostanziale sentimento filorusso in alcune parti del paese, l’invasione ha inasprito la visione dei russi da parte di molti ucraini».
La crisi dei migranti
Nel giro di un mese e mezzo oltre 4,5 milioni (su 41,5) di ucraini sono fuggiti; la maggior parte (2,6 milioni) ha trovato rifugio temporaneo in Polonia. Anche negli anni precedenti (a partire dal 2014) è stato questo paese ad accogliere oltre un milione di ucraini. Eppure, oggi, dopo una iniziale sincera catena di solidarietà che ha accolto i rifugiati a braccia aperte, nei media stanno emergendo domande su come i sistemi di assistenza sociale e sanitaria, già sovraccarichi, potranno reggere.
La guerra in Ucraina ha costretto uno stato conservatore per antonomasia come la Polonia ad abbandonare la sua rigida posizione anti rifugiati degli ultimi anni. Oggi il governo polacco ha aperto le frontiere a tutti gli sfollati provenienti dall’Ucraina, rivedendo le sue posizioni: un’accoglienza motivata tanto dalla paura della confinante Russia, quanto dalla compassione. Ma quanto reggerà?
Claudia Bettiol*
(*) Nata nel 1986, slavista di formazione, dopo un anno di studio in Russia, un Erasmus in Estonia e un volontariato nella città ucraina di Sumy, Claudia Bettiol si è trasferita a Kyiv dove, fino allo scoppio della guerra, lavorava come traduttrice e insegnante di italiano. Ha scritto per «East Journal» (eastjournal.net). Dal 2019 collabora con «Osservatorio Balcani e Caucaso» (balcanicaucaso.org).
![]()
La guerra di Putin e le divisioni della Chiesa ortodossa

Kirill, il patriarca con l’elmetto
Il patriarca di Mosca non ha voluto (o potuto) distinguersi dall’amico Putin. Il suo avvallo alla guerra in Ucraina è una scelta grave e densa di conseguenze.
Il presidente Putin e il patriarca ortodosso Kirill formano una coppia di guerra ben assortita: il primo ha il sogno di ricostituire una sorta d’impero zarista, il secondo di difendere l’idea della Santa Russia («Svjataja Rus»).
Pubblicamente, entrambi hanno come riferimento l’ideologia del Mondo russo («Russkii mir»). Segretamente, entrambi hanno (o avevano) l’ambizione di ampliare la rispettiva sfera di potere.
Sul tema, un nutrito gruppo di teologi ortodossi è intervenuto con una dichiarazione congiunta: «Questo “Mondo russo” – vi si legge – ha un centro politico comune (Mosca), un centro spirituale comune (Kyiv quale “madre di tutte le Rus’”), una lingua comune (il russo), una Chiesa comune (la Chiesa ortodossa russa, il Patriarcato di Mosca), e un patriarca comune (il Patriarca di Mosca) che lavora in “sinfonia” con un presidente/capo nazionale comune (Putin) per governare questo mondo russo, oltre che per sostenere una spiritualità, moralità e cultura comuni, distinte da quelle del mondo non russo». I firmatari concludono: «[Noi] respingiamo l’eresia del “Mondo russo” e le azioni vergognose del governo della Russia [compiute] con la connivenza della Chiesa ortodossa russa» (13 marzo 2022, domenica dell’ortodossia).
La conversione religiosa di Putin viene fatta risalire agli anni Novanta. Il suo padre spirituale sarebbe l’ultraconservatore vescovo Tikhon, oggi metropolita di Pskov. Tuttavia, le apparizioni pubbliche dello zar del Cremlino sono state e sono con il patriarca Kirill. Dopo l’invasione dell’Ucraina, i due si sono sostenuti a vicenda con dichiarazioni che, fuori della Russia, sono apparse sconcertanti. Durante il suo comizio allo stadio di Mosca (17 marzo), il presidente ha giustificato l’invasione citando un passo del Vangelo di Giovanni: «Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici». Per parte sua, il patriarca ha superato ogni immaginazione nel suo sermone di domenica 6 marzo. In esso Kirill ha giustificato l’intervento armato russo per proteggere i valori cristiani sulla sessualità e sul matrimonio, minacciati, egli sostiene, dalla cultura occidentale delle «parate gay». Anche nelle ore del massacro di Bucha, il patriarca di Mosca ha parlato in difesa dell’intervento russo (3 aprile).
Come il sodale Putin, pure Kirill, a capo della Chiesa ortodossa russa dal 2009, non ha però tutto sotto controllo. Dopo lo scisma ucraino del 2018 (7mila parrocchie su 19mila sono passate alla neonata Chiesa ortodossa autocefala guidata dal primate Epifanij), oggi Kirill si trova in difficoltà anche con la Chiesa ortodossa ucraina guidata dal primate Onufrij, la quale, pur rimasta legata al patriarcato di Mosca, ha espresso una forte contrarietà alla guerra.
I cattolici ucraini
I cattolici ucraini – stimati attorno all’11 per cento del totale, pari a 6 milioni di persone – sono invece riuniti nella Chiesa greco cattolica, guidata da monsignor Sviatoslav Shevchuk. «Non lasciateci soli nel nostro dolore – ha detto il vescovo (28 marzo) -. Nessuno è preparato alla guerra, tranne i criminali che la pianificano e la mettono in atto. È stato uno choc. Ma era evidente che si trattava di un’invasione ben pianificata». Quella ucraina non è una «guerra di religione», ma è una guerra in cui la religione viene usata come strumento. Come troppo spesso nella storia.
Paolo Moiola

Ucraina, alcuni dati
- Superficie: 603.600 Km2 (due volte l’Italia);
- Popolazione: 41,5 milioni (dato controverso);
- Capitale: Kyiv (traslitterato dall’ucraino), Kiev (traslitterato dal russo), con circa tre milioni di abitanti;
- Sistema politico: repubblica democratica semipresidenziale;
- Presidente: Volodymyr Zelenskyj, in carica dal 20 maggio 2019;
- Date essenziali: indipendenza, 25 dicembre 1991; invasione russa, 24 febbraio 2022; scoperta una strage di civili a Bucha, 3 aprile; papa Francesco parla di «impotenza dell’Onu» (6 aprile);
- Principali gruppi demografici: ucraini 78%, russi 17%;
- Religioni principali: ortodossi 78% (divisi in due Chiese, una legata a Mosca e una autocefala), cattolici 11% (Chiesa greco cattolica);
- Economia: produzione agricola (grano, semi di girasole, zucchero, carne, prodotti caseari); industria siderurgica (acciaio e ghisa);
- Gas: attraversa l’Ucraina il gasdotto Yamal, dal quale passa circa il 10% delle forniture totali di gas proveniente dalla Russia;
- Regioni contese: Donbass, regione mineraria (carbone in primis, ma anche ferro, uranio, titanio, manganese, mercurio e gas) di circa 32mila Km2, quattro milioni di abitanti (dato controverso), Donesk e Luhansk come capoluoghi; Crimea, penisola sul Mar Nero di 26.200 Km2 (poco più della Lombardia), due milioni di abitanti e Sebastopoli come capoluogo;
- Migranti (anteguerra): circa sei milioni di cittadini (World Migration Report, 2022), la maggior parte in Russia e Polonia; ottavo paese al mondo per fenomeno migratorio;
- Ucraini in Italia (anteguerra): 236mila pari al 4,6% degli stranieri ufficiali (dati Istat, 1° gennaio 2021); dei residenti ucraini in Italia 177mila sono donne, in larga parte occupate nei servizi alla persona (colf e badanti; dati Fondazione Leone Moressa);
- Profughi: 6,5 milioni di profughi interni (International organization for migration, Iom, marzo 2022); 4,5 milioni di profughi scappati dal paese (dati Unhcr al 10 aprile 2022), oltre 87mila arrivati in Italia (secondo le cifre del Viminale al 10 aprile).
(a cura di Paolo Moiola)
![]()