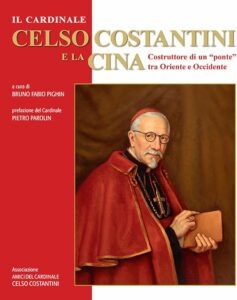«Gli eventi traumatici estremi come la tortura e la violenza intenzionale portano a una drammatica frammentazione delle funzioni psichiche di coloro che le subiscono. Allo stesso modo, il percorso di cura può essere visto – metaforicamente e nei fatti – come un processo di ricomposizione dei “frammenti” della mente e del corpo dei sopravvissuti».
Inizia con queste parole il rapporto «Frammenti» di Medici per i diritti umani (Medu), un’organizzazione che lavora per fornire una risposta al bisogno di salute mentale proveniente da migranti, rifugiati e richiedenti asilo in Italia. Le sue iniziative si rivolgono soprattutto a coloro che sono sopravvissuti a tortura e trattamenti crudeli, inumani e degradanti.
Un’esigenza di intervento evidenziata anche dai dati: dei 1.500 migranti che Medu ha assistito nei suoi progetti dal 2014, l’80% ha riferito di aver subito tali trattamenti nei Paesi di origine e/o di transito. In particolare in Libia, che Medu denuncia essere ormai una vera e propria «fabbrica della tortura».
In Italia, il sistema di accoglienza e quello sanitario sono decisamente lontani dall’essere in grado di individuare precocemente e prendere in carico efficacemente richiedenti asilo e rifugiati che hanno subito torture, stupri e altre forme gravi di violenza fisica, psicologica o sessuale.
Già si è dovuto attendere ben trent’anni dalla ratifica della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti affinché l’Italia introducesse nel proprio Codice penale il reato di tortura.
In più, le Linee guida per l’assistenza, la riabilitazione e il trattamento dei disturbi psichici dei rifugiati e delle vittime di tortura – emanate nel 2017 dal ministero della Salute – sono ancora ampiamente disattese dalla maggior parte delle regioni italiane. Mancano i fondi per riorganizzare i servizi sanitari, introdurre figure per la mediazione linguistico-culturale e formare il personale medico e psicologico.
È in questo contesto di carenza di adeguati servizi medici e psicosociali che Medu ha fondato i centri Psyché.
A Firenze, Ragusa e Roma, queste strutture si occupano della salute mentale transculturale di migranti, richiedenti asilo e rifugiati. La loro nascita è stata resa ancor più necessaria dalla riduzione dei servizi legali e psicologici nei Centri di accoglienza straordinaria a seguito dell’introduzione della legge 50 del 2023 (il cosiddetto «Decreto Cutro», l’ennesima stretta al sistema di accoglienza italiano).
I centri Psyché dunque cercano di riempire questo vuoto. Nascono per fornire assistenza psicologica, psichiatrica e psicosociale ai sopravvissuti a tortura, trattamenti inumani e degradanti, violenza sessuale e di genere. Ma sono aperti anche a tutti coloro che presentano disagi psichici di natura post-traumatica, indipendentemente da condizione giuridica, economica e sociale.
In questi centri, una figura essenziale è il mediatore linguistico-culturale. In un video contenuto nel rapporto «Frammenti», Najla Hassen, mediatrice di Medu, racconta: «Ci occupiamo di ferite, quindi è essenziale dialogare nella lingua dei pazienti per avvicinarci il più possibile a loro. La mediazione linguistica non è soltanto una traduzione letterale, è un’interpretazione e un costruire un dizionario per ogni persona che incontriamo».
Mentre il suo collega Abdoulaye Toure aggiunge: «Il mediatore non è una presenza basata solo sulla trasmissione, sulla traduzione della lingua, ma sul fatto di stare lì. Il paziente ha vicina una persona che potrebbe essere uno zio o un fratello più grande e ha fiducia. Così, riesce a raccontare molto di più di quello che il terapeuta si aspettava».
Infatti, nonostante il background sociale e anagrafico delle persone assistite nei tre centri sia diversificato, tutti coloro che vi accedono sono stati esposti a traumi complessi (intesi come eventi ripetuti, prolungati nel tempo e di natura interpersonale).
Analizzando un campione di 120 persone, ad esempio, Medu ha rilevato che, mediamente, ciascun individuo è sopravvissuto a sette eventi traumatici pre-migratori, migratori e post-migratori. Nei primi due casi si trattava di tortura, detenzione e gravi abusi fisici. Nell’ultimo invece rientrano le carenti condizioni dei centri di accoglienza, la precarietà dello status legale, lo scarso supporto psicosociale e le barriere linguistiche.
Ricomporre i «frammenti» della mente e del corpo dei sopravvissuti è quindi necessario per curare le ferite fisiche, ma soprattutto quelle psicologiche di migranti, richiedenti asilo e rifugiati. Farlo, parlando la loro lingua e interpretando le loro parole e i loro gesti, è fondamentale per garantire a tutti la possibilità di ricostruire il proprio futuro.
Aurora Guainazzi