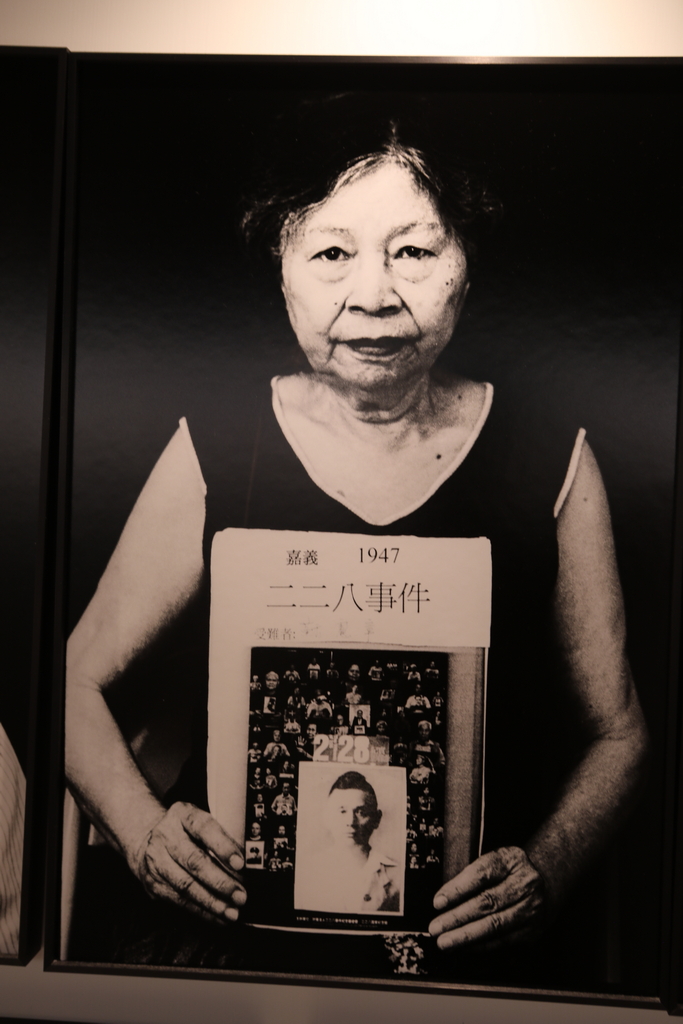Porta e pastore (Gv 10,1-21)
Giovanni presenta l’agire e il parlare di Gesù quasi sempre nel contesto delle feste giudaiche nel tempio. Alcune volte presenta un nuovo discorso di Gesù come se fosse una prosecuzione di quello precedente, nonostante sia chiaro che il tema è cambiato.
È quello che succede all’inizio del decimo capitolo del Vangelo, anche se al versetto 21 sembra che il testo accenni di nuovo alla guarigione del cieco nato di cui ha raccontato nel capitolo 9. Questo significa che l’evangelista ci sta suggerendo che i due brani andrebbero visti più o meno insieme? Può darsi. Nel Vangelo di Giovanni spesso succede così, benché questa volta fatichiamo un po’ a capire quale possa essere il collegamento. D’altronde, non è una novità che il quarto Vangelo ci stimoli a cercare di capire senza offrirci la certezza di avere colto davvero tutto.
Vanno probabilmente nella stessa direzione anche le due immagini che Gesù utilizza nel capitolo 10 per parlare di sé: la porta dell’ovile e il pastore del gregge. Si parla in entrambi i casi di pecore, ma verrebbe da dire che se Gesù è la porta da cui le pecore passano, non può essere anche il pastore che ce le fa passare. Sembra una contraddizione, però, al di là di una corrispondenza più o meno precisa dei dettagli, possiamo cogliere che quello che conta è il significato di fondo delle due immagini, ciascuna della quali suggerisce qualcosa su Gesù. E quindi sul Padre.
La porta (vv. 1-10)
Non siamo più abituati a vivere con gli animali «da fattoria». Pochi di noi, probabilmente, hanno visto dal vero una pecora e, meno ancora, un gregge nel suo ambiente consueto, fatto di pascoli e di ovile. Possiamo però immaginarlo. L’ovile è recintato, a volte addirittura chiuso e coperto: consente di difendersi le pecore da ogni minaccia esterna, che siano i predatori o il clima. Nello stesso tempo, però, il cibo si trova normalmente fuori dall’ovile, e occorre comprendere quando è il momento di uscire e di rientrare, quando preferire il riparo e quando il pascolo.
Gesù si presenta come colui che garantisce questo passaggio, dal dentro al fuori. Se volessimo ampliare l’intuizione dell’evangelista, adattandola meglio al nostro contesto, potremmo dire che anche per noi ci sono i momenti di vita privata, di preghiera al Padre nell’intimo della nostra stanza (Mt 6,6), di studio, di esame di sé e della propria vita, e ci sono, viceversa, i tempi in cui, come per il cieco nato, rispondere alle domande, dare testimonianza su Gesù e agire nel mondo in coerenza alle nostre scelte.
Il privato e il pubblico, possono sembrarci contesti talmente lontani da faticare a farli dialogare tra di loro: nella nostra cultura si pensa ad esempio che la vita spirituale, religiosa, vada benissimo se gestita in privato, purché non si noti all’esterno, mentre siamo ogni giorno messi davanti alle vite pubbliche e pubblicitarie di personaggi sui quali ci viene da interrogarci se e quale vita interiore possano condurre.
Gesù sembra proporsi come passaggio tra questi due mondi, che sono entrambi nostri. E lo fa non indicando le regole da seguire, ma appellandosi alla «voce». È un’immagine che sembrerebbe adattarsi meglio al pastore che alla porta, e infatti poi Gesù la riprenderà, ma, un po’ paradossalmente, la utilizza già qui per la porta, quasi che fosse la porta stessa a chiamare per nome le pecore.
Questo accenno alla voce è profondamente significativo: ciascuno aderisce non a una legge o a un programma, ma a una chiamata. Chi ci chiama per nome per farci proposte, o incoraggiarci, o darci suggerimenti, non si limita a offrire delle indicazioni, ma domanda di fidarci. In questo caso non ci adeguiamo alle parole perché convincenti, ma perché confidiamo in chi le dice. La relazione personale è più importante del contenuto del messaggio. È esattamente quello che suggerisce Gesù, nella ricerca del Padre e del pascolo: ascoltare lui, fidarsi di lui, restare in relazione personale con lui.
Nello stesso tempo, la porta – preziosa, ad esempio, per capire chi viene dentro per depredare, e anche perché permette di passare da dentro a fuori e viceversa – resta per così dire secondaria, a servizio. Centrale sì, ma umile, essenziale, ma funzionale. Passo dopo passo Gesù ci conduce a capire che lui è cruciale, sì, ma che l’obiettivo ultimo è il nostro incontro con il Padre, e con la nostra vita più autentica.
![]()
Il pastore (vv. 11-18)
Nei versetti successivi Gesù cambia immagine, in una direzione che in qualche modo ha già preparato: «Io sono il buon pastore», anzi, se dovessimo tradurre in modo proprio letterale, «il bel pastore». «Bello» in greco aveva una gamma di significati più ampia del nostro aggettivo, non indicava solo l’aspetto estetico, ma descriveva anche qualcosa come «affidabile, adeguato, generoso».
Gesù è il pastore modello, quello che non pensa a sé ma al bene delle pecore, che conosce per nome, che chiama perché riconoscono la sua voce. Gesù è il pastore che, quando dovesse venire il lupo, non fuggirebbe, ma gli si metterebbe davanti, pronto anche a dare la propria vita per le pecore.
Potremmo pensare che l’immagine sia persino esagerata: il pastore, alla fine, alleva le pecore per la loro lana, il loro latte e magari anche la loro carne. Di certo non difenderebbe la loro vita fino al punto da rischiare la propria. Può darsi, invece, che chi conosce dei pastori sostenga il contrario. L’affetto che li lega alle proprie pecore può portare fin lì. Chi vive con animali domestici in casa sa che il bene provato per quelle bestie, che dipendono da noi e ci donano e domandano amore, può spingerci a difenderli oltre ogni ragionevole limite. E in ogni caso, quello che Gesù dice, per quanto razionale o incredibile ci sembri, è che lui è disposto a dare la propria vita per le sue pecore. Lo farà, infatti, sul Golgota. E non sarà un errore, un incidente di percorso: già prima si è detto disposto a offrire tutto sé stesso per la vita delle sue pecore, che conosce e chiama per nome, che ama una a una.
E in questa relazione, Gesù dice di ripetere, verso le sue pecore, ciò che il Padre fa con lui. Come loro due si conoscono e si amano, così Gesù conosce e ama il suo gregge. Nel suo amore, quindi, si coglie l’amore del Padre che nessuno può vedere.
Come è già successo e ancora succederà nel corso del Vangelo, pare quasi che le direttrici dell’amore si confondano: non è più chiaro chi ami chi e chi dia la vita per chi. È la felice confusione dell’amore, nella quale ci si vuole bene e si è ognuno per l’altro, senza soppesare se qualcuno dà di più o riceve di più. Anzi, come potrebbe confermare chiunque ami, la contabilità del dare e dell’avere non ha senso, perché chi ama è felice di donare e fare il bene dell’amato.
Se allora Gesù si presenta come la porta da cui passare per avere la vita, e come il pastore da ascoltare e seguire perché quella vita sia nutrita e difesa, nel suo agire vediamo il sentimento stesso del Padre, che vuole la vita di chi ama senza mettersi al centro, felice di amare e donare.
Un altro gregge (v. 16)
A questo punto, a sorpresa, Gesù dice di avere anche altre pecore, di un altro ovile. I commentatori si sono sbizzarriti nel cercare di identificarle: saranno i cristiani che vengono dal paganesimo? Saranno quei giudei che non sono lì presenti e magari incontrano Gesù di nascosto? Sarà già un anticipo di quei cristiani divisi in tante chiese?
In realtà, non è difficile capire che non è poi così importante rispondere a queste domande. Quello che Gesù dice è semplicemente che bisogna restare aperti alle novità, all’arrivo di altre pecore. La tentazione di ogni gruppo umano, infatti, è quella di chiudersi, di escludere tutti gli altri, di restare «solo noi che ci vogliamo così bene». Gesù richiama a restare aperti, disponibili, fiduciosi e ottimisti anche nei confronti degli «altri», che saranno pecore buone perché in ascolto del medesimo pastore bello. È la dinamica della Chiesa: i credenti sono una comunità non perché vengano dallo stesso posto o abbiano lo stesso antenato o le stesse sensibilità o passioni, o ragionino allo stesso modo, ma perché tutti ascoltano la voce del medesimo pastore. È Gesù, porta di passaggio, a garantire che si possa essere un gregge solo.
È tanto importante questa armonia offerta dall’unico pastore che ci raduna e ci ama, che Giovanni si lancia anche in un gioco di parole affascinante: l’obiettivo dei discepoli, scrive in greco, sarà quello di essere «un solo gregge e un solo pastore» (mia poimnē eis poimēn).
Le reazioni (vv. 6.19-21)
Gesù ha impostato tutto il suo discorso sulla relazione, non sull’obbedienza a una legge. E in una relazione è sicuramente importante la proposta e l’offerta da parte di uno, tanto quanto lo è la risposta dell’altro. Giovanni, infatti, ne scrive dicendo che la prima reazione dei suoi discepoli è di incomprensione (v. 6). In tutto il Vangelo resta questo dramma della fatica dei discepoli a comprendere le parole di Gesù (la proviamo anche noi, spesso). Qui però è chiaro che, di fronte all’offerta di una relazione con Dio basata su affetto, ascolto e fiducia, la difficoltà dei discepoli non è tanto quella di non capire, quanto quella di accettare. Occorre rinunciare all’immagine di un Dio severo, giudice, che ci farà sentire belli e buoni espellendo dall’ovile e castigando gli altri. L’immagine che Gesù offre è diversa, è una voce che chiama e conosce per nome, che non fa violenza alle pecore, non le costringe, ma offre solo protezione e vita. Quando non si vuole accettare questa immagine di Gesù e del Padre, ci si rifugia nella incomprensione: «Non può essere così, non c’è severità, serietà, selezione».
Non a caso anche dopo la seconda parte del discorso di Gesù c’è una «divisione» tra i suoi ascoltatori, tra chi dice che è pazzo e chi, al contrario, fa notare che nessun pazzo può aprire gli occhi a un cieco. I dati sono lì, sono a disposizione. Ma Gesù non costringe a restare nell’ovile e a seguire la voce del pastore.
Anche noi,oggi, ci troviamo di fronte a un volto divino – trasmesso ed esemplificato da Gesù -, che è di affetto, di relazione personale, di fiducia. Possiamo decidere che è un volto non abbastanza severo e rigido, possiamo non capire, o respingerlo: oppure possiamo lasciarci avvolgere dall’abbraccio che lega il Padre e il Figlio e che si mantiene accogliente per chiunque.
Angelo Fracchia
(Il Volto del Padre 12 – continua)