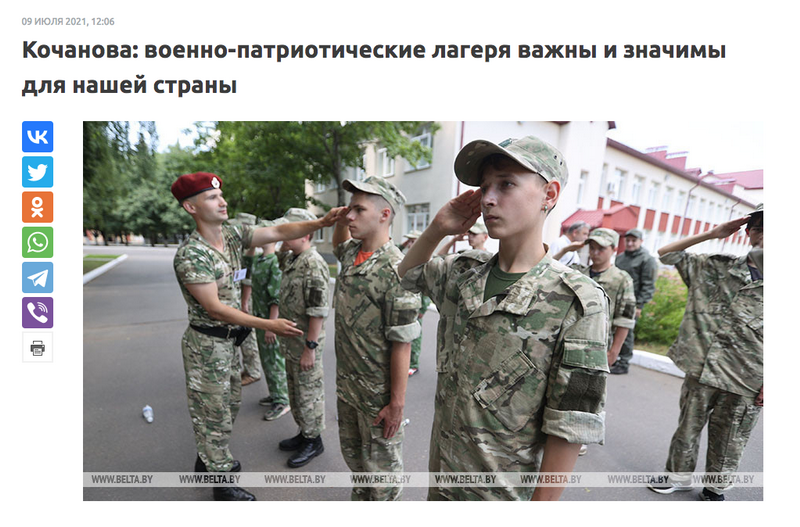Cina: esempio per l’Africa?
La Cina ha lanciato nel 2013 la Nuova via della seta, un progetto di cooperazione economica a livello planetario. E l’Africa è un continente chiave. Sia perché ha grandi riserve di materie prime, sia perché, con la sua popolazione giovane, è un mercato in espansione e la futura fabbrica del mondo. La strategia dell’impero di mezzo sta cambiando. E un libro ci rivela come.
«Nell’ultimo anno, a causa della guerra in Ucraina, l’aspetto politico della strategia cinese è emerso in maniera preponderante, ancora più di quello economico. Quello dei rapporti tra Cina e Africa mi sembra un argomento importante, anche per l’Italia, per cui ho deciso di approfondirlo». Chi parla è Alessandra Colarizi, sinologa e analista, con una grande esperienza, tra l’altro, come autrice per testate italiane ed estere, su questioni cinesi. Alessandra ha vissuto diversi anni in Cina, dove ha iniziato, nel 2016, a fare parte del collettivo «China Files» (vedi in fondo a questo testo), per poi diventarne coordinatrice editoriale.
Si è specializzata sui rapporti tra la Cina e i paesi membri della Belt and Road initiative (Bri, detta anche la nuova via della seta), affrontando prima la questione dell’espansionismo cinese in Asia centrale e poi, in tempi più recenti, in Africa. È da questo interesse che nasce «Africa rossa», il suo ultimo libro.
Il volume presenta un vasto studio delle relazioni tra l’impero di mezzo e il continente africano, a partire da alcuni aneddoti storici, tracciando il percorso degli ultimi decenni, fino ad arrivare a descrivere come la strategia si è modificata, e si sta muovendo.
«Africa rossa» è un testo notevole, che ha il pregio di tentare un approccio a 360 gradi della questione. Si consideri, inoltre, che in Italia mancava un approfondimento sul tema da diversi anni.
Leggendolo si scopre che la Cina, dal 2009, è diventata il primo partner commerciale del continente, e che nel 2021 l’interscambio ha raggiunto i 254 miliardi di dollari. La Cina detiene il 14% del debito sovrano dell’Africa.
Abbiamo avuto un colloquio online con Alessandra Colarizi, per parlare di questo suo lavoro.

Retorica cinese
La Cina si è sempre posta, rispetto ai paesi africani, su un piano di uguaglianza: ex colonizzati, tutti paesi emergenti, sebbene sia la seconda economia mondiale. Ma il rapporto è, indubbiamente, asimmetrico.
«È una contraddizione in termini quella cinese. Il Paese compie piccoli gesti che mettono in mostra l’intenzione di porsi in modo diverso dall’Occidente. Caso simbolo è quello delle Comore, (stato indipendente composto da tre piccole isole nel canale di Mozambico, ndr), dove la Cina ha aperto un’ambasciata, e dove recentemente si è recato il ministro degli Esteri cinese.
Questo mostra una certa sensibilità della Cina. Penso, inoltre, che il comportamento dell’Occidente faccia gioco della strategia cinese. C’è molto risentimento verso alcuni paesi ex colonizzatori. Se ci fosse un comportamento diverso, l’attenzione degli stati africani verso la Cina forse sarebbe minore.
È chiaro che, nell’atteggiamento cinese, c’è molta retorica, ma allo stesso tempo, la strategia è portata avanti con i fatti. Ovvero: attenzione diplomatica, seguita da investimenti».
Alessandra ricorda che ci sono alcune questioni trascurate nel rapporto Cina-Africa: «Poi si può passare sopra ad alcune problematiche. Penso a quelle culturali, alla scarsa accettazione reciproca dal punto di vista umano, agli attacchi razzisti contro i cinesi presso alcune miniere in Africa, o dei quali sono stati vittime gli studenti africani in Cina. Sono problemi giganteschi, che però sono insabbiati a causa di un interesse maggiore».
Per decenni in Africa hanno avuto influenza quasi esclusiva i paesi ex colonizzatori (Francia, Regno Unito, Portogallo), con l’aggiunta di Usa e Urss durante la guerra fredda. Da una ventina di anni a questa parte, invece, gli attori in campo si sono moltiplicati. Oltre alla Cina, è presente con un certo peso la Turchia, e poi l’India, le monarchie del Golfo (come Qatar ed Emirati arabi uniti), e infine la Russia di Putin con una presenza di tipo militare non ufficiale (cfr. MC novembre 2022). Ogni paese con un approccio diverso.
Colarizi scrive in Africa rossa: «Per Washington l’Africa continua ad avere le sembianze di un ring da cui buttare fuori le sfidanti – Cina e Russia – accusate di agire con intenzioni predatorie». Le chiediamo se tra queste potenze straniere, che si incrociano in Africa, ci possa essere anche collaborazione, oltre che competizione.
«Ufficialmente la Cina promuove la cooperazione nei paesi terzi, come è scritto nel memorandum sulla Bri, firmato dall’Italia nel 2019. Aveva invitato Francia e Germania a portare avanti progetti insieme. La Cina collabora con realtà occidentali fino dai primi anni ‘90, in alcuni settori dello sviluppo.
Nel momento in cui gli Usa e l’Europa spingono per dei progetti che prenderebbero il posto della Cina, e non sono aperti a investimenti cinesi, allora diventa una competizione».
«Per quanto riguarda i rapporti con le potenze emergenti, come Russia ed Emirati arabi, non c’è una grossa contrapposizione ed è bassa la possibilità che gli interessi entrino in conflitto. Questi due paesi sono focalizzati sul settore della sicurezza, nel quale la Cina sta aumentando la propria presenza con l’export di armi, ma con un interesse più rivolto all’aspetto economico che a quello militare. Quando estende le sue relazioni sul piano militare, lo fa con programmi di formazione, e solo in rapporti ufficiali. Non vedo possibilità di scontro.
L’elemento Russia è particolare, perché sappiamo che opera non solo attraverso canali ufficiali. Ci sono stati episodi recenti che hanno coinvolto anche dei cinesi, come le morti nella Repubblica Centrafricana (il 19 marzo scorso, 9 cinesi lavoratori di una miniera sono stati giustiziati; ribelli centrafricani e gruppo Wagner si rimbalzano le accuse, ndr). Questi potrebbero essere un elemento destabilizzante, che la Cina non vede con favore».
Quando ci sono elementi d’instabilità, la Cina non è mai contenta. «Con la Russia ci sono anche tentativi di cooperazione a livello ufficiale (in Africa): ci sono foto ricordo di diplomatici dei due paesi in ambasciate africane. C’è poi l’altra dimensione, la questione dei mercenari russi, nella quale non è ben chiaro dove sia il confine tra lecito e illecito.
Con gli Usa, in questa fase, non mi pare ci possano essere grandi cooperazioni».

Mercenari cinesi
Parlando di sicurezza, lo studio di Colarizi riporta che l’84% dei progetti della Bri è a rischio medio alto, con attacchi di varia natura al personale, e rischi di terrorismo islamista. Gran parte dei paesi africani, infatti, ha visto negli ultimi vent’anni aumentare notevolmente la propria insicurezza interna. Tutto ciò crea grossi problemi agli interessi della Cina nel continente. Inoltre: «La vocazione cinese è mantenere la stabilità».
Scopriamo da Africa rossa che anche l’impero di mezzo ha i suoi contractors: «Secondo il
think tank americano Carnegie endowment for international peace, Beijing DeWe Security Service e Huaxin Zhong An Security Group da sole controllano 35mila contractors in 50 nazioni africane». Però, ci dice Colarizi: «I contractors privati cinesi, hanno un ruolo marginale, non possono usare armi da fuoco, sono impiegati in ruoli di consulenza, supporto tecnico e prevenzione dei rischi. Interessante è una cooperazione che si sta attivando con le forze di polizia e sicurezza, a livello di addestramento e fornitura di equipaggiamento». La sinologa ci spiega inoltre che il governo cinese ha lanciato la Global security initiative. La seconda di tre iniziative, dopo la Global development initiative e prima della Global civilization initiative di pochi mesi fa. «Si tratta di slogan, di iniziative multilaterali che vorrebbero dare un aspetto più pacifico e bonario alla Cina. Ma si basano su principi generici e sono vaghi».
Soft power dalla grande muraglia
Chiediamo all’autrice l’importanza del soft power (cioè l’abilità di guadagnare consenso internazionale grazie all’appeal culturale e valoriale, anziché attraverso la coercizione, dalla definizione del politologo statunitense Joseph S. Nye Jr., riportato da Colarizi, ndr) cinese sul continente .
La domanda che si pongono i governanti cinesi è: come accrescere il favore delle popolazioni locali nei confronti della Cina?
«Mi sembra che, al momento, il soft power sia più evidente nella sua versione tradizionale, ovvero borse di studio per attrarre giovani africani nel Paese asiatico. È il metodo migliore e più efficace per tentare di avere un impatto forte sulle generazioni future.
A livello di prodotti culturali, la Cina non ha un’industria cinematografica in grado di competere con quella statunitense o sudcoreana, anche se ci sono stati alcuni prodotti più fortunati, ma senza una grande espansione.
C’è il settore controverso della cooperazione mediatica, per la quale sono stati siglati contratti che fanno trasferire le notizie della Xinhua (agenzia stampa ufficiale di Pechino, ndr) direttamente sui media africani, senza che ci possa essere un filtro da parte di giornalisti locali. Ma non tutti i lettori sono in grado di capire qual è la propaganda».
Ci sono anche i social media, che in Africa sono molto diffusi, come ad esempio il cinese Tiktok.
«Sì, ma non so quanto impatto abbia sulla popolazione locale. C’è stato il fenomeno degli influencer cinesi che risiedono in Africa, e fanno vedere la vita dal posto sui social. In Cina sono abbastanza popolari, ma non ho un riscontro su cosa succeda in Africa».
![]()
Una nuova strategia
Si assiste, mette in evidenza Africa rossa, a un’evoluzione strategica della presenza cinese in Africa.
Fino a un decennio fa si trattava prevalentemente di costruire infrastrutture e invadere il mercato di manufatti cinesi in sovraproduzione, facendosi pagare in materie prime da portare in patria per alimentare l’industria. Questo approccio ha creato un forte indebitamento degli stati africani, che per motivi diversi, tra i quali l’instabilità sociopolitica, hanno difficoltà a pagare.
Oggi si tratta di esportare il modello cinese, che prevede, tra l’altro, la creazione di Zone economiche speciali (Zes, aree con facilitazioni legislative e fiscali, create per attrarre investimenti stranieri) come quella di Shenzhen.
Fondamentale è questo passaggio del libro: «Abbiamo visto la Cina, riconoscendo se stessa nell’Africa, tende a replicare quanto già collaudato con successo durante il proprio percorso di crescita e sviluppo. Lo ha fatto in passato con la realizzazione di infrastrutture di trasporto in cambio di materie prime. Ci ha riprovato in seguito coniugando la costruzione di aree residenziali, Zes e distretti industriali. Il tutto con l’obiettivo di creare un ecosistema urbano integrato per risolvere il grande dilemma: a differenza della versione cinese l’urbanizzazione africana non è stata accompagnata da uno sviluppo industriale in grado di sostenere la crescita economica del continente. Per porre rimedio, negli ultimi dieci anni lo sviluppo di Zes e parchi industriali è diventato uno dei pilastri della collaborazione sino africana, con un focus particolare sul settore manifatturiero e il trasferimento di tecnologia. Nel 2020 erano già 25 le zone di cooperazione economica istituite dalla Cina e potenzialmente capaci di elevare il continente da fornitore di commodities a esportatore di prodotti industriali».
La svolta
«In Africa – ci spiega Colarizi – il prezzo della mano d’opera è ancora basso, mentre in Cina è in aumento. Inoltre, nell’ultimo anno è stato firmato un accordo per abbattere le tariffe doganali di molti prodotti da diversi paesi in via di sviluppo.
I leader cinesi stanno puntando sul settore agricolo, perché sanno che l’Africa ha un grande potenziale, che si può sviluppare. Stanno investendo in formazione, export di macchinari che possono aiutare i paesi del continente a rendere più produttive le coltivazioni. È anche il settore sul quale hanno ricevuto richieste da parte degli africani».
L’export africano, soprattutto di prodotti alimentari, è dunque aumentato verso la Cina, e si tratta di un’inversione di tendenza, segno di un grande cambiamento.
Colarizi: «Recenti dati sull’export cinese verso paesi emergenti, dicono che c’è un aumento del 30% di semilavorati, che vengono poi utilizzati nel manifatturiero. Questo da l’idea che ci sia l’intenzione di rafforzare lo sviluppo industriale».
Allora la Cina è un esempio per i paesi africani? «C’è l’intenzione da parte della Cina di replicare il proprio modello, anche se io non ci vedo un tentativo di imposizione dall’alto. Piuttosto una proposta. È come se i cinesi dicessero: “il nostro modello ha funzionato da noi, però non è detto che funzionerà da voi. Seguite il vostro percorso, trovate la vostra strada, sperimentate e non è escluso che ce la farete”».
Marco Bello

Cina-Africa su MC
- Chiara Giovetti, Cina in Africa, Miti e poca trasparenza/2, gennaio 2018.
- Chiara Giovetti, La Cina in Africa: che cosa è cambiato/1, ottobre 2017.
- AA.VV., Tigri e leoni, numero monografico, ottobre 2010.
- Bongiovanni, G. Nikundana, A Koné, M. Bello, dossier Giallo in Africa, dicembre 2007.
China Files
- È un collettivo di giornalisti, sinologi ed esperti di comunicazione specializzati in affari asiatici. Nata a Pechino nel 2008 come agenzia stampa focalizzata sulla Cina si è ampliata fino a coprire l’intera Asia. Ha già collaborato con MC.
- Alessandra Colarizi, tra l’altro, cura la rubrica Africa rossa, per aggiornare sulle dinamiche tra Cina e i paesi del continente.
- www.china-files.com