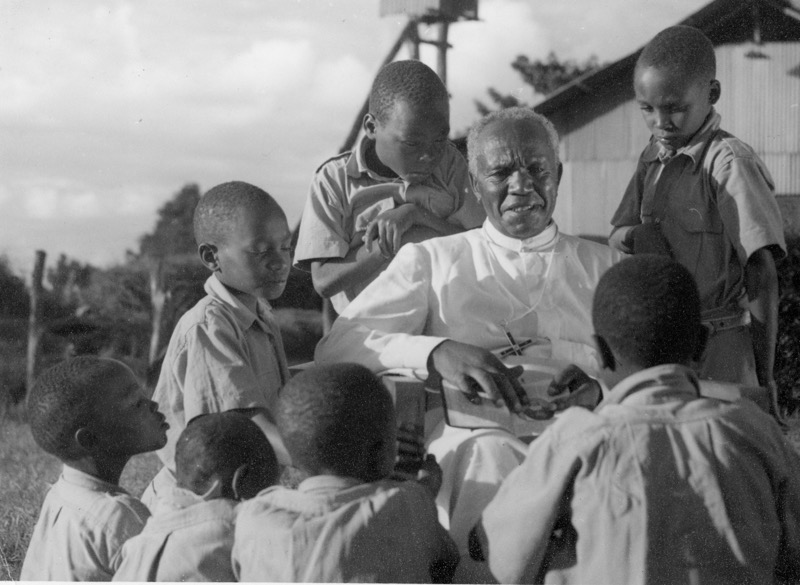Nata in Colombia venti anni fa, in un contesto di guerra civile, la scuola di perdono e riconciliazione «Espere» oggi è diffusa in 20 paesi nel mondo. Anche in Portogallo, grazie a padre Albino Brás che l’ha sperimentata nei suoi anni di favela a Rio de Janeiro. In un tempo di conflitti a ogni livello, il perdono e la riconciliazione sono una strada di evangelizzazione.
I conflitti e la violenza sono all’ordine del giorno nella favela della parrocchia Nossa Senhora da Consolata a Rio de Janeiro. Per questo nel 2003, dopo sei anni di presenza sul territorio, padre Albino Brás decide di partecipare a un corso di «Espere» (Escuelas de perdón y reconciliación), la scuola di perdono e riconciliazione fondata in Colombia e poi diffusa in diversi paesi nel mondo dal confratello padre Leonel Narváez Gómez.
Il corso offre a padre Albino quegli strumenti che gli mancavano per dare corpo al desiderio di promuovere il perdono e la riconciliazione tra la sua gente. S’innamora a tal punto del metodo di Espere che, quando lascia il Brasile per il Portogallo, decide di farsene promotore anche nel suo paese di origine e in Europa.
Oggi afferma con convinzione che quella della risoluzione dei conflitti e della giustizia riparativa è una strada prioritaria di umanizzazione e missione.

In favela per la pace
«La mia prima destinazione è stata in Brasile. Sono arrivato lì il 17 maggio 1997», racconta padre Albino, nato il 15 agosto 1965 a Loureira, distretto di Leiria, regione centrale del Portogallo.
Ultimo di sei fratelli cresciuti in campagna in una famiglia umile, padre Albino è entrato in seminario a soli 13 anni, nel 1979, ed è stato ordinato nel 1996.
«Il lavoro pastorale in un contesto di favela è stato impegnativo. Come sacerdote appena ordinato, ho imparato lì il meglio del mio ministero e della mia vita missionaria. Ho lavorato molto in quegli anni nella pastorale delle favelas, nella dimensione socio caritativa, con i minori abbandonati, nella Commissione diocesana per i diritti umani, ma anche e soprattutto nell’ambito della spiritualità, della catechesi e dell’evangelizzazione.
Le sfide sono state molte. Ho vissuto momenti difficili, di persecuzione e violenza. Ma credo che sia proprio nelle situazioni di tensione che la Chiesa deve essere presente, anche correndo dei rischi, per promuovere la pace e il rispetto reciproco».

Una cultura del perdono
Padre Albino conosce il progetto Espere, nel 2003. «Padre Leonel ha tenuto una conferenza a Rio de Janeiro su violenza, conflitti, perdono e riconciliazione. Ero sensibile a questi temi, anche per la difficile realtà di Rio, e sono andato a seguirla. Poche settimane dopo ho fatto il corso.
Sebbene il progetto si chiami “scuola”, non è qualcosa di teorico: Espere offre un’esperienza di perdono e riconciliazione partendo dalla vita di ogni persona. Investendo nella creazione di una cultura del perdono, le Espere riparano la vittima e, allo stesso tempo, cercano il recupero dell’autore della violenza, a scapito di una giustizia meramente punitiva molto presente nelle società di oggi, anche in Europa.
Espere nasce dalla prospettiva non solo di sognare un mondo di pace, ma di lavorare concretamente per realizzarlo.
Mi è sempre stato detto che dovevo perdonare, ma mi mancava il “come”, e con Espere ho trovato gli strumenti, il processo, il metodo, per renderlo possibile.
Inoltre, Espere è in linea con il carisma dell’Imc e con il Vangelo della consolazione: perdono e riconciliazione, compassione e misericordia, amore e pace che derivano dall’esercizio della giustizia riparativa».
Subito dopo aver seguito il corso, padre Albino lo replica nella sua parrocchia. Le valutazioni dei partecipanti sono buone e il missionario si rende conto che produce trasformazione a livello personale, comunitario e sociale.

La missione in Portogallo
Il 14 gennaio 2005, padre Albino lascia il Brasile per il Portogallo.
Tra il 2005 e il 2012 sta nella comunità Imc di Fatima dove lavora nell’animazione missionaria e nella pastorale giovanile. È direttore nazionale del Segretariato Imc per la missione, coordina per sette anni il Corso di missiologia promosso dagli Istituti missionari ad gentes (Imag) e dalle Pontificie opere missionarie portoghesi. Fonda il gruppo Jmc (Giovani missionari della Consolata) che cresce negli anni.
«Sono stato poi in missione per quattro anni al Bairro do Zambujal, nel comune di Amadora, un sobborgo dell’area metropolitana di Lisbona – prosegue padre Albino -. Zambujal è un quartiere abitato principalmente da due gruppi etnici: africani e zingari. È stato molto impegnativo.
Nel 2016, poi, ho assunto la direzione di Fatima Missionária, la rivista fondata dai Missionari della Consolata in Portogallo quasi 70 anni fa. Dopo aver lasciato la direzione della rivista, oggi continuo a contribuire come collaboratore e lavoro anche nell’area della comunicazione dell’Imc in Portogallo, soprattutto nei media digitali.
Dalla fine del 2016 sono nella comunità Imc di Olivais, a Lisbona come superiore. Nell’aprile di quest’anno sono stato nominato Segretario dell’Imc Europa».

Espere a Zambujal
Domandiamo a padre Albino quando e perché ha ripreso in mano il programma di Espere nella sua terra di origine: «Ho sentito il bisogno di riprendere il progetto Espere quando mi trovavo nel Bairro do Zambujal, un quartiere periferico con molte tensioni tra le varie etnie.
Ho riunito un’équipe, abbiamo fatto formazione, tradotto materiali e programmato corsi.
Fino allo scoppio della pandemia da Covid-19 che ci ha costretti a fermarci, ne abbiamo tenuti nove. Il team nazionale era composto da undici facilitatori organizzati in due nuclei: Lisbona e Porto. Espere consiste in due moduli di alcuni incontri ciascuno: un modulo sul perdono e uno sulla riconciliazione».
Padre Albino è il primo a promuovere il progetto Espere in Portogallo, ampliando così la crescente Rete internazionale già presente in diciannove paesi.

Liberazione e guarigione
I destinatari dei corsi sono i più vari: gruppi parrocchiali, comunità religiose, «abbiamo ricevuto richieste anche dalla Spagna – prosegue padre Albino -. C’è un grande desiderio di applicare i corsi anche nelle carceri.
Nell’ultimo organizzato, quasi tutti i partecipanti erano coordinatori e volontari del Servizio dei Gesuiti per i rifugiati (Jrs) la cui missione è “accompagnare, servire e difendere” i rifugiati, gli sfollati e tutti i migranti in situazioni di vulnerabilità.
È stato bello sapere che stavamo aiutando il processo di perdono e riconciliazione di tanti migranti. Spesso sono persone con ferite aperte, a volte rancori e risentimenti. Molti sono dovuti fuggire da guerre, persecuzioni religiose e politiche, tante situazioni avverse, tanto odio, ferite nel corpo e nell’anima che hanno bisogno di liberazione e di guarigione».

Spezzare la violenza
Oltre ai corsi, il missionario tiene diverse conferenze e interviste ai media nazionali. «Le persone mi confidano che l’approccio al tema del perdono e della riconciliazione porta molta novità nella loro vita. Si rendono conto che è la chiave per spezzare i circoli viziosi della violenza.
Sebbene questa metodologia sia nata in Colombia, in un contesto di “frontiera della violenza”, credo che essa sia necessaria anche per un paese come il Portogallo, e in un continente come l’Europa che, pur non avendo la guerriglia, vive altre forme di violenza: in famiglia, nella coppia, nelle scuole, al lavoro.
La via della convivenza, della fraternità e della comunione è una via che tutti dovremmo seguire, perché, quando perdoniamo, portiamo benefici a noi stessi prima ancora che alla persona che ci ha offesi.
I benefici del perdono non rimangono confinati nell’interiorità, ma hanno ripercussioni dirette anche sullo stato fisico di ciascuno. Papa Francesco dice che “il perdono è fonte di gioia, di salute, e chi non perdona si ammala fisicamente e mentalmente”. Oggi è noto che chi non perdona ha una maggiore tendenza ad ammalarsi.
Quando lo facciamo, interrompiamo questo ciclo. È un processo di guarigione personale e, a poco a poco, della società».

Il perdono evangelizza
Durante la pandemia il gruppo ha dovuto interrompere i corsi, perché la metodologia di Espere richiede la presenza fisica dei partecipanti. Padre Albino progetta di riprendere quest’anno, dopo l’estate.
Lui considera le Espere uno strumento privilegiato di evangelizzazione che l’Imc può utilizzare con frutto anche in Europa.
«Il perdono dei peccati è nel mandato missionario che Gesù dà agli apostoli. Fa parte della missione della Chiesa. E sarebbe una povertà se lo limitassimo al sacramento della Confessione.
Il perdono è un elemento della spiritualità umana. È un tema che sta acquisendo sempre più importanza anche in scienze come la psicologia, la sociologia, l’antropologia, la biomedicina.
In questo momento abbiamo una guerra fratricida in Ucraina, nel mezzo dell’Europa. Ma tutto il mondo è assetato di processi di perdono e riconciliazione.
Tutti i conflitti, tutte le guerre esistono perché le persone, i gruppi, i capi delle nazioni, i Paesi, si lasciano intossicare dal veleno di rancori e risentimenti storici che li fanno degenerare nella violenza. Questo è ciò che sta accadendo oggi nella Russia di Putin: in questo momento la capitale mondiale del risentimento e dell’odio.
Mi chiedo: quale futuro sarà possibile, dopo questa guerra, in quei paesi? Saranno nemici per sempre, in una sorta di guerra fredda perenne e di pace marcia?
In Europa, con tutti i problemi che ho già sottolineato, abbiamo più che mai bisogno di mediatori, di operatori di pace. E i missionari dovrebbero essere specialisti in questo. Mediatori di conflitti, facilitatori di comunione.
Quali altre vie di missione può percorrere l’Imc in Europa?».

Missionari sulla soglia
Padre Albino, durante la nostra intervista ci ricorda il Progetto missionario che l’Imc ha scritto nel 2021 durante la Conferenza della Regione Europa: «È un progetto che ci invita ad approfondire il “cosa”, il “come” e il “dove” della nostra missione in questo continente. Il tutto, ovviamente, tenendo conto di chi sono i missionari delle nostre quasi 40 presenze europee. Le nostre comunità, colorate con le tonalità dell’interculturalità, rappresentano un valore aggiunto in un’Europa dove i temi dell’accoglienza, dell’unità nella diversità e, più in generale, della fraternità vengono minacciati ogni giorno di più.
Mi piace quando il Progetto missionario chiede a noi missionari in Europa di essere persone che stanno “sulla soglia”, capaci di leggere la complessità della realtà, disponibili ad abitare le periferie esistenziali e antropologiche, ad andare dove altri non vogliono o non possono, chiamati a “prenderci cura” del creato, della giustizia, della pace e della riconciliazione, consapevoli che è questo che ci rende missionari».

Europa, luogo di missione
«Non è una novità che l’Europa sia oggi un innegabile campo di missione – aggiunge ancora padre Albino -. Il nostro istituto ha fatto scelte teoriche e missionarie molto attraenti: lavorare nelle periferie esistenziali, con gli immigrati e i rifugiati, dentro una società edonistica, individualista e consumistica.
Ma ho l’impressione che ci manchino alcuni strumenti per lavorare in una prospettiva veramente missionaria. La società cambia velocemente, e i missionari non sempre si preparano per accompagnare il cambiamento.
È necessario sintonizzarsi con un mondo segnato dalla massificazione delle tecnologie, dalla pluralità di voci e pensieri potenziati dalle reti sociali, dalle fake news, dall’intelligenza artificiale.
Di fronte a queste realtà, la reazione più immediata di molti di noi può essere quella di chiudersi e dire: “Se la realtà è così, peggio per la realtà!”. E allora, rimanendo fuori, il Vangelo cessa di avere la possibilità di essere lievito nella pasta, nella società.
Per questo, penso e sostengo che dobbiamo migliorare i nostri metodi. Sì, perché molte volte individuiamo le cause missionarie ma poi non definiamo il metodo: il come, con quali strumenti, definendo il processo.
Posso dire che il successo di Espere nel mondo deriva proprio da questo: aver trovato una metodologia efficace, un processo con dei passi da seguire e un risultato da presentare.
E questo dovrebbe essere trasversale a tutte le cause, i progetti e gli impegni missionari in una realtà e in un continente missionariamente impegnativo come l’Europa.
L’evangelizzazione qui non sembra facile, ma credo che, nella fede in Cristo e nella potenza del nostro carisma allamaniano e consolatino, è possibile».
Luca Lorusso

Le scuole di perdono e riconciliazione
Le Scuole del perdono e della riconciliazione (Espere, Escuelas de Perdón y Reconciliación) sono un percorso pensato per aiutare persone offese da diversi tipi di violenza a guarire le ferite, trasformare la memoria, generare pratiche riparatrici e ritrovare la fiducia. Sono improntate a una metodologia pedagogica esperienziale e ludica che attiva nei partecipanti un processo personale di perdono e riconciliazione che permette loro di identificare e alleviare le conseguenze delle violenze subite nella vita e di ristabilire dei legami sani con se stessi e con la comunità, generando coesione sociale.
Il programma Espere ha una durata di 96 ore suddivise in dodici moduli, e si sviluppa in due fasi: quella dedicata al perdono e quella dedicata alla riconciliazione. I gruppi sono composti normalmente da 15-21 persone.
Le Espere, ideate da padre Leonel Narváez Gómez, missionario della Consolata colombiano, attuale presidente della Fundación para la Reconciliación nata il 13 marzo 2003, si sono diffuse in 19 paesi e hanno lavorato con più di 2 milioni di persone.
Negli anni, hanno ricevuto diversi riconoscimenti nazionali e internazionali, tra cui il Premio Unesco per l’educazione alla pace nel 2006.
L.L.
fundacionparalareconciliacion.org
ARCHIVIO MC SU ESPERE:
– Paolo Moiola, Contro l’odio la scommessa del perdono, MC agosto 2018, pag 51.
– G. Testa, P. Farinella, L. Narváez, M. Nosengo, Ricordare con occhi differenti, Dossier MC, gennaio 2008.
SU ZAMBUJAL:
– Domenic Cusmano, C’era una volta il campo degli ulivi, MC giugno 2017, p. 63.
– Mário Linhares, Insieme a Zambujal, MC giugno 2009, p. 42