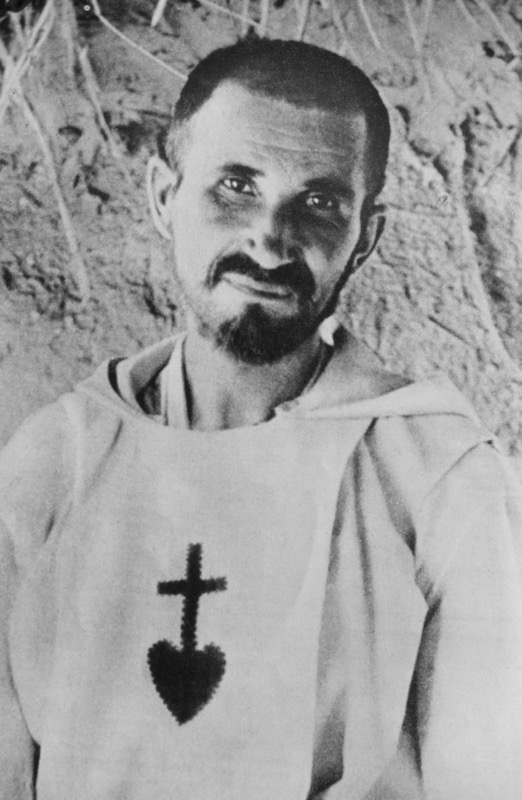Un luogo dove vivere (Es 23,20-24,18)
Il libro dell’Esodo è il racconto dell’uscita d’Israele dalla «casa di schiavitù», dall’Egitto, per diventare un popolo libero. Esso ci mostra che per ottenere tale libertà, non basta essere liberati dall’oppressore, come si scopre strada facendo. Dio, dopo aver portato il popolo nel deserto, gli ha proposto un legame personale definitivo, «sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo» (la citazione è di Lv 26,12, ma è il senso di Es 19,5-6). Questo legame, che in qualche modo era regolamentato dal decalogo, è stato ripreso e chiarito in modalità che ora vederemo e che ci permetteranno di evidenziare alcuni elementi importanti. Oltre a una terra da cui uscire, infatti, c’era anche bisogno di una terra in cui vivere, e questa è stata promessa, anche se la promessa non riguarda solo la terra, ma allude a tante altre cose.
Un angelo davanti a te (Es 23,20)
«Se ci fosse Dio» è una frase che abbiamo sentito o ci siamo trovati a pensare molte volte. Molto spesso, la frase esprime quello che noi pensiamo che faremmo se fossimo noi Dio. Si tratta di una tentazione, a cui, in qualche modo, questo testo risponde: «Ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato».
Dio promette che un «messaggero» (questo è il significato della parola «angelo») condurrà il popolo nella terra promessa. A chi si deve pensare? A un essere invisibile, non umano? A un intervento miracoloso? Nel Primo Testamento si parla spesso di «angeli», ma sembra sempre un modo per indicare l’intervento divino senza nominare Dio apertamente. Quasi mai leggiamo di interventi «magici» che risolvono le questioni. Normalmente gli uomini devono mettersi in gioco, conquistarsi la fiducia, interpretare e rischiare.
Sembra, insomma, che l’«angelo» di cui si parla sia un uomo. E non sembra che questi sia Mosè, altrimenti non verrebbe usato il futuro (peraltro, Mosè non arriverà nella terra promessa).
Dio invita il popolo ad avere fiducia: Lui interverrà. Ma non lo farà direttamente, bensì attraverso persone, delle quali bisognerà vagliare l’affidabilità, decidere se sono degne di fiducia.
È la presentazione della vita umana che non offre certezze ma invita a mettersi in gioco anche soltanto per valutare di chi fidarsi.
In tutta la storia dell’umanità occorre aspettarsi che Dio intervenga tramite persone umane che però potrebbero essere ingannevoli. Bisognerà, quindi, continuamente mettersi in gioco, cercare di capire, scommettere, fidarsi.
Il sogno di un legame
Il modo con cui Dio immagina la relazione con il suo popolo sembra davvero sognante: «Terrò lontana da te la malattia, non ci sarà donna che abortisce o sterile, ti farò giungere al numero completo dei tuoi giorni» (Es 20,25). Nell’originale ebraico tante parole sono tipiche della poesia, non di un trattato legale.
Il motivo si può cogliere nell’insistenza con cui Dio chiede che il popolo gli sia fedele, senza volgersi ad altri dèi.
Il richiamo alla fedeltà e il tono poetico (poco adatto a un trattato legale) ci possono fare avvicinare all’interpretazione più verosimile del passo: Dio non sta firmando un contratto, ma sta impegnandosi in un legame. Il paragone più vicino non è l’acquisto di una casa, ma un matrimonio. Dio sogna di essere amato, di vivere sempre insieme al suo popolo. Non è un legame di convenienza, ma di amore.
Ecco perché il testo insiste sul tenersi lontano dall’idolatria, sulla gelosia divina. L’immagine è precisa: Dio non vuole altri, perché è innamorato del suo popolo. Lo lega in un rapporto alla pari, perché lo ama. Con l’umanità non stipula un contratto di assicurazione, ma un legame di cuore per sempre, come uno sposo che sogna la sua vita insieme all’amata.
L’espulsione degli altri
Se da un lato Dio chiede al popolo di discernere chi sono i suoi angeli e di fidarsi di loro, da parte sua, sembra impegnarsi a scacciare chi occupa la terra che gli è destinata. Lo fa con attenzioni graduali e sorprendenti, affinché i nuovi occupanti non trovino poi una terra desolata e invasa da bestie selvatiche (23,29-30).
La nostra sensibilità moderna si stupisce e scandalizza: perché la salvezza di un popolo deve significare la morte o l’espulsione di altri?
Una prima risposta ha la sua radice nella mentalità semitica antica. Per quella cultura, chi si impegna in un compito deve innanzitutto dimostrare di esserne capace, di esserne all’altezza. Dio non può promettere agli ebrei che vivranno nella terra destinata a loro, se non è capace di fare piazza pulita di chi ci abita adesso. Noi amiamo vedere delicatezza e dolcezza, persino commozione e fragilità, anche nei potenti; la cultura che scrive queste righe, invece, voleva che il garante assicurasse di avere la forza necessaria per garantire.
Ma poi, strisciante, si insinua un’altra spiegazione appena andiamo a indagare più da vicino i nomi degli espulsi. In Gen 10,15-18 e 1Cr 1,13-16 troviamo elenchi più ampli, che arrivano a una dozzina di popolazioni. Qui ne troviamo «solo» tre, che ci lasciano un po’ perplessi: degli Ittiti sappiamo tanto, compreso il fatto che non si sono mai stabiliti in Palestina; i Cananei, invece, resteranno nella terra anche secoli dopo l’insediamento ebraico, continuando, soprattutto al Nord, a essere i vicini di casa, a volte più tollerati e a volte più odiati. Gli Evei, stranamente, non hanno lasciato alcuna traccia di sé se non in questi elenchi. Quando andiamo a controllare anche le liste più ampie, troviamo di nuovo popolazioni che avrebbero continuato a vivere insieme agli ebrei per lunghi secoli (Amorrei, Gebusei, Aramei) oppure altre di cui non abbiamo traccia se non in questi elenchi (Gergesei, Architi, Sinei, Semariti, Amatiti).
Agli archeologi e biblisti, dopo lunghe analisi, è venuto il sospetto che i nomi delle popolazioni che non hanno lasciato traccia di sé (in un territorio piccolo e arido come quello della Palestina) siano forse stati inventati. Come se Dio, innamorato del suo popolo, abbia esagerato il numero delle alternative a cui aveva rinunciato per la sua unica amata.
Non ci sembri irrispettoso. A noi pare che nella Bibbia debba trovare spazio solo ciò che è rigorosamente storico, secondo i nostri criteri moderni. Ma la storia, di fatto, ci dice che gli ebrei si infiltrarono quasi di soppiatto nella terra di Canaan, senza cancellare chi ci viveva già prima. In realtà questi testi che stiamo considerando sembrano più scritti poetici e retorici, che documenti storici. Storiograficamente potremmo ritenere falsa questa presentazione delle popolazioni scacciate, e considerarla invece come un tenero tentativo di ribadire al popolo d’Israele quanto il suo Dio ne è innamorato. Nel genere del canto d’amore, i particolari possono essere inventati, il contenuto di affetto, no.
![]()
Sul monte
Normalmente solo Mosè parlava con Dio, come ripete anche Esodo 24,2: «solo Mosè si avvicinerà al Signore». Di fatto, però, salgono sul monte anche Aronne, Nadab, Abiu e settanta anziani (24,9). E il loro messaggio sarà poi trasmesso a tutto il popolo.
Se è vero che, riprendendo anche l’umanissima tradizione della lontananza di Dio dall’umano, Esodo immagina che l’uomo non possa avvicinarsi al Signore senza morire (Es 20,19), qui però un’ampia rappresentanza del popolo lo incontra senza conseguenze (24,10-11). Da una parte Dio rimarca la sua distanza e alterità rispetto al mondo, dall’altra vuole incontrarsi con i suoi, e non sopporta di tenerli lontani o fare loro del male.
Sempre di più il comportamento di Dio si mostra comprensibile e affascinante se lo pensiamo diverso da un assicuratore, un legislatore o un condottiero, se lo vediamo come un innamorato che vuole mantenere la propria distanza e dignità ma, nello stesso tempo, e molto di più, non vuole in alcun modo perdere o fare del male al suo amato popolo.
Un’alleanza
In diverse occasioni, nel Primo Testamento, Dio viene ritratto nel gesto di stringere un’alleanza con gli uomini (Gn 6,18; 9,9-17; 15; 17,2-21; Es 6,4-5 …). In tutte queste situazioni il modello di alleanza è quello paritario. Dio, cioè, non stringe un patto con gli uomini tenendoli in condizione subalterna, come fossero dei sudditi.
Spesso noi non riusciamo a cogliere tutti i sottintesi di riti antichi che sicuramente erano meglio noti ai primi lettori dell’Esodo di venticinque secoli fa, ma qualcosa capiamo lo stesso. Il sangue, ad esempio, è simbolo della vita e dice la serietà del patto: idealmente, chi lo viola sarà tenuto a effondere il sangue proprio, in punizione. Ma è interessante che (in Es 24,6-8) il sangue venga sparso mezzo sul popolo e mezzo sull’altare: Dio non si tira fuori, non si ritiene superiore, anzi, minaccia anche se stesso di vendetta e punizione se violerà l’accordo.
I riti di iniziazione spesso calcano la mano sul rischio di morte, perché l’accordo è questione importante che va presa sul serio: questo vale anche, simbolicamente, nell’iniziazione cristiana, come si intuisce dal fatto che in greco il verbo «battezzare» significava «affogare». Qui, però, Dio si mette in gioco allo stesso modo: la sua natura è diversa da quella dell’uomo, ma lui accetta di «scendere» al livello umano, per un accordo che sia di vera reciprocità.
È significativo il fatto che non riusciamo a capire con precisione quale sia il contenuto di questa alleanza: è il decalogo (Es 20,1-17)? È il corpo legale più ampio (Es 20,22-23,19)? È qualcos’altro che non ci viene raccontato?
Cose da innamorati
Sembrerebbe che il cuore dell’accordo sia l’accordo stesso. Come, di nuovo, tra innamorati, a Dio pare interessare soprattutto stringere un accordo alla pari con un popolo di cui è innamorato. I contenuti dell’accordo sembrano secondari e riformabili (Dio li riformerà tante volte lungo la storia). Quello che non cambia pare essere solo la sua intenzione di continuare a relazionarsi con l’essere umano.
Si direbbe quasi che la vera terra che Dio promette è la relazione tra sé e l’uomo, tramite il popolo ebraico.
Un innamorato che fantastichi di vivere con la sua amata in una bella casetta solitaria sui monti, vivendo di allevamento e scaldandosi a legna, quando poi si trovasse a vivere in un appartamento con riscaldamento centralizzato e lavoro d’ufficio, potrebbe ritenere di avere compiuto il proprio sogno comunque: il sogno infatti è quello di vivere con la propria amata, non i dettagli del modo in cui vivere insieme.
E Dio sembra essere interessato soprattutto, o meglio solo, a continuare a vivere con il suo popolo. L’unico ostacolo immaginabile a tale sogno è il (possibile) rifiuto del popolo ad accogliere la piena comunione di vita con lui.
Angelo Fracchia
(Esodo 14 – continua)