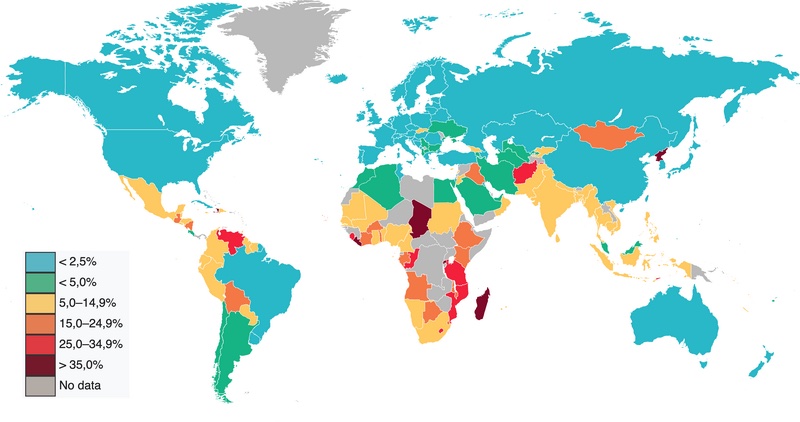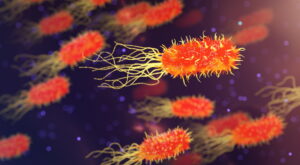Mongolia. Giovane Cardinale di una piccola chiesa
Dal 2003 è in Mongolia, paese che ama e che continua a stupirlo. Qui, con altri missionari e missionarie della Consolata, ha fondato una nuova parrocchia. Da agosto 2020 è prefetto apostolico di Ulaanbaatar. Poi l’annuncio di papa Francesco.
Nato il 7 giugno del 1974, cresciuto a Torino tra le parrocchie di sant’Alfonso, Regina delle Missioni e gli scout, Giorgio Marengo decide di entrare nei Missionari della Consolata dopo la maturità al liceo Cavour. Segue il percorso di formazione e viene ordinato a Torino, nel 2001, all’anniversario dei 100 anni dell’Istituto. Nel 2003 è nel primo gruppo di missionari in partenza per la Mongolia.
L’ordinazione episcopale arriva ad agosto 2020. Poi, a sorpresa, il suo nome compare nella lista dei nuovi cardinali, resa nota da papa Francesco lo scorso 29 maggio. Viene quindi nominato nel concistoro del 27 agosto. È il cardinale più giovane, ed è il primo tra i Missionari della Consolata e della chiesa in Mongolia.
Ci accoglie con un grande sorriso, e la disponibilità che lo contraddistingue, nonostante i tanti impegni di un periodo frenetico.
![]()
Come descriverebbe la Mongolia in poche parole?
«È un paese affascinante, molto bello, con tanti contrasti, a cominciare da quelli climatici. C’è il deserto freddo più grande del mondo, d’estate +40°, d’inverno
-40°. L’impatto dell’uomo è poco visibile. È il secondo paese meno popolato del mondo (su una superficie 5,2 volte l’Italia, vivono 3,3 milioni di persone).
È difficile da definire, ma possiamo parlare di due Mongolie, quella della capitale e poi tutto il resto. Entrambe rappresentano la Mongolia, ma in maniera diversa. Ulaanbaatar è una capitale evoluta, tecnologica, con molte costruzioni moderne, lo stile di vita è urbano. Negli ultimi dieci anni si è trasformata. La Mongolia dell’interno è quella tradizionale, dell’allevamento, delle grandi distese, delle tradizioni, dell’isolamento, del vuoto.
Un forte elemento identificativo è la storia. Ovvero Gengis Kahn e il ruolo dominante dei mongoli nel XIII secolo, quando hanno costituito l’impero più grande di sempre. Questo ha plasmato la coscienza comune. Sono un popolo molto fiero.
Oggi sono un paese sovrano e democratico in mezzo a due superpotenze, la Federazione Russa e la Cina popolare. La Mongolia è un paese che mantiene la sua identità, e vuole confermare la propria sovranità, su base democratica e di rispetto dei diritti e della libertà.
È stata per settant’anni una repubblica popolare, non formalmente membro dell’Urss, ma totalmente allineata alla politica sovietica. Questo ha implicato questioni molto gravi, compresa la repressione del buddhismo, la cancellazione della libertà religiosa, grosse sfide alla cultura, l’imposizione del cirillico al posto della scrittura mongola, l’ateismo di stato. Quei 70 anni hanno impattato, ma oggi, dopo 30 anni dalla fine del regime, la democrazia è affermata».
La Chiesa cattolica ha compiuto 30 anni nel paese. Come è stato l’inizio?
«All’indomani delle prime elezioni democratiche nel ‘92, quando si è costituito il primo governo multipartitico, questo ha voluto dimostrare al mondo l’impegno di tutelare la libertà di religione e di culto. Inoltre, il paese aveva molto bisogno di aiuto dall’estero perché, come è sempre successo nel post-comunismo, subito c’è stata una fase di grande crisi economica. Così il governo mongolo ha chiesto alla Santa sede di ristabilire relazioni diplomatiche. Di solito accade il contrario.
La Santa sede si è subito attivata e, per motivi storici, ha proposto alla congregazione del Cuore immacolato di Maria (Scheut) di andare in Mongolia. Intanto padre Jeroom Heyndrickx, noto
sinolgo, aveva già compiuto una prima esplorazione nell’ottobre 1991, così nel luglio 1992, sono stati mandati tre missionari, i padri Robert Goessens, Gilbert Sales (belgi) e Venceslao Padilla (originario delle Filippine). Questi hanno cominciato a inserirsi, creato contatti, e hanno fatto una grande attività di promozione umana, facendo arrivare tanti aiuti in un paese che allora era in ginocchio.
Con grande capacità relazionale, soprattutto di Padilla, si sono costituite le prime realtà ecclesiali, da un nucleo che si ritrovava nell’appartamento in affitto nel quale i missionari vivevano. Si sono create relazioni stabili con gente interessata a questioni di fede e dieci anni dopo, la Santa Sede ha eretto la Prefettura apostolica. Padilla è stato ordinato prefetto e poi vescovo nell’agosto 2003.
Noi Missionari della Consolata ci siamo inseriti nel luglio 2003, quando era ancora un’esperienza pionieristica.
Il cambiamento più grande è stato tra il 2003 e il 2010, quando c’è stato un grosso boom economico, legato ad aiuti e investimenti. La Mongolia ha accelerato la trasformazione interna, e questo si è riflettuto un po’ anche sulla realtà ecclesiale».

Ci racconta i primi passi della Consolata?
«I primi tre anni ci siamo dedicati a imparare la lingua, nella capitale Ulaanbaatar, iniziando a guardarci intorno per vedere dove installarci. La presenza missionaria si concentrava nella capitale, e noi volevamo metterci a disposizione di qualsiasi altra realtà che non fosse stata ancora raggiunta. Mons. Venceslao Padilla ci disse di fare noi il discernimento, e così facemmo, sempre in comunione con lui. Dopo una serie di viaggi esplorativi la Provvidenza ci ha portati in una zona del centro Sud, vicino al deserto del Gobi. Così ci siamo stabiliti nel 2006 ad Arveiheer, capoluogo della provincia. Eravamo due padri e tre suore. Abbiamo cominciato tutto da zero. È stata una bellissima esperienza di vita, di missione, di fede. Perché lì la chiesa non c’era mai stata.
Avevamo bisogno delle autorizzazioni delle autorità locali, e abbiamo vissuto in affitto condividendo la vita della gente di realtà diverse. Poi il governo ci ha dato il permesso e si è avviata la missione».
Come è organizzata oggi la Chiesa cattolica in Mongolia?
«Abbiamo dieci luoghi di culto riconosciuti dallo stato, di cui otto parrocchie e due cappelle (cinque in capitale e dintorni, due nel Nord e una ad Arveiheer). Sono il fulcro della vita cristiana. Abbiamo 22 sacerdoti di cui due sono mongoli, 35 suore, alcuni laici missionari, per 11 congregazioni e 24 nazionalità. I catechisti, sui quali si è investito e si continua a investire, sono i principali protagonisti dell’evangelizzazione, grazie al fatto che sono membri di questo popolo e che possono esprimere con lingua e categorie culturali locali i contenuti essenziali della fede e accompagnare le persone nel loro percorso, con un discorso di comunità e fraternità.
Il 71% delle nostre attività sono di tipo sociale: promozione umana e sviluppo, educazione, sanità, assistenza, promozione e diffusione della cultura mongola. La chiesa è impegnata in settori di utilità comune, non specificamente religiosi. Quest’anno, oltre al sinodo stiamo celebrando i primi 30 anni della chiesa in questo paese e ci siamo fermati a riflettere. Io sono dell’idea che, probabilmente, le priorità non sono più quelle di 20-30 anni fa. Forse dobbiamo gradualmente riorientare le nostre energie verso obiettivi più attuali.
Ho scritto la mia prima lettera pastorale e ho proposto tre parole fondamentali: profondità, fraternità e annuncio.
Profondità, perché il seme è stato gettato, la testimonianza della prima generazione di missionari è stata feconda, accolta. Se abbiamo una comunità cristiana è perché le persone che la compongono hanno veramente accolto il Signore nella loro vita. Adesso però c’è bisogno che questa vita embrionale di fede raggiunga le fibre più profonde della persona e delle comunità, che non sia qualcosa di superficiale che poi è soggetta all’abbandono, ma si approfondisca continuamente.
Fecondità, perché questa piccola comunità rischia, come accade ovunque, di frazionarsi nelle otto parrocchie, anche a causa delle tendenze centrifughe delle varie congregazioni.
Annuncio, per non dimenticarci che, se siamo lì è perché con discrezione e con umiltà vogliamo condividere la nostra fede, e quindi non aver paura di continuare ad annunciare Cristo».
![]()
Cosa vuole dire essere una chiesa di minoranza?
«Essere una minoranza è una grazia, perché ci riporta al messaggio delle parabole: un po’ di lievito, un pizzico di sale, una candela, un seme caduto nel terreno. Il Signore quando ha parlato del Regno di Dio ha sempre fatto riferimento a immagini del poco nel tanto, quindi io l’ho vissuta così e continuo a viverla come una grazia. Ci porta a questa dimensione dell’autenticità messa alla prova per il fatto che non è per nulla scontato essere cristiani, ed essere accettati come tali. Usiamo spesso il parallelo con gli Atti degli apostoli.
Essere minoranza può avere, da una parte, il rischio di portarci a dire: stiamo bene tra di noi, siamo piccoli, siamo poveri. Questo non è il nostro caso. Dall’altra, quello di porci l’obiettivo di diventare noi maggioranza, cioè raggiungere una situazione in cui sia socialmente accettabile e auspicabile diventare cristiani. Ritengo che l’esperienza dell’Occidente sia importante, fondamentale, ma non è l’unica, e nella storia ha rappresentato una piccola sezione in ordine di tempo e di spazio. È importante il fatto di non dare nulla per scontato nell’esercizio della fede, perché è un continuo provare a metterla in circolo nella vita concreta, in una società in cui i punti di riferimento sono altri. È una provocazione sana, che ci fa rimanere umili, attenti, che ci fa dire: questa strada non funziona, allora ne proviamo un’altra.
L’importante è curare l’autenticità del messaggio e della vita di fede, aiutando le persone a viverla con coraggio e serenità, perché diventare cristiano per un mongolo è una scelta impopolare, che lo espone anche alla derisione sociale.
Come aiutare queste persone ad appropriarsi della fede, ad approfondirla in modo che poi diventi sorgente di una nuova interpretazione della realtà, in armonia con l’identità culturale, ma anche capace ogni tanto di provocare, è una delle grandi sfide.
Anche se in Italia è generalmente accettato, il messaggio del Vangelo è comunque sempre controcorrente, non è mai assimilabile a una cultura o società».
Com’è la relazione con le altre religioni?
«Essere minoranza ha come aspetto bello che ti fa percepire la ricchezza delle tradizioni religiose diverse. Per noi sono il buddhismo di matrice tibetana, che nel paese oramai si chiama buddhismo mongolo, poi lo sciamanesimo, come anche l’islam praticato nell’Ovest, nella comunità kazaca, e anche delle altre tradizioni religiose recenti, il bahaismo o le altre denominazioni cristiane non cattoliche.
C’è un rapporto con tutti, ma il migliore lo abbiamo con il buddhismo, rappresentato dalle loro istituzioni e dai loro leader, con cui abbiamo un cammino trentennale continuo. Il 28 maggio scorso il Papa ha ricevuto in udienza due autorità del buddhismo mongolo, uno è l’abate del secondo monastero della Mongolia.
Esiste una rete di incontri interreligiosi che, fino a un anno fa, erano annuali e ora sono quasi mensili: a turno uno dei leader religiosi ospita gli altri, si mangia, si discute di temi comuni. L’orizzonte di questi incontri è da una parte conoscitivo (solo se ci si conosce bene ci si rispetta, ci si apprezza), e dall’altra pensare quali obiettivi raggiungere insieme».
![]()
Come si diventa cattolici in Mongolia?
«Quando siamo andati ad Arveiheer non c’era nessun cristiano. È stato interessante vedere come la grazia si fa strada. È una storia di relazioni, di amicizia con i missionari e le missionarie, attraverso la quale le persone vengono in contatto con un mondo che si apre loro e che magari all’inizio è legato a una loro necessità. Da notare che la campagna ha conosciuto lo sviluppo dieci anni dopo la capitale. Per cui quando siamo arrivati c’era molta povertà. Quando abbiamo avuto il permesso di svolgere le nostre attività, la curiosità e l’amicizia ha portato le persone per la prima volta a mettere la testa dentro la nostra gher, a vedere cosa vuol dire la preghiera dei cristiani. O a vedere questi poveri stranieri imbranati che cercavano di rendersi utili con una mentalità di non sfruttamento degli altri e, possibilmente, di aiuto. Questo faceva sorgere dei punti di domanda, e le persone, gradualmente, senza correre, chiedevano di approfondire.
C’è sempre una specie di pre catecumenato, che è un periodo fluido di contatti, di relazione, di amicizia, fino a quando la persona formula la sua richiesta, che noi vogliamo sia scritta: io voglio iniziare un percorso di fede. Si propone la catechesi e il catecumenato dura due anni. Stiamo lavorando per preparare il materiale catechetico di base. Poi c’è l’iniziazione, il battesimo.
Oggi i cristiani in Mongolia sono di prima ma anche di seconda generazione. A chi è battezzato ed è riuscito a conservare la fede anche nella vita famigliare, si propone di far fare il cammino della catechesi anche ai loro figli. Non abbiamo mai insistito, abbiamo sempre aspettato che la gente si proponesse».
Quale ruolo può avere la chiesa mongola tra le chiese asiatiche?
«In Asia ci sono tante esperienze interessanti e anche diversificate tra di loro. È un arricchimento reciproco. Il blocco del Sud Est asiatico è erede di un’epopea missionaria dell’800 in cui i missionari erano provenienti da nazioni coloniali, un tema che in Mongolia non c’è. Non c’è mai stata sovrapposizione di poteri politici ed ecclesiastici. Lì c’è una cristianità più radicata, antica. Noi siamo la chiesa più giovane d’Asia.
Nella Federazione delle conferenze episcopali dell’Asia (Fabc, fondata nel 1971), c’è un clima molto fraterno. I vescovi di tutta l’Asia si incontrano, condividono, dialogano, cercano vie comuni.
Da aprile sono entrato a fare parte della neonata conferenza episcopale dell’Asia centrale. Nell’autunno 2021 la Santa Sede l’ha istituita raggruppando le cinque repubbliche ex sovietiche, l’Afghanistan e la Mongolia.
A parte le Filippine e la Corea, dove ci sono le due chiese più affermate, per il resto, in tutta l’Asia siamo minoranza. In certi paesi ha buoni rapporti con lo stato, in altre parti è una chiesa sofferente».
![]()
Quali sono le sfide della Chiesa in Asia?
«Riuscire a essere un faro per i diritti là dove esistono regimi non morbidi, un agente di coesione e pace sociale, di promozione del dialogo: è una sfida grande in tutta l’Asia. Anche nei paesi di tradizione più affermata. Le comunità cattoliche in tutto il continente sono dei baluardi di umanità, fede, spiritualità, rappresentano una bella testimonianza.
L’ateismo puro in Asia non esiste, è esistito imposto dal comunismo, ma il tema non è Dio o non Dio, piuttosto quale Dio. Non c’è mai stato l’illuminismo quindi la cesura tra ragione e fede, tra uomo religioso e uomo scientifico non è mai esistita. In Asia si deve portare avanti un discorso di dialogo, per dire con quali valori comuni, noi seguaci di tradizioni religiose diverse, possiamo promuovere il bene di questi paesi. Poi c’è il discorso più teologico: io ho collaborato con il Pontificio consiglio per il dialogo interreligioso che organizza periodicamente un colloquio buddhista-cristiano».
Secondo lei, perché un cardinale in Mongolia?
«Bisogna chiederlo a papa Francesco. Conoscendolo, per lui queste esperienze di chiesa in situazioni di minoranza e marginalità sono preziose, e allora forse vuole che siano conosciute di più e rappresentate».
Quali sono i progetti futuri?
«Vorremmo riuscire a vivere la progettualità da un punto di vista più unitario, comunionale: non solo le singole congregazioni con i loro progetti, ma unire le forze per ottimizzare le cose già meravigliose che i singoli missionari stanno facendo.
Abbiamo rilevato un edificio in capitale, e vorremmo creare la Casa della misericordia, un luogo di accoglienza e consolazione, per rendere la chiesa un porto sempre accessibile a chiunque, con qualunque necessità».
Marco Bello