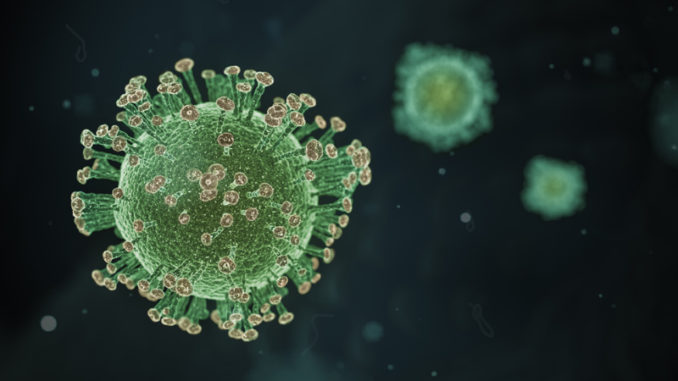
testo di Francesco Gesualdi |
Siamo dovuti arrivare con l’acqua alla gola per iniziare a cambiare. Tra la vita e la ricchezza abbiamo scelto la prima. Ora dobbiamo rivedere profondamente stili di vita e forme economiche. Una sfida inevitabile e non indolore, ma affrontabile.
Sembrava che niente potesse fermarci. Né gli uragani, né lo scongelamento delle calotte polari, né gli appelli disperati di Greta Thunberg. Insensibili a tutto, abbiamo continuato a spostarci freneticamente, a consumare oltre ogni logica di buon senso, a invocare la crescita come il nostro massimo bene. Ma poi è arrivata una minuscola forma di vita, neanche una cellula, addirittura un frammento di Rna, e ci ha fermati. Semplicemente perché ci ha fatto vedere la morte in faccia, come invece non sono capaci di farci vedere i cambiamenti climatici, troppo lenti per metterci paura.
La legge del rospo
È la legge del rospo. Se lo metti in una pentola di acqua bollente, avverte di essere in pericolo di vita e, raccogliendo tutte le sue forze, con un balzo salta fuori dalla pentola. Ustionato, ma vivo. Se invece lo metti in una pentola di acqua fredda e vi accendete sotto il fuoco, il rospo si adatterà alla temperatura crescente e vi morirà dentro, bollito. Il coronavirus (e Covid-19, la patologia che genera) è stato avvertito come un pericolo mortale e abbiamo reagito: se dobbiamo scegliere fra la vita e la ricchezza scegliamo la vita. Per questo abbiamo accettato di rinunciare a viaggi e vacanze, abbiamo disertato le autostrade, abbiamo evitato ristoranti, stadi e sale cinematografiche, non ci siamo lamentati dei tagli ai voli aerei e alle corse ferroviarie. Abbiamo accettato di fare le code ai supermercati, di lavorare da casa quando era possibile, di non presentarci al lavoro in assenza di mascherine.
Pur nella sua drammaticità, la capacità che abbiamo avuto di reagire di fronte al coronavirus è di buon auspicio: significa che siamo ancora capaci di scegliere. Ma scegliere solo perché si ha l’acqua alla gola non è la miglior strategia di cambiamento. I drammi ambientali e sociali che abbiamo accumulato, ci impongono di rivedere in profondità stili di vita e forme economiche, ma la sfida è farlo in maniera indolore. In fondo la scelta che dobbiamo compiere è proprio questa: proseguire la nostra corsa frenetica finché non ci schianteremo contro il muro o frenare e deviare finché siamo in tempo? Se fossimo intelligenti sceglieremmo la seconda strada: prenderemmo atto della necessità di ridurre e programmeremmo la transizione introducendo gradualmente tutte le riforme che servono in ambito produttivo, sociale, politico, in modo da attuare la sostenibilità senza che nessuno abbia a rimanere senza lavoro e, quindi, senza mezzi di sostentamento.
«Covid-19 ci ha costretto a fermarci e, speriamo, anche a riflettere. Da un lato ha messo in ginocchio il nostro modello industriale, mettendo in crisi il lavoro e la vita di milioni di persone, ma dall’altro, paradossalmente, ha ridotto massicciamente le emissioni di gas serra nel mondo (oltre il 25% solo in Cina) e ha ripulito l’aria della Pianura Padana dalle polveri sottili. Non facciamo sì che un ritorno alla normalità significhi rimpiazzare le mascherine antivirali con quelle antismog». Così scriveva un gruppo di parlamentari in una lettera ad Avvenire il 18 marzo 2020. E forse è proprio dalle contraddizioni che il coronavirus ha messo in evidenza che potremmo cominciare per riformare la nostra economia. Mi limiterò solo a due aspetti.
Per un’economia locale
Il primo si riferisce alla carenza di mascherine: in Italia non se ne trovano semplicemente perché non esiste più un’impresa che le produca. Conseguenza di una globalizzazione totalizzante che, portando alle estreme conseguenze la teoria dei vantaggi comparati, ha trasferito in Cina e altri paesi a basso costo produttivo qualsiasi tipo di produzione. Tutte le scelte a senso unico, prima o poi, presentano il conto, perché la vita non è mai fatta di un solo elemento, ma di tanti aspetti che devono stare in equilibrio fra loro. L’impostazione mercantile pretende di imporci come unica legge la convenienza monetaria. Di conseguenza ci ha catapultati in una globalizzazione incondizionata, che però ci ha fatto prima subire contraccolpi sul piano ambientale e poi anche su quello della sicurezza sanitaria. Già venti anni fa Wolfgang Sachs ci aveva avvertito della necessità di ritrovare il senso di casa che non vuol dire rinchiudersi nell’autarchica, tanto meno avventurarsi in guerre commerciali, ma valorizzare l’economia locale. Ogni paese dovrebbe produrre tutto il possibile per la propria popolazione in modo da evitare trasporti inutili, salvaguardare l’occupazione, tutelare la propria autonomia. Quando l’emergenza sarà finita dovremo impegnarci per fare cambiare le regole dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) affinché l’obiettivo non sia più l’espansione del commercio fine a se stesso, ma la salvaguardia delle economie locali, la tutela dei diritti dei lavoratori, la riduzione dell’anidride carbonica.
Lo stato e la UE
Il secondo spunto di riflessione offerto dalla situazione creata dal coronavirus riguarda lo stato: il suo ruolo e le sue vie di finanziamento. Di fronte alle difficoltà in cui sono venuti a trovarsi cittadini, ospedali, interi comparti produttivi, giustamente lo stato ha deciso di intervenire con stanziamenti eccezionali, non solo per rafforzare gli interventi di prevenzione e cura contro l’infezione, ma anche per sostenere i redditi, salvaguardare l’occupazione e potenziare gli ammortizzatori sociali di quanti stavano subendo un danno economico dall’epidemia. In gioco c’erano migliaia di posti di lavoro e quindi il pane di migliaia di famiglie: intervenire era un obbligo morale e sociale prima ancora che un’esigenza economica.
Chiarita l’assoluta necessità di intervenire, non si può fare a meno di considerare che l’operazione è stata fatta a debito peggiorando un quadro già molto critico. Non tanto per le maggiori somme che dovremo restituire a titolo di capitale, quanto per la maggiore quantità di denaro che dovremo sborsare a copertura degli interessi. Soldi dei cittadini che in misura crescente saranno distolti da servizi e investimenti collettivi per finire nelle tasche dei nostri creditori. È il solito vecchio gioco del sollievo di oggi che prepara la pena del domani.
Ma davvero non abbiamo altro destino?
Diciamocelo: l’economia non è come la fisica che è governata da regole naturali immodificabili come la forza di gravità. L’economia è frutto di regole umane che possiamo cambiare in ogni momento. E se oggi ci troviamo nella condizione di non avere altro modo di affrontare le emergenze se non indebitandoci, è perché abbiamo fatto scelte assurde nella gestione della moneta. C’è una certa ritrosia a criticare l’euro perché non si vuole mettere in discussione l’appartenenza all’Unione europea. Ma l’attaccamento all’Europa non si dimostra accettando tutto ciò che fa, bensì sapendo criticare ciò che non va. Chi critica e propone modifiche dimostra di amare l’Europa più di chi l’accetta così com’è. I sentimenti antieuropei sempre più diffusi da un capo all’altro dell’Unione non hanno matrice ideologica, ma pratica. Sono frutto dell’esperienza di chi ha constatato che le regole europee hanno esacerbato la concorrenza fra lavoratori, hanno aggravato l’austerità, hanno accelerato le delocalizzazioni produttive all’interno dell’Unione, hanno lasciato soli i paesi di prima linea nell’accoglienza dei migranti. E la conclusione di molti è il ritorno ai nazionalismi. Giustamente ce la prendiamo con certi politici che cavalcano le paure e il malcontento per consolidare la propria posizione di potere, ma l’unico modo per sbarrare la strada all’avanzata dell’onda nazionalpopulista è la correzione dell’Europa in un’ottica di maggiore sensibilità sociale. Che non si fa a parole, ma con riforme radicali a cominciare dalla gestione dell’euro.

Senza fare nuovo debito
L’euro è stato concepito in piena era neoliberista, quando i governi non erano più visti come attori indispensabili per l’economia, ma come nemici da esautorare se non da combattere. Per cui si è deciso di gestire la moneta unica in una logica puramente mercantilistica con un accanimento particolare verso i governi a cui la Banca centrale europea non poteva, e tutt’ora non può, prestare neanche un centesimo. Dell’assurdità di questa misura ci siamo resi conto nel 2011 quando i paesi più deboli e più indebitati sono diventati preda della speculazione internazionale. La situazione è stata ripresa per i capelli da Mario Draghi (al quale ora è subentrata Christine Lagarde) che, tramite alcune forzature, è riuscito a trasformare la Bce nel più potente acquirente di titoli di stato sul mercato secondario. Il che non solo ha fermato gli speculatori, ma ha anche indotto una notevole riduzione dei tassi di interesse applicati ai debiti sovrani. Il nostro paese è stato fra quelli che più hanno risentito dell’effetto benefico di questa politica perché ha visto passare la spesa per interessi da 83 miliardi nel 2012 a 64 miliardi nel 2018 nonostante una crescita del debito complessivo.
Poter pagare bassi tassi di interessi è già un sollievo, ma quando la spesa complessiva per il servizio del debito assorbe comunque il 10% delle entrate pubbliche, bisogna trovare dei modi per poter finanziare le emergenze sociali, sanitarie, ambientali, economiche senza ricorrere a nuovo debito. Il che è possibile a patto che si riformi la Banca centrale europea. Bisogna riaffermare il principio che la moneta deve essere gestita avendo come priorità la piena occupazione, l’espansione dei servizi pubblici, la tutela dei beni comuni, la difesa delle famiglie più bisognose. Obiettivi che hanno guidato il governo delle monete nei gloriosi trent’anni successivi alla Seconda guerra mondiale, anni durante i quali i paesi europei hanno conosciuto il più alto tasso di crescita economica, di occupazione e di sviluppo della sicurezza sociale grazie all’azione guida dei governi e a un uso sociale della moneta. Il principio base è che, in condizioni di emergenza, i governi debbano poter finanziare le spese supplementari con denaro ottenuto direttamente dalla Banca centrale, a tasso zero sotto forma di debito irredimibile. La cosa può fare paura per la quantità di nuovo denaro di cui può essere inondato il sistema, ma non è senz’altro un problema di oggi. Dal 2015 al 2018 la Banca centrale europea ha iniettato nel sistema economico 2.650 miliardi di nuova liquidità, ma lo ha fatto acquistando titoli, privati e pubblici, dalle banche commerciali e da altri investitori privati. Se avesse usato lo stesso denaro per finanziare direttamente i governi, più che una crescita della finanza, avremmo avuto una crescita dell’occupazione, dei servizi pubblici, degli investimenti verdi. In conclusione, avremmo avuto un effetto benefico assicurato per l’economia reale e la realtà sociale, che invece continuano a dibattersi nei problemi di sempre. Dal 1992, anno in cui veniva firmato il Trattato di Maastricht che istituiva l’euro e questa Banca centrale europea, sono passati quasi trent’anni. È tempo di rivederlo, in modo da non essere più costretti a dover andare in Europa per chiedere più flessibilità, ossia possibilità di fare nuovo debito, ogni volta che si ha l’acqua alla gola, ma di poter ottenere nuova liquidità per gestire le emergenze senza fare nuovo debito. Si può fare, ma qualcuno deve avere il coraggio di gridare che il re è nudo.
Francesco Gesualdi