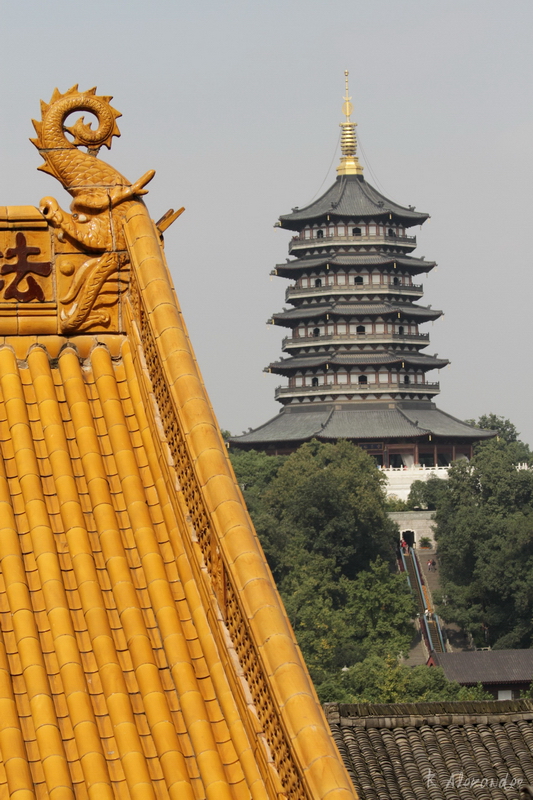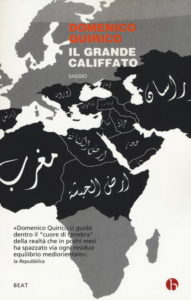Gli Yanomami e le decisioni condivise
Testo e foto di Paolo Moiola
Dal 2015 associazioni e leader degli Yanomami si riuniscono per elaborare un «Piano di gestione territoriale e ambientale» (Pgta) della loro terra. Un sistema che, usando parole del mondo bianco, si potrebbe definire di «democrazia partecipativa». L’ultima assemblea si è tenuta sul lago Caracaranã, nella terra indigena Raposa Serra do Sol, a circa 200 chilometri da Boa Vista, capitale di Roraima. Vi raccontiamo come si è svolta.
La Br-401 conduce in Guiana. È asfaltata, liscia, dritta e poco trafficata: motivo d’orgoglio per i politici locali che si autocelebrano con alcuni cartelloni pubblicitari posti lungo la strada.
Siamo in Amazzonia, ma il paesaggio sembra suggerire altro. Al posto della foresta c’è il cosiddetto lavrado, un ecosistema molto simile alla savana. Anche qui l’agrobusiness, l’industria agricola, sta facendo danni con la diffusione dell’allevamento estensivo e delle monocolture. «Riso, soia e Acacia mangium», mi spiega Carlo Zacquini che guida l’auto.
L’Acacia mangium è una pianta di origine asiatica, caratterizzata da una rapida crescita. Certamente più consone all’ambiente originale del lavrado sono le piante di burití (Mauritia flexuosa), una palma che dà frutti commestibili usati in svariati modi, tra cui sotto forma d’olio.
Passiamo accanto a varie fattorie: fazenda Arizona, fazenda Nova Altamira, fazenda Rio das Pedras e molte altre di cui non riesco ad annotare il nome perché fratel Carlo non toglie mai il piede dall’acceleratore.
Percorsi poco più di cento chilometri, lasciamo la 401 per girare a sinistra su una strada sterrata rossa. Direzione municipio di Normandia. Di lì a poco, superato il fiume Tacutu, un cartellone ci avverte che stiamo entrando nella terra indigena Raposa Serra do Sol, abitata in prevalenza da Macuxi ma anche da Taurepang, Ingarikó, Patamona e Wapichana.
Una nuova deviazione prima di arrivare alla cittadina di Normandia ci conduce in breve alla nostra meta: il lago Caracaranã sulle cui sponde i Macuxi gestiscono una piccola struttura, spesso adibita a luogo d’incontri.
L’ingresso è un cancello di legno tipo fazenda o ranch. Con accanto un cartello sbilenco ma leggibile: «Proibido entrada com bebidas alcoólicas» (Proibita l’entrata con bevande alcoliche).
Ci vengono ad aprire e posteggiamo accanto alle uniche due automobili presenti. Un’ottima cosa in ottica ambientalista.
![]()
Gli Yanomami e gli altri
Il posto è bello. Alberi (quasi tutti di caju, Anacardium occidentale), prati, una spiaggetta di sabbia bianca che delimita un lato del lago, piccolo ma delizioso.
La struttura ricettiva che è stata costruita è semplicissima e poco impattante. Ci sono alcune piccole costruzioni in muratura a un solo piano e poi varie capanne senza pareti sotto le quali gli ospiti appendono le loro amache. Al centro c’è un capannone, anch’esso senza pareti, dove si svolgono gli incontri plenari.
In questi giorni (ben sette in totale) la struttura sul lago Caracaranã ospita una riunione delle organizzazioni e dei leader Yanomami arrivati, spesso dopo viaggi lunghi e complicati, da varie comunità sparse sul loro vastissimo territorio.
Uno striscione dai colori vivaci, steso davanti al capannone delle riunioni, presenta l’evento: «Plano de Gestão territorial e ambiental Terra indígena Yanomami». In basso sono riportati nomi e loghi dei partecipanti.
Gli organizzatori sono due: Hutukara, la principale tra le associazioni degli Yanomami (quella guidata da Davi Kopenawa) e Isa, l’Istituto socioambientale brasiliano cui vanno ascritti molti meriti. Tra i collaboratori, le altre organizzazioni Yanomami e la Missione Catrimani. Tra i finanziatori (indispensabili) figurano la Norvegia, il Fondo Amazzonia, l’Unione europea.
Gli indigeni presenti sono oltre ottanta, in maggioranza uomini, ma ci sono anche donne e alcuni bambini. Portare alle assemblee persone che abitano in comunità distanti e spesso isolate richiede sempre uno sforzo organizzativo e finanziario importante.
All’assemblea partecipano anche due organizzazioni governative: la Fundação Nacional do Índio (Funai) e l’Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (IcmBio), che dipende dal ministero dell’Ambiente. Si tratta di due organizzazioni controverse (soprattutto la Funai), ma qui i loro rappresentanti – tutti giovani – sembrano molto bendisposti e coinvolti.
![]()
Come gestire la terra indigena?
Cosa sia il «Piano di gestione territoriale e ambientale» viene spiegato nel materiale conoscitivo distribuito al banco dell’organizzazione: «È un documento che contiene le proposte di come gli Yanomami e gli Ye’kuana debbono prendersi cura della loro terra e di come il governo e le istituzioni partner debbono lavorare per migliorare la protezione territoriale, l’assistenza sanitaria e l’educazione, la gestione dei redditi e la valorizzazione delle conoscenze tradizionali».
La gestione territoriale e ambientale della Terra indigena yanomami è una tematica complessa. In primis, perché riguarda un territorio che si estende su 96.650 chilometri quadrati (più o meno la grandezza del Nord Italia meno l’Emilia) di Amazzonia, uno spazio che genera enormi appetiti tra i non indigeni.
Detto questo, la prima impressione sull’assemblea indigena del lago Caracaranã è molto positiva: l’organizzazione è ineccepibile. Un cartello appeso nel capannone centrale riporta l’elenco dei gruppi tematici: protezione e controllo, governo, redditi, conoscenze tradizionali, risorse naturali, salute, educazione. Ogni gruppo discuterà una serie di proposte sul tema prescelto, dovendo rispondere a due domande fondamentali: come attuare le varie proposte e con chi, distinguendo tra indigeni e non-indigeni.
Una volta formati, i sette gruppi si distribuiscono negli spazi della struttura: chi attorno a un albero, chi sotto una tettoia. Per agevolare e coordinare le discussioni ci sono dei facilitatori (moderatori), ruolo assunto dai non indigeni.
![]()
Fratel Carlo Zacquini, dopo aver salutato a destra e a manca, si aggrega come partecipante a un gruppo. Io, unico estraneo, sono libero di passare da un gruppo all’altro per scattare foto e fare qualche filmato (dopo il permesso ottenuto da Davi Kopenawa).
La lingua utilizzata è il portoghese ma, non essendo compresa da tutti i partecipanti, in ogni gruppo c’è una persona che fa da traduttore. Davi Kopenawa è sotto il capannone centrale nel gruppo in cui si parla di governança (governo). Qui ci sono anche alcune donne che, pur avendo neonati tra le braccia, non rinunciano alla partecipazione. Nel gruppo su proteção e fiscalização (protezione e controllo) due ragazze dell’Istituto Chico Mendes (IcmBio) conducono i lavori, sotto lo sguardo attento degli indigeni e di tre rappresentanti della Funai. Qui la presenza dei non indigeni è forte perché si discute di uno dei problemi più gravi: l’invasione della Terra indigena yanomami da parte dei garimpeiros, i cercatori d’oro illegali. Le proposte per affrontare il problema sono scritte con un pennarello su un cartoncino bianco posto in terra, in mezzo al gruppo. Più tardi saranno votate o respinte da ogni partecipante.
Sotto alcuni alberi, a pochi metri dalla spiaggia e dal lago, un altro gruppo sta discutendo con grande partecipazione (ma senza animosità). In quanto bianco, la mia attenzione è verso due Yanomami, provenienti dallo stato di Amazonas, che hanno viso e petto dipinti di nero. La grande maggioranza dei partecipanti al convegno indossa vestiti da «bianco» (nelle comunità, i vestiti sono invece ridotti al minimo sufficiente per coprire i genitali), ma nessuno ha rinunciato alle pitture corporali o ad alcuni oggetti simbolici (copricapi di piume, collane, pendagli per collo e orecchie, cinture di perline).
È invece sotto una tettoia con i partecipanti seduti sulle loro amache il gruppo che si occupa di salute. L’unico in piedi è un giovane relatore bianco che parla con scioltezza la lingua indigena. Le uniche parole che riesco a intendere sono i nomi di alcuni farmaci che non arrivano nelle aldeias (comunità) indigene.
Il gruppo sulle conoscenze tradizionali è sotto un albero, vicino alla cucina. È moderato da padre Corrado Dalmonego, responsabile della Missione Catrimani. Con lui un altro missionario della Consolata, padre Izaias Melo Nascimento, che sta preparandosi per aggregarsi a Catrimani.
![]()
Con Mauricio Ye’kuana
È ora del pranzo. La fila che porta davanti ai pentoloni dove alcune signore distribuiscono il cibo è lunga ma ordinata. Oggi servono carne di maiale con riso e fagioli.
È qui che conosco Mauricio del popolo Ye’kuana. Gli Ye’kuana condividono con gli Yanomami la terra indigena e rappresentano circa il 3 per cento della popolazione totale che è di circa 24.800 persone.
Mauricio ha soltanto 32 anni, ma già dal 2008 fa parte del consiglio di Hutukara. Vive in una comunità della regione di Auaris, al confine con il Venezuela e per questo parla anche un po’ di spagnolo, oltre al portoghese e alla lingua madre del suo popolo.
Il giovane Ye’kuana spiega: «In questi giorni siamo riuniti per decidere come difendere la nostra terra. Dobbiamo arrivare a un manifesto da presentare allo stato perché capisca come noi vogliamo gestire il territorio».
Poi conferma quanto è di dominio pubblico: «Il grande problema di oggi è l’attività mineraria dentro la terra indigena. I garimpeiros inquinano i boschi in cui noi viviamo con tranquillità e armonia. I nostri bambini e i vecchi hanno problemi di salute perché i minatori usano grandi quantità di mercurio che poi finisce nel pesce che noi mangiamo. Noi chiediamo allo stato di agire perché faccia ritirare questi invasori. Vogliamo evitare che accadano fatti come il massacro di Haximu del 1993 (quando un gruppo di garimpeiros uccise 16 Yanomami, comprese donne e bambini, ndr)».
Mauricio parla di 5mila invasori, ma altri, tra cui lo stesso Davi Kopenawa, sostengono che siano più di 20mila.
La lotta continua
È un peccato dover tornare a Boa Vista, mentre qui, al lago Caracaranã, si discuterà ancora per alcuni giorni. Il risultato finale sarà il «Piano di gestione territoriale e ambientale della Terra indigena Yanomani».
Un sistema decisionale che nel mondo dei Bianchi potrebbe essere chiamato di «democrazia partecipativa». Un successo importante per le comunità indigene, pur nella consapevolezza che la lotta per difendere i loro diritti e la terra faticosamente conquistati è lungi dall’essere conclusa.
Paolo Moiola
![]()
L’«Instrumentum Laboris»
Ascoltare le grida amazzoniche
 A metà giugno è stato reso pubblico lo «strumento di lavoro» su cui verterà la discussione dei partecipanti al Sinodo Panamazzonico del prossimo ottobre. Si tratta di 147 punti ricchissimi di osservazioni, critiche e proposte per il presente e il futuro dell’Amazzonia e dei suoi abitanti.
A metà giugno è stato reso pubblico lo «strumento di lavoro» su cui verterà la discussione dei partecipanti al Sinodo Panamazzonico del prossimo ottobre. Si tratta di 147 punti ricchissimi di osservazioni, critiche e proposte per il presente e il futuro dell’Amazzonia e dei suoi abitanti.
Nato da un lungo processo d’ascolto iniziato da papa Francesco a Puerto Maldonado (19 gennaio 2018), l’Instrumentum Laboris è la base teorica su cui lavorerà il Sinodo panamazzonico. Con il titolo di Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per un’ecologia integrale, esso si compone di tre parti: «La voce dell’Amazzonia», «Ecologia integrale» e «Chiesa profetica in Amazzonia: sfide e speranze». La sua divisione in parti e capitoli trova la propria unità in una numerazione progressiva che si conclude con il punto 147.
La voce dell’Amazzonia
Si parte dall’affermazione che l’Amazzonia è la seconda area più vulnerabile del pianeta, dopo l’Artico, in relazione ai cambiamenti climatici di origine antropica (punto 9). Qui la vita è minacciata dalla distruzione e dallo sfruttamento ambientale, dalla sistematica violazione dei diritti umani fondamentali dei popoli originari (diritto al proprio territorio, all’autodeterminazione, alla consultazione e al consenso previi) (14). I cambiamenti climatici e l’aumento degli interventi umani (deforestazione, incendi e cambiamenti nell’uso del suolo) stanno portando l’Amazzonia a un punto di non ritorno (16). Oggi essa è diventato luogo di una bellezza ferita e deformata, di dolore e violenza. La molteplice distruzione della vita umana e ambientale, le malattie e l’inquinamento di fiumi e terre, l’abbattimento e l’incendio di alberi, la massiccia perdita della biodiversità, la scomparsa delle specie (più di un milione degli otto milioni di animali e piante a rischio), costituiscono una cruda realtà che chiama in causa tutti. La violenza, il caos e la corruzione dilagano. Il territorio è diventato uno spazio di scontri e di sterminio di popoli, culture e generazioni (23). A dispetto di tutto questo, l’Amazzonia è il luogo della proposta del «buon vivere», della promessa e della speranza di nuovi cammini di vita. La vita in Amazzonia è integrata e unita al territorio, non c’è separazione o divisione tra le parti. Questa unità comprende tutta l’esistenza: il lavoro, il riposo, le relazioni umane, i riti e le celebrazioni. Tutto è condiviso, mentre gli spazi privati – tipici della modernità – sono minimi. La vita è un cammino comunitario dove i compiti e le responsabilità sono divisi e condivisi in funzione del bene comune. Non c’è posto per l’idea di un individuo distaccato dalla comunità o dal suo territorio (24). I popoli amazzonici originari hanno molto da insegnarci. Dobbiamo riconoscere che, per migliaia di anni, essi si sono presi cura della loro terra, dell’acqua e della foresta, e sono riusciti a preservarli fino ad oggi (29). Lo sfruttamento della natura e dei popoli amazzonici (indigeni, meticci, lavoratori della gomma, coloro che vivono sulle rive dei fiumi e persino quelli che vivono nelle città) provoca una crisi di speranza (31).
L’attuale crisi socio-ambientale può condurre all’autodistruzione. Secondo papa Francesco occorre realizzare un dialogo interculturale in cui i popoli indigeni siano i principali interlocutori (35), avendo sempre presente che l’Amazzonia è un mondo plurietnico, pluriculturale e plurireligioso (36).
Il dialogo incontra però pesanti resistenze. Gli interessi economici e un paradigma tecnocratico respingono ogni tentativo di cambiamento. I suoi sostenitori sono disposti a imporsi con la forza, trasgredendo i diritti fondamentali delle popolazioni presenti nel territorio e le norme per la sostenibilità e la conservazione dell’Amazzonia (41).
Intessuta di acqua, territorio, identità e spiritualità dei suoi popoli, la vita in Amazzonia invita al dialogo e all’apprendimento della sua diversità biologica e culturale (43).
![]()
Ecologia integrale
La seconda parte dell’Instrumentum Laboris tratta i gravi problemi causati dagli attentati alla vita nel territorio amazzonico (44). L’Amazzonia è oggetto di contesa su più fronti. Uno risponde ai grandi interessi economici, avidi di petrolio, gas, legno, oro, monocolture agro-industriali, ecc. Un altro è quello di un conservatorismo ecologico che si preoccupa del bioma ma ignora i popoli amazzonici (45).
Per prendersi cura dell’Amazzonia, le comunità aborigene sono interlocutrici indispensabili, poiché – lo abbiamo già evidenziato – sono proprio loro che normalmente si prendono meglio cura dei territori (49). L’abbattimento massivo degli alberi, la distruzione della foresta tropicale per mezzo di incendi boschivi intenzionali, l’espansione della frontiera agricola e delle monocolture sono la causa degli attuali squilibri climatici regionali e globali, con grandi siccità e inondazioni sempre più frequenti (54).
La cultura amazzonica, che integra gli esseri umani alla natura, diventa un punto di riferimento per la costruzione di un nuovo paradigma di ecologia integrale. La Chiesa dovrebbe assumere nella sua missione la cura della Casa comune con azioni per il rispetto dell’ambiente, programmi di formazione, denunce dei casi di violazione dei diritti umani e di distruzione estrattivista (56).
La popolazione originaria dell’Amazzonia è stata vittima del colonialismo nel passato e di un neocolonialismo nel presente. L’imposizione di un modello culturale occidentale ha inculcato un certo disprezzo per il popolo e i costumi del territorio amazzonico, definendoli addirittura «selvaggi» o «primitivi». Oggi, l’imposizione di un modello economico estrattivista occidentale colpisce ancora una volta le comunità amazzoniche invadendo e distruggendo le loro terre, le loro culture, le loro vite (76).
L’educazione implica un incontro e uno scambio (93). In Amazzonia, essa non deve significare imporre ai popoli amazzonici le proprie cosmovisioni: parametri culturali, filosofie, teologie, liturgie e costumi estranei (94). La cosmovisione dei popoli indigeni amazzonici è diversa perché comprende la chiamata a liberarsi da una visione frammentata della realtà, incapace di percepire le molteplici connessioni, interrelazioni e interdipendenze.
Da qui deve nascere l’educazione per un’ecologia integrale. Per comprendere questa visione, vale la pena di applicare lo stesso principio della salute: l’obiettivo è quello di osservare tutto il corpo e le cause della malattia e non solo i sintomi (95). Tale educazione «deve tradursi in nuove abitudini» tenendo conto dei valori culturali. L’educazione, in una prospettiva ecologica e in chiave amazzonica, promuove il «buon vivere», il «buon convivere» e il «fare bene», che deve essere persistente e percepibile per avere un impatto significativo sulla Casa comune (97).
Passare dall’educazione ecologica alla conversione ecologica implica riconoscere la complicità personale e sociale nelle strutture di peccato, smascherando le ideologie che giustificano uno stile di vita che aggredisce la creazione (101).
![]()
Chiesa profetica in Amazzonia: sfide e speranze
La terza e ultima parte dell’Instrumentum parla del volto amazzonico della Chiesa, che deve trovare la sua espressione nella pluralità dei suoi popoli, culture ed ecosistemi (107). È una Chiesa che si lascia alle spalle una tradizione coloniale monoculturale, clericale e impositiva e sa discernere e assumere senza timori le diverse espressioni culturali dei popoli (110). Costruire una Chiesa dal volto amazzonico significa abbandonare la tendenza a imporre una cultura estranea all’Amazzonia che impedisce di comprendere i suoi popoli e di apprezzare le loro cosmovisioni (111).
Essere Chiesa in Amazzonia in modo realistico significa porre profeticamente il problema del potere, perché in questa regione le persone non hanno la possibilità di far valere i loro diritti contro le grandi imprese economiche e le istituzioni politiche. Oggi, mettere in discussione il potere nella difesa del territorio e dei diritti umani significa mettere a rischio la propria vita. La Chiesa non può rimanere indifferente a tutto questo (145).
Nel lungo percorso per la stesura dell’Instrumentum Laboris, sono state ascoltate le voci dell’Amazzonia. Voci che chiedono di dare una nuova risposta alle diverse situazioni e di cercare nuovi cammini che rendano possibile un kairós per la Chiesa e per il mondo (147).
a cura di Paolo Moiola
![]()