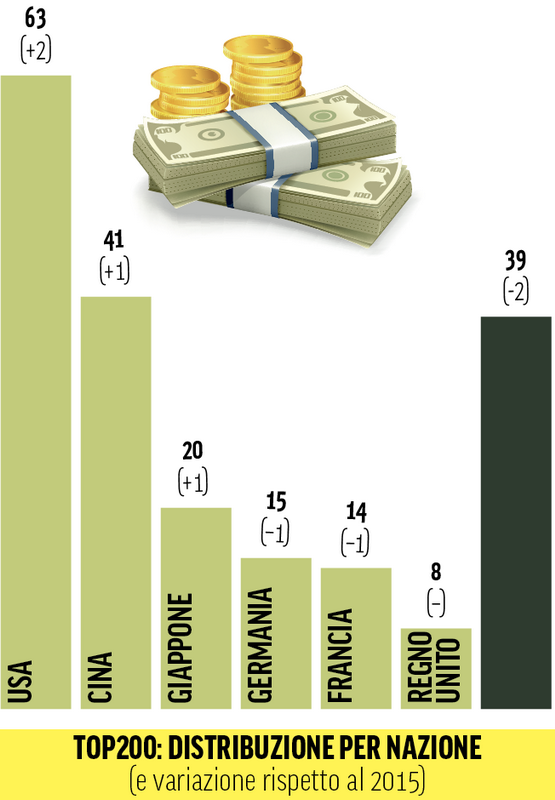È l’Amazzonia
Testi e foto di Paolo Moiola |
Unica, ricca, fragile: l’Amazzonia sotto assedio
AMAZZONIA
I numeri, le ricchezze, le minacce
Da conquistatori a protettori
A colloquio con padre Angelo Casadei
«Essere custodi è la nostra responsabilità»
Mons. Joaquín?Humberto PInzón Güiza
Vicariato di Puerto Leguízamo-Solano
![]()
Unica, ricca, fragile: l’Amazzonia sotto assedio
La «minga»?del?vicariato?di Puerto?Leguízamo-Solano
L’Amazzonia è una regione unica. Per millenni abitata solamente da popoli indigeni, oggi ospita anche altre popolazioni. Gli uni e gli altri debbono affrontare molti problemi, perché la foresta si è trasformata in un luogo ambito a causa delle sue ricchezze. Il giovane Vicariato di Puerto Leguízamo-Solano ha invitato decine di persone dei tre paesi confinanti – Perù, Ecuador, Colombia – sui quali si estende il suo territorio, per discutere su come difendere l’Amazzonia dall’assalto degli sfruttatori. Ha chiamato quest’evento «Minga amazónica fronteriza».
Verso Puerto Leguízamo, Colombia. Nel piccolissimo aeroporto di Puerto Asís non è facile avere informazioni. Non ci sono né monitor né annunci. L’aereo della Satena, la compagnia colombiana gestita dai militari, che ci ha portato qui da Bogotà, è ora fermo sulla pista. Finalmente un addetto ci spiega che a Puerto Leguízamo, meta del viaggio, sta piovendo a dirotto e pertanto la partenza è rimandata finché le condizioni meternorologiche non miglioreranno. Di norma nelle zone equatoriali le piogge sono molto intense ma si esauriscono in poco tempo. In ogni caso non c’è alcuna protesta dei viaggiatori visto che nessuno desidera imbarcarsi su un volo rischioso. All’improvviso viene aperta la porta che conduce sulla pista dove è posteggiato l’aereo (l’unico aereo). Saliamo la scaletta fiduciosi di riprendere il viaggio. Mi sistemo accanto al finestrino con la macchina fotografica nella speranza di poter immortalare qualche immagine dall’alto. Il volo si svolge tranquillo, a parte qualche prevedibile scossone. Nuvole nere impediscono di vedere bene la terra sottostante. Tuttavia, non mancano squarci nel cielo che consentono di ammirare i luoghi sorvolati. È una visione che affascina ma che al tempo stesso fa riflettere e intristire. Sotto è Amazzonia e il verde domina ancora incontrastato, ma gli spazi disboscati o ridotti a pascolo sono ampi. L’elemento più appariscente sono i fiumi, tanti, lunghi e sinuosi. Le loro acque non appaiono blu o verdi, ma marroni come la terra che trasportano.
![]()
Il volo dura circa un’ora. Nonostante la pioggia, l’atterraggio è relativamente facile. L’aeroporto di Puerto Leguízamo è costituito da una pista malconcia in mezzo alla campagna e una casetta bassa e anonima verso la quale s’incamminano i passeggeri di Satena. La pista è delimitata da una rete metallica oltre la quale s’intravvedono alcuni mototaxi, veicoli a tre ruote che costituiscono il mezzo di trasporto di gran lunga più diffuso. E, subito dietro, un grande cartellone sbiadito da sole e acqua che dà il benvenuto a Puerto Leguízamo, cittadina allungata lungo le rive del Putumayo, con il Perù di fronte e l’Ecuador poco sopra.
Sul volo ho incontrato padre Francisco Pinilla, colombiano e missionario della Consolata che lavora da queste parti da sei anni e che sta andando proprio dove vado io. Ne approfitto subito per chiedere una descrizione del luogo.
«Siamo – spiega – più o meno al centro del 6% dell’Amazzonia che la Colombia possiede. Contando tutto il municipio, qui vivono all’incirca 40mila abitanti». Di cosa vivono? «Un tempo si producevano riso, frutta, platano, yuca, però ultimamente la gente preferisce produrre altre cose (il padre si riferisce alla coca, ndr) che danno più reddito. Quindi, i prodotti locali sono andati sparendo». Per arrivare fino a qui ci sono due modalità. «Sì – conferma il missionario -, come siamo venuti, in aereo, con la compagnia della Forza aerea colombiana, e attraverso il fiume da Florencia o da Puerto Asís in 8-10 ore di viaggio».
Il viaggio per fiume, molto più lungo ma molto meno costoso di quello aereo, fino a qualche mese fa non era accessibile a tutti per la presenza delle Farc, che potevano fermare o sequestrare le persone giudicate non gradite. Dopo la firma degli accordi di pace (novembre 2016), la situazione è divenuta assai più tranquilla.
Sotto una leggera pioggia saliamo su un mototaxi. Per conversare occorre parlare a voce alta perché il rumore del veicolo è assordante ed anche la strada – stretta e dissestata – non agevola il dialogo tra i due passeggeri. Il paese è cresciuto lungo quest’unica arteria. Nostro destino è la sede del giovane Vicariato apostolico di Puerto Leguízamo-Solano che ha organizzato un incontro internazionale sull’Amazzonia: la «Minga amazónica fronteriza». Minga è un termine kichwa che indica un lavoro collettivo e gratuito di carattere temporaneo.

L’Amazzonia, da cortile a piazza centrale

All’incontro sono iscritte 147 persone: 32 provenienti dal Perù, 11 dall’Ecuador e 103 dalla Colombia (più una dall’Italia: chi scrive), tutte ospitate nelle strutture del Vicariato. In ognuno dei tre giorni (6-8 novembre 2017) è prevista l’esposizione di un esperto che parlerà di Amazzonia alla luce del motto della minga: Somos territorio, somos pobladores, somos cuidadores. La minga prevede però la partecipazione attiva di tutti. Per questo gli iscritti sono stati divisi in 11 gruppi o tavoli di lavoro: dai contadini ai cacique e governatori, dai laici missionari ai vescovi. Ogni gruppo dibatterà sugli interventi ascoltati in sala partendo dalle risposte ad alcune domande. Le considerazioni verranno quindi esposte da un portavoce di ciascun gruppo davanti all’assemblea riunita in seduta comune.
Nell’aula magna del Centro pastorale del Vicariato, sullo sfondo di un suggestivo albero di cartapesta (opera del padre Carlos Alberto Zuluaga), vengono cantati gli inni nazionali di Ecuador, Perù e Colombia. È mons. Joaquin Pinzón, il padrone di casa, a dare il benvenuto agli ospiti e aprire il convegno. Ma sono due indigeni shuar ecuadoriani, Bosco Guarusha e il figlio Daniel Guarusha, a offrire un senso mistico all’inaugurazione della minga con una cerimonia di purificazione (la cosiddetta «limpia») molto coinvolgente e partecipata.
Il primo intervento è di Maurizio López, segretario esecutivo della Rete ecclesiale panamazzonica (Repam). «Per molti anni – spiega il relatore – l’Amazzonia è stata considerata come il “cortile sul retro”. Si parlava di “terra senza uomini per uomini senza terra”, di “territorio di indios da addomesticare”, di “inferno verde”. Oggi l’Amazzonia si è trasformata nella “piazza centrale”. E non si capisce cosa sia meglio visto che oggi ci sono tanti occhi e tanti pareri su questa realtà. Se prima era un luogo da addomesticare e civilizzare, adesso la si vede come dispensa per lo sviluppo del mondo. Il che conduce a un “estrattivismo” che si comporta come se qui non ci fosse nessuno. Come se questi territori non avessero una loro popolazione, identità, cultura ed anche una loro sacralità».
Per di più – spiega ancora – oggi l’Amazzonia viene distrutta non per ripartire in maniera equa le sue ricchezze, ma perché esiste una corsa all’accumulazione senza fine. «Come dice papa Francesco – conclude Maurizio López -, siamo davanti a una crisi che è ad un tempo sociale e ambientale».

Dal «grande vuoto» ai selvaggi da umanizzare
L’antropologo peruviano Javier Gutiérrez Neira inizia il suo intervento citando dati archeologici che certificano la presenza umana in Amazzonia almeno da 12mila anni avanti Cristo. Smentita scientifica al mito del «gran vuoto amazzonico», successivamente sostituito da quello delle popolazioni selvagge da umanizzare. Azione che ebbe il suo apice con il genocidio avvenuto durante l’epoca del caucho (1840-1915), quando più di 30mila indigeni – principalmente Huitoto, Ocaina e Resigaro – vennero ridotti in schiavitù o sterminati. Rispetto al passato, oggi sono cambiate le condizioni generali (alle popolazioni autoctone si sono aggiunti gli abitanti meticci), ma non lo stato di conflitto.
I governi – spiega l’antropologo – hanno lottizzato l’Amazzonia dandola in concessione per molti anni a società minerarie e petrolifere, «senza considerare gli impatti sui territori indigeni e sulla stessa Amazzonia, la quale durante oltre 50 anni d’estrazione petrolifera ha conosciuto soltanto inquinamento e conflitti sociali». Nulla di più vero: in Perù, Colombia ed Ecuador, ad esempio, i conflitti ambientali in atto sono centinaia (Observatorio latinoamericano de conflictos ambientales, Olca).
Secondo l’antropologo peruviano, l’Amazzonia va pensata «da dentro» e non «da fuori». Dovrebbero cioè essere i popoli amazzonici ad avere la responsabilità di formulare una politica per l’Amazzonia e portarla all’attenzione degli stati nazionali.

La cancellazione del limite e la creazione delle necessità
Mons. Héctor Fabio Henao, direttore nazionale della Pastorale sociale della Caritas colombiana (e dal 17 dicembre anche presidente del Comitato del Consiglio nazionale per la pace, la riconciliazione e la convivenza) inizia il suo discorso dal concetto di limite. «La teoria è che la gente abbia necessità che non si saziano mai e per questo occorra produrre al massimo. È il produttivismo, cioè produrre illimitatamente per creare consumismo. Un consumismo che, a sua volta, ci porta verso uno sviluppo patologico, che chiameremo sviluppismo».
«Veramente abbiamo necessità illimitate? È sicuro che le necessità dell’essere umano non abbiano limiti? In verità, sono i sogni, i desideri a essere illimitati, mentre le necessità sono limitate». Ma come si inserisce in tutto questo l’Amazzonia? Il capitalismo, che mons. Henao definisce «uno stato dell’anima», vuole controllare completamente l’essere umano e la natura. Per questo ha messo gli occhi sull’Amazzonia. Concretamente: il capitalismo selvaggio spinge per l’estrazione delle materie prime (estrattivismo) del bioma amazzonico per alimentare una produzione senza limiti.
Mons. Henao vede il cambio corretto nelle proposte fatte da papa Francesco nella sua Laudato si’. Qui si parla di ecologia integrale e di rivoluzione della tenerezza. «Dobbiamo – conclude Henao – bandire la frase “Tutto è lecito”, visto che essa non include il futuro, non pensa cioè ad assicurare una vita dignitosa a chi verrà dopo di noi».

«Cosa abbiamo capito, cosa vogliamo fare»
Dopo tre giorni di relazioni, dibattiti e incontri conviviali, l’8 novembre giunge il momento di tirare le somme. Tutti i gruppi partecipano alla stesura di un Manifesto rivolto agli abitanti dell’Amazzonia e a tutti coloro che hanno a cuore la sua causa. La dichiarazione prende atto dei grandi problemi che coinvolgono il bioma amazzonico: dallo sfruttamento petrolifero a quello minerario e boschivo, dalle monocolture all’allevamento, dal narcotraffico all’insufficiente presenza dello stato.
Quindi, richiama le autorità nazionali, internazionali e locali a comportamenti adeguati alle particolari necessità dell’Amazzonia: adottare piani di sviluppo che siano realmente amazzonici; garantire la consultazione preventiva dei popoli indigeni per qualsiasi progetto; educare le comunità locali a un trattamento adeguato dei rifiuti; incentivare le autorità accademiche allo studio scientifico della realtà amazzonica, nonché alla formazione e divulgazione delle conoscenze maturate; spingere gli agenti pastorali ad avere una parola più profetica e decisa in difesa dell’Amazzonia.
Infine, il Manifesto afferma la volontà degli estensori di partecipare attivamente alla realizzazione del Sinodo amazzonico del 2019*, accompagnare le comunità amazzoniche nella ideazione ed esecuzione di progetti sostenibili e di contrastare con determinazione tutto ciò che attenta alla vita in Amazzonia.
Un Manifesto – per propria intrinseca natura – contiene indicazioni generali e a volte generiche, soprattutto su una materia complessa com’è la realtà dell’Amazzonia. Tuttavia, esso è importante come base di partenza concettuale, per produrre una fotografia del problema e ipotizzare soluzioni, modalità d’azione, comportamenti.
![]()
Vista sul Rio Putumayo
![]()
La minga è terminata. Il giorno seguente seguo padre Fernando Florez, uno degli organizzatori più impegnati, mentre accompagna al porto di Puerto Leguízamo il gruppo di partecipanti – paiono tutti allegri – che torneranno in Ecuador e in Perù. I primi salgono su una lancia a motore per passeggeri che lascia subito la banchina e inizia a solcare le acque calme del Rio Putumayo in direzione Nord. I secondi si accontenteranno di un vecchio barcone di legno senza finestrini e con tavolacci al posto delle sedute. Il motore tuttavia pare a posto. Dato che il viaggio verso San Antonio del Estrecho durerà due giorni e non ci sono posti di rifornimento lungo il tragitto verso Sud, occorre fare il pieno di carburante. Il distributore sta sulla strada, qualche metro più in alto rispetto alla riva. Il comandante collega allora il suo barcone con la pompa di benzina attraverso un lungo tubo di gomma. Ci vuole oltre un’ora per completare il rifornimento. Alla fine il barcone prende il largo docilmente con la logora bandiera peruviana che sventola nell’aria, tra i cenni di saluto di chi è rimasto a prua e il rumore ripetitivo dei peke peke – le piccole barche a motore – che gli passano a fianco. L’Amazzonia è (anche) questo.
Paolo Moiola
AMAZZONIA
I numeri, le ricchezze, le minacce
DEFINIZIONE
Si chiama Amazzonia la regione sudamericana che ospita la maggiore foresta tropicale umida del pianeta e la più grande riserva di acqua dolce del mondo.
DATI?GEOGRAFICI
- SUPERFICIE: 7.989.004 km2 divisi su 9 paesi;
- PAESI: Brasile (64%), Perù (9,7%), Bolivia (7%), Colombia (6,6%), Venezuela (5,9%), Guyana (2,1%)*, Suriname (1,9%)*, Ecuador (1,6%), Guyana francese (0,8%)*; (*): paesi con territorio amazzonico posto fuori del bacino idrografico del Rio delle Amazzoni.
- FIUMI: Río delle Amazzoni (6.992 Km, il più lungo del mondo), con migliaia di affluenti tra cui il Río Negro (2.000 km), il Río Madeira (3.240 km), il Río Putumayo (1.813 km), il Río Napo (1.130 km), il Río Marañón (1.600 km). (Fonte: Gutierrez-Acosta-Salazar, Instituto Sinchi, Colombia 2004)
DATI?DEMOGRAFICI
- POPOLAZIONE: 38 milioni di cui 25 in Brasile e 3,7 in Perú;
- CITTÀ PRINCIPALI: Manaus (Brasile), Belém (Brasile), Iquitos (Perú), Santarém (Brasile);
- POPOLI?INDIGENI: circa 420 popoli indigeni (60 in isolamento) per un totale approssimativo di 1,5 milioni di persone; sono 433mila (per 240 popoli) nell’Amazzonia brasiliana e 333mila (per 52 popoli) nell’Amazzonia peruviana.
RICCHEZZE
Foreste, acqua, fauna, flora, biodiversità, risorse del sottosuolo, popoli indigeni.
MINACCE?ANTROPICHE
Attività petrolifere, attività minerarie (oro, in primis), allevamento bovino estensivo, monocolture (soia, in primis), industria del legname, coltivazioni di coca, sfruttamento delle acque dei fiumi (centrali idroelettriche), biopirateria.
(Paolo Moiola, 2018)
Da conquistatori a protettori
A colloquio con padre Angelo Casadei
Per l’Amazzonia colombiana sono mutate molte cose. I missionari, presenti dalla metà del XVI secolo, già da tempo avevano cambiato le proprie modalità di lavoro. Scegliendo di schierarsi (con convinzione) a fianco dei popoli indigeni e in difesa di un ambiente unico.
Puerto Leguízamo. «Forse anche noi missionari arrivammo con uno spirito di conquista e per accompagnare la colonizzazione di questo territorio. Oggi c’è quasi una visione opposta. Prima si parlava di conquista dell’Amazzonia, oggi si parla di protezione e conservazione. Oggi l’Amazzonia non è più soltanto la sua ricchezza ecologica, ma anche quella dei popoli che in essa vivono. C’è stato – conclude padre Angelo – un cambio di visione rispetto a quando arrivammo».
I primi missionari arrivarono da queste parti a metà del XVI?secolo, i missionari della Consolata nel 1952, padre Angelo Casadei da Gambettola nel 2005. «Però in Colombia ero già stato durante gli studi, dal 1989 al 1990», precisa.

Dalla guerra agli accordi di pace
Padre Angelo non si separa mai dalla sua Canon. Fotografa e filma tutto. E quando lo fa non passa inosservato dall’alto dei suoi 186 centimetri d’altezza. Avendo operato in Caquetà (a Remolino e San Vicente del Caguán) e in Putumayo (prima a La Tagua, oggi a Solano), il missionario è un testimone privilegiato di questa parte dell’Amazzonia che per anni è stata un feudo quasi inaccessibile delle «Forze armate rivoluzionarie di Colombia», le Farc.
«Era una guerra civile. All’interno di uno stesso paesino potevi trovare persone che appartenevano all’esercito e altre alla guerriglia.
Per questo dico che l’accordo di pace è stato un bene per i colombiani. Anche se permangono gruppi dissidenti, per esempio a Solano. Oggi il vero problema nasce dall’assenza dello stato. L’unica presenza sono queste grandi basi militari (il riferimento è alla base che sta accanto alla sede del Vicariato, ndr). Prima dell’accordo tra il governo e le Farc, i soldati uscivano in gruppo e rientravano in gruppo per ridurre i rischi. C’erano però vasti territori dove i militari non entravano mai e dove l’ordine pubblico era gestito dalla stessa guerriglia. Oggi, con la consegna alle autorità della gran parte dei guerriglieri, molti di questi territori sono rimasti scoperti. Se lo stato non darà segnali di presenza, il rischio è che gli spazi vuoti possano essere occupati da bande criminali o dalla delinquenza comune e le persone inizino a farsi giustizia da sé. Com’è già accaduto».
![]()
La coca e le (difficili) alternative
Il problema è reale. Le bande criminali – una delle più conosciute è La Constru – si dedicano all’attività mineraria illegale e soprattutto al narcotraffico, che è in costante aumento. Il Putumayo è il secondo dipartimento colombiano per coltivazione di coca: si stimano 25.162 ettari coltivati, il 17% del totale (146.000 ettari nel 2016, stando ai dati Simci-Unodc). Più coca significa più danni ambientali (disboscamento e sversamento di sostanze chimiche nell’ambiente) e più danni sociali.
Un chilo di coca – quella più grezza prodotta sul posto di raccolta delle foglie (pasta básica de cocaína) – vale oggi quasi 3 milioni di pesos (circa 870 euro).
La media di produzione per ogni ettaro coltivato è di chilogrammi 1,45 di pasta base (dati Simci-Unodc). I raccolti sono tre all’anno. I piccoli contadini che la coltivano non diventano ricchi, vivono o semplicemente sopravvivono (cosa ancora più vera per i raspachines, i braccianti giornalieri che raccolgono le foglie).
«È difficile trovare un’alternativa alla coca, soprattutto in territori isolati come questi. Un chilo di coca, che sono milioni di pesos, lo metti in uno zainetto e lo trasporti facilmente dove vuoi. Se coltivi mais o yuca o altri prodotti, la commercializzazione risulta molto più difficile. I missionari hanno proposto vari prodotti in alternativa alla coca – soprattutto cacao e caucciù -, anche se non esiste un prodotto sostitutivo perfetto. Il nostro è però anche un lavoro di coscientizzazione, per far capire alla gente cosa comporta produrre cocaina».
Se si esclude la coca, le alternative economiche praticabili ed ecosostenibili non sono molte. L’allevamento – che qui è sempre di tipo estensivo – ha effetti devastanti perché implica disboscamento. Tanto disboscamento: la media attuale è di una vacca per ogni ettaro. Quanto alle altre colture sono, almeno per il momento, troppo poco redditizie. «La foresta offre però varie ricchezze – precisa padre Angelo -. Penso alle piante medicinali. Penso alla noce amazzonica, che ha mercato e che viene coltivata da alcune comunità indigene. Penso al caucciù (caucho natural), che un tempo era una ricchezza. Penso al cacao. Penso al turismo, che qui non esiste anche se abbiamo due grandi parchi naturali, La Paya e Chiribiquete. Ovviamente dovrebbe essere un turismo con limiti ben precisi».

Oro e petrolio, una maledizione
Altro fattore di distruzione è stato l’espansione dell’attività mineraria illegale, in particolare quella legata alla ricerca dell’oro alluvionale. I danni prodotti dalla ricerca del prezioso metallo riguardano soprattutto la contaminazione delle acque con il mercurio. «Anche le Farc – spiega padre Angelo – usavano l’attività mineraria illegale per avere delle entrate. In particolare, chiedevano una percentuale sull’oro estratto. Oggi però la situazione pare fuori controllo».
La fine della guerra civile ha dato nuovo impulso anche all’esplorazione petrolifera nell’Amazzonia colombiana. Ecopetrol (Colombia), GranTierra (Canada), Monterrico (Perù), Amerisur (Gran Bretagna) sono alcune delle compagnie che hanno aperto campi petroliferi in Caquetà e Putumayo.
«Per le compagnie petrolifere la scomparsa delle Farc è un vantaggio perché entrano nelle zone di ricerca con più facilità. La guerriglia era contraria alla loro attività perché essa porta strade e comunicazione, rompendo l’isolamento». Contrarie sono anche la maggior parte delle comunità indigene che si trovano direttamente coinvolte nei progetti petroliferi.
«Lungo il fiume Putumayo e lungo il Caquetà ci sono molte comunità indigene di vari gruppi etnici, che da sempre vivono in questi territori. Mantengono la loro lingua e tradizioni, anche se sono comunità che sono venute a contatto con l’uomo e la cultura occidentali. E spesso sono state violentate, come all’epoca del caucciù quando moltissimi indigeni furono schiavizzati».
«Noi ci siamo assunti il compito di accompagnarli in una riflessione sul trauma subito. Per molto tempo siamo stati gli unici ad avvicinarli e aiutarli nelle loro lotte. Per questo i popoli indigeni ci guardano con rispetto».
Paolo Moiola

«Essere custodi è la nostra responsabilità»
Mons. Joaquín?Humberto PInzón Güiza
Al centro dell’Amazzonia colombiana si trova il Vicariato di Puerto Leguízamo-Solano, cinque anni a febbraio. Il vescovo Joaquín Pinzón e i suoi collaboratori hanno scelto di percorrere la strada della sostenibilità ambientale per difendere un territorio unico ma ambito e molto fragile. Un impegno complicato: gli sfruttatori dell’Amazzonia sono tanti (minatori illegali, compagnie petrolifere, coltivatori di coca, commercianti di legname, ecc.) e non paiono intenzionati ad arretrare. Approfittando anche dell’assenza dello stato.
Puerto Leguízamo. Le sei e trenta del mattino sono un buon orario per un’intervista all’aperto. Non ci sono ancora i chiassosi alunni della scuola attigua e la temperatura è ideale.
Mons. Joaquín Humberto Pinzón Güiza è giovane all’anagrafe e giovanile nell’aspetto. Colombiano del dipartimento di Santander, missionario della Consolata, egli ha visto nascere, crescere e cambiare il Vicariato apostolico di Puerto Leguízamo-Solano che regge fin dalla sua fondazione, avvenuta nel febbraio del 2013. Da allora sono trascorsi 5 anni e tutt’attorno le cose sono cambiate: in primis, ci sono stati gli accordi di pace con le Farc e qui, a Puerto Leguízamo, molto più che nelle città (che infatti raccolgono la maggioranza dei contrari), i cambiamenti sono fatti quotidiani, concreti e visibili.
Monsignor Pinzón, il suo vicariato comprende municipi di tre diversi dipartimenti: Putumayo, Caquetá e Amazonas. Come descriverebbe questo territorio?
«Siamo ubicati nel cuore dell’Amazzonia colombiana. Ma allo stesso tempo siamo ai confini dell’Amazzonia peruviana e di quella ecuadoriana. In altre parole, noi non solo ci troviamo in un contesto amazzonico ma anche di frontiera. Per molti il Rio Putumayo ci divide, ma per noi non è così. Come dice padre Gaetano Mazzoleni, missionario della Consolata che ha lungamente vissuto qui, il fiume ci unisce. Il fiume ci dà la possibilità di muoverci, di trovare i prodotti per alimentarci. È la nostra “autopista fluvial”…».
Interessante la terminologia che lei usa: autostrada fluviale, autostrada d’acqua…
«In questo contesto amazzonico dove non esistono strade, il rio è la nostra autostrada. Il fiume è la possibilità per spostarci e metterci in comunicazione con altre popolazioni e altri contesti. È il nostro spazio di vita che ci mette in comunione con gli abitanti di questa Amazzonia sudcolombiana, nordperuviana e nordecuadoriana».
![]()
Popoli indigeni e non solo
Per molto tempo – per motivi politici, economici e culturali – si è sostenuto che l’Amazzonia fosse spopolata anche se era abitata dai popoli indigeni. Ancora oggi, nell’immaginario collettivo, l’Amazzonia è soltanto foresta e fiumi. Invece ci sono anche i suoi abitanti.
«Quando parliamo di pobladores (abitanti) dell’Amazzonia dobbiamo parlare di popoli, culture e famiglie da integrare. Siamo tutti pobladores di questo territorio, ma con caratteristiche molto particolari e precise. In questo Vicariato, ad esempio, ci sono molti popoli ancestrali, come i Murui (della famiglia Huitoto), gli Inga, i Koreguaje, i Siona, i Kichwa».
I popoli indigeni sono gli abitanti originari, oggi però non ci sono più soltanto loro.
«Sì, nel corso della storia, per diversi motivi e circostanze, qui sono arrivate altre persone: per cercare migliori condizioni di vita o per sfuggire alla violenza presente in altri territori. Oggi li chiamiamo campesinos, un tempo erano detti colonos. Definizione questa rifiutata dagli interessati: “Non siamo coloni. Non siamo venuti a colonizzare. Siamo abitanti di questo territorio”. Nello stesso tempo, sono cresciute le dimensioni delle città e le loro popolazioni. Insomma, l’Amazzonia odierna ospita differenti esperienze umane».
Gli accordi di pace e il vuoto di potere
Fino a pochi mesi fa Puerto Leguízamo e tutta questa regione erano sotto il controllo delle Farc. Gli accordi di pace hanno cambiato la situazione?
«Sì, l’hanno cambiata. La maggioranza degli appartenenti al movimento se ne sono andati nei luoghi di concentrazione fissati dal governo. In due territori del Vicariato rimangono piccoli gruppi dissidenti. In particolare, un gruppo venuto dall’Oriente – conosciuto come la dissidenza del Frente Primero – e altri gruppetti locali fuoriusciti dal Frente 48. Però, possiamo affermare che la situazione è cambiata perché i guerriglieri non esercitano più quel controllo sociale che avevano in gran parte di questo territorio. Quello che manca ora è una risposta del governo centrale. Le persone si domandano: oggi chi esercita l’autorità in questi luoghi? Chi comanderà d’ora in avanti? C’è incertezza. C’è paura che possano arrivare altri gruppi fuorilegge e che essi possano assumere il controllo che prima esercitavano le Farc.
Insomma, nella gente da una parte c’è contentezza per il cambiamento, dall’altra c’è sconcerto per la mancanza di risposte da parte del governo rispetto al vuoto di potere che si è creato».
![]()
Sempre più coca
Gli accordi di pace non pare abbiano cambiato l’economia della coca, che continua a essere prodotta in quantità.
«È vero: la produzione di coca prosegue. In ciò è cambiato poco. Anzi, secondo alcuni, la produzione è aumentata. Occorre riflettere sul fatto che le persone continuino a coltivare e la produzione a crescere. Il problema oggi è la commercializzazione. Anteriormente le Farc facevano da intermediarie, oggi manca questo passaggio. Pertanto, è aumentata la produzione ma è diminuita la commercializzazione. Le persone continuano a considerare la produzione di coca un’attività vitale, ma sono preoccupate per l’aspetto commerciale. Per tutto questo sulla questione della coca occorrerebbe fare una riflessione ad hoc».
È molto difficile vivere facendo i contadini. Al contrario, con pochi ettari di terra – si parla di tre – coltivati a coca si può vivere. A volte anche bene.
«Con tre ettari di coca si può vivere se le famiglie hanno esigenze limitate. È anche vero che il movimento di denaro generato dal narcotraffico ha incrementato le esigenze. Il problema vero è che non esiste una politica di sostituzione, un’alternativa che consenta alle famiglie di lasciare la coltivazione della coca per dedicarsi ad altre attività che consentano non soltanto di vivere ma di vivere degnamente».

Oro e petrolio sono incompatibili con l’ambiente
Altro problema che pare allargarsi è legato all’attività mineraria, in particolare quella illegale connessa alla ricerca dell’oro.
«L’attività mineraria illegale è un problema piuttosto serio, perché essendo illegale non esiste alcun controllo. Costoro arrivano e si stabiliscono in luoghi dove si possano nascondere da sguardi indiscreti. Questo genera una situazione molto difficile perché essi praticano l’attività senza preoccuparsi di usare metodi che riducano gli effetti sull’ambiente. A queste persone interessa soltanto estrarre il minerale, in questo caso l’oro, senza alcuna precauzione che consenta di mitigare l’impatto ambientale».
Già da alcuni anni si parla di tonnellate di mercurio riversate nei fiumi colombiani (Estudio Nacional del Agua 2014). Il problema riguarda anche il río Putumayo?
«Sì, nel río Putumayo si utilizza il mercurio. Questo ha generato e continua a generare problematiche. Contaminando il fiume, contaminano il pesce e quindi coloro che lo consumano. A poco a poco, le persone si caricano di questo metallo che l’organismo non è in grado di trattare».
Nel vicino Ecuador e nel Nord del Perù le imprese petrolifere stanno distruggendo l’Amazzonia e inquinando i fiumi. Com’è la situazione qui in Colombia?
«Rispetto alle compagnie petrolifere, al Nord del Putumayo – nella zona di Puerto Asís, in particolare – stanno avvenendo delle esplorazioni per capire se c’è la possibilità di estrarre petrolio. In questo momento sono in corso dialoghi con le comunità interessate, anche se alcuni di questi sono viziati da interessi economici. Le persone non sono state sufficientemente preparate e così accade che, con un po’ di denaro, a volte vengono comprate. Le persone non hanno la possibilità di raggiungere la consapevolezza dell’impatto che le attività petrolifere possono produrre».
![]()
I perché di una minga amazzonica
Il suo Vicariato ha organizzato – novembre 2017 – una «minga amazónica fronteriza». Perché avete usato il termine «minga»?
«Minga è parola kichwa che significa offrire qualcosa in cambio di qualcos’altro. Nella pratica, si traduce in un’esperienza di lavoro comunitario che porta beneficio a tutti e nel quale tutti apportano ciò che hanno. In altre parole, tutti mettiamo i nostri sforzi in una causa comune per ottenere un beneficio comune. Per questo noi abbiamo voluto dare al nostro incontro di riflessione la categoria della minga. Creare uno spazio di riflessione comune».
Lo slogan continuamente richiamato durante la minga è stato «Amazonia, contexto de vida que une orillas», un contesto di vita che unisce le sponde. Ci spieghi meglio in cosa consiste questa unione.
«Qui a Puerto Leguízamo si è unito un buon gruppo di persone della Colombia, del Perù e dell’Ecuador. Abbiamo avuto come ospiti i vescovi di San Miguel del Amazonas (Perù), di San Vicente e di Florencia. Abbiamo avute persone che si muovono da diverse prospettive rispetto a quella ecclesiale: persone delle amministrazioni (come il sindaco di Puerto Leguízamo), di organismi ecuadoriani, di organizzazioni ambientaliste.
Tutte istituzioni e persone a cui interessa la cura di questo contesto di vita. Tutti riuniti per una causa comune: come essere abitanti responsabili che cercano uno sviluppo sostenibile, cioè che non danneggi ma al contrario protegga il contesto amazzonico in cui ci ritroviamo a vivere.
Dalla minga siamo usciti tutti contenti e desiderosi di trasformarci in difensori di questo territorio e di questo spazio di vita. Le istituzioni pubbliche, quelle ambientali e quelle ecclesiali. Tutti desiderosi di trasformarci in piccoli cuidanderos».
Quindi, in epoca di sfruttamento dell’Amazzonia, voi volete esserne curatori, difensori, protettori: una bella responsabilità.
«Il motto completo della minga era: “Somos territorio, somos pobladores, somos cuidanderos”. L’ultima parola non è in un castigliano perfetto: in realtà, dovrebbe essere cuidadores. Ma abbiamo usato questa perché è un termine che usano le persone di qui quando affidano il loro campo a qualcuno perché lo curi bene. Dunque, non explotadores, ma al contrario cuidanderos».

Dalla «Laudato si’» al Sinodo amazzonico
Per il novembre del 2019 è stato convocato un sinodo per l’Amazzonia. Si può dire che la vostra minga lo abbia anticipato?
«Potremmo dirlo ma sarebbe una risposta un po’ superba. Abbiamo sognato e progettato quest’esperienza di minga nel febbraio 2017. Potremmo dire che abbiamo anticipato il sinodo. Ma la vera risposta è che papa Francesco ci ha sfidati con il contributo della Laudato si’.
L’enciclica è stato un regalo per l’umanità. Sappiamo che essa è una proposta del papa non soltanto per la chiesa ma per l’umanità tutta.
Vivendo in questo territorio noi ci siamo sentiti molto in sintonia. Non soltanto con la Laudato si’, ma con la sensibilità ecologica di questo papa».
Monsignor Pinzón, la porta qui accanto è quella di una scuola elementare. Quanto è importante l’istruzione nella difesa dell’Amazzonia?
«Abbiamo bisogno di un sistema educativo che ci aiuti. Finora ci hanno abituato non soltanto al consumo, ma al consumo senza limiti. Necessitiamo di un’educazione nuova, basata su un’altra mentalità, che ci renda persone responsabili nell’uso delle risorse. Il mondo ci chiede di essere responsabili con il pianeta, con la nostra casa comune, con la natura che Dio ci ha regalato».
Paolo Moiola

Questo dossier:
• Approfondimenti
Il manifesto della Minga di Puerto Leguízamo è leggibile a questo link (clicca su questa linea).
Sul canale YouTube sono invece reperibili vari documentari di padre Angelo Casadei.
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=UUG7cIYkOIY?feature=oembed&w=500&h=281]
• Prossimamente
Il nostro reportage lungo il río Putumayo proseguirà in terra peruviana fino alle comunità di Soplín Vargas e Nueva Angusilla.
• Dedica
Questo dossier è dedicato a padre Antonio Bonanomi, scomparso domenica 7 gennaio. Per molti anni padre Antonio – una vita in Colombia, soprattutto tra gli indigeni del Cauca – è stato assiduo informatore dell’autore sulle cose colombiane, nonché guida durante il primo viaggio in quel paese. Mancherà a tanti. (Pa.Mo.)
![]()
Vicariato di Puerto Leguízamo-Solano
· FONDAZIONE
Il 21 febbraio 2013. Da allora è retto da mons. Joaquín Humberto Pinzón Güiza.
· GEOGRAFIA
Si estende in tre dipartimenti colombiani: Caquetá, Putumayo e Amazonas. È caratterizzato dalla presenza di due grandi fiumi: il río Caquetá e il río Putumayo, più i loro affluenti. In esso si trovano il Parco nazionale naturale La Paya, il Parco nazionale naturale Chiribiquete e la Zona di riserva forestale dell’Amazzonia. I centri urbani principali sono Puerto Leguízamo (Putumayo), Solano (Caquetá) e Puerto Alegría (Amazonas).
· POPOLI?INDIGENI
Kichwa (Quechua), Koreguaje, Siona, Huitoto (ramo Murui), Inga, Nasa, Andoque.
· ALTRE?POPOLAZIONI
Meticci (campesinos) e comunità di afrodiscendenti.
· DATI
- SUPERFICIE: 64.912 km2;
- POPOLAZIONE: 46mila abitanti;
- RELIGIONE: 36mila cattolici.