Italia 2014: sei madri si raccontano
Economia e politica contro le mamme
Quello che ci figuriamo come il classico paese dei
«mammoni», accoglie ben poco, e male, le mamme: l’Italia non ha infatti una
politica in favore della famiglia e della mateità e rende difficile la vita
alle coppie ancora convinte che avere figli abbia senso e sia segno di civiltà
e sorgente di progresso.
 Essere
Essere
«madre», nel 2014, è una sfida che si scontra con un’economia allo sbando. Per
tutelare il più nobile diritto della civiltà, la mateità per l’appunto, la
strada è ancora tutta in salita. In un paese dove il tasso di disoccupazione è
pari al 12,6% (dati Istat), le più penalizzate rimangono le donne e, in
particolare, le madri. La carenza di servizi per la prima infanzia (va
ricordato che solo l’11% dei bambini italiani va al nido, ventuno punti in meno
rispetto ai numeri raccomandati dalla strategia di Lisbona del 2002) e una
mentalità ancora prevalentemente maschilista, delega tuttora alle donne la cura
dei figli e l’organizzazione della casa. Chiara Saraceno (ritratta nella
foto di destra), una delle sociologhe italiane di maggior fama,
specializzata in tematiche familiari, questione femminile e politiche sociali,
ci delinea nitidamente questa pagina di storia italiana: «Il nostro è un paese
in cui conciliare responsabilità famigliari e lavoro remunerato è molto
difficile: perché i servizi per la prima infanzia e le scuole a tempo pieno
sono mediamente insufficienti; perché la divisione del lavoro in famiglia
continua a essere disomogenea tra uomini e donne; perché nell’organizzazione
del lavoro si è diffusa più la flessibilità dettata dalle priorità aziendali
che non quella che tiene conto delle esigenze dei lavoratori. Ci sono
differenze tra donne, a seconda del livello di istruzione, dell’area geografica
di residenza, del tipo di professione. È più facile per le laureate che vivono
nel Centro-Nord combinare lavoro remunerato e mateità. Anche per le laureate,
tuttavia, lavoro e mateità possono apparire inconciliabili. Secondo gli
ultimi dati Almalaurea, a cinque anni dalla laurea è occupato il 63,3% di
coloro che hanno già un figlio a fronte del 75,8% di coloro che non ne hanno.
La mateità allarga la differenza con i coetanei maschi, le cui percentuali
sono rispettivamente 88,9% e 83,5%. Mentre la pateità è associata a una più
alta partecipazione al lavoro, per la mateità è vero il contrario. Il fatto è
che le giovani laureate, oltre a sperimentare maggiori difficoltà di conciliare
famiglia e lavoro quando hanno un figlio, fanno anche più fatica a passare da
un contratto temporaneo a uno definitivo, con meno garanzie in caso di
interruzione per mateità» (La Repubblica, 24/04/2014).
Alla luce di tutto ciò, e considerando che anche
l’attuale premier Matteo Renzi sta promuovendo una maggiore flessibilizzazione
dei contratti di lavoro, come se la passeranno le donne e, in particolare, le
mamme, nel prossimo futuro? «Poter spezzettare un rapporto di lavoro in
contratti di 4-5 mesi, salvo ricominciare da capo, con un nuovo
lavoratore/lavoratrice allo scadere dei tre anni, sarà deleterio per le donne.
La possibilità di fare contratti brevi, rinnovabili più volte, consentirà ai
datori di lavoro di ignorare del tutto legalmente la norma sul divieto di
licenziamento durante il cosiddetto periodo protetto. Non occorrerà neppure più
far firmare, illegalmente, dimissioni in bianco, o indagare, sempre
illegalmente, sulle intenzioni procreative al momento dell’assunzione. Basterà
fare loro sistematicamente contratti brevi, non rinnovandoli alla scadenza in
caso di gravidanza. Con l’ulteriore conseguenza negativa che molte donne non
riusciranno a maturare il diritto alla indennità di mateità piena e faranno
fatica a iscrivere il bambino all’asilo nido, dato che non potranno dimostrare
di avere un contratto di lavoro almeno annuale» (Lavoce.info,
17/03/2014).
In virtù di queste considerazioni nasce il nostro
dossier che restituisce totalmente la voce a una galleria di donne italiane e
straniere. Attraverso le loro scelte e il loro quotidiano, cercheremo di
mostrare uno spaccato di genere in una situazione italica, in cui la penuria
lavorativa sembrerebbe voler appiattire, uniformare e rendere invisibili i talenti,
penalizzando le multi capacità femminili. Ma, come sempre, le donne si
riorganizzano, si reinventano e combattono.
Gabriella
Mancini
Tre madri italiane nell’impresa di
Conciliare lavoro e
famiglia
A volte occorre semplicemente mettersi in ascolto. È quello
che abbiamo fatto per ridare voce alle donne, troppo spesso messe a tacere.
 Un contratto a progetto per anni in un’agenzia di
Un contratto a progetto per anni in un’agenzia di
comunicazione milanese, una professionalità mai messa in discussione dai
responsabili dell’azienda, una porta chiusa alla nascita del secondo figlio a
favore di una neolaureata sottopagata e… libera da vincoli familiari.
«Quando
sono rimasta incinta del mio secondo figlio ero alle soglie dei 40 anni.
Lavoravo da dieci anni come copy writer in un’agenzia di comunicazione e
svolgevo parallelamente attività giornalistiche di interesse sociale, sempre
poco remunerative ma molto gratificanti. Il lavoro in agenzia era a tutti gli
effetti da dipendente (orari e impegno sul luogo di lavoro) ma travestito da
contratto a progetto, reiterato anno dopo anno. Fino all’ultimo mese di
gravidanza lavorai con un buon ritmo. Nelle ultime settimane, i miei capi mi
affiancarono una giovane stagista – non retribuita – per sostituirmi nei mesi
della mateità. Tre settimane prima della data prevista del parto, in
occasione della mia festa di “arrivederci”, le titolari dell’azienda (entrambe
con tre figli a testa) mi riempirono di sorrisi, baci e abbracci. Andai in
mateità fiduciosa che avrei ritrovato il mio ruolo e la mia postazione dopo i
cinque mesi obbligatori. Le voci erano rassicuranti: la giovane sostituta, per
quanto volenterosa, non aveva la mia stessa esperienza e la mia penna».
La mercificazione della propria professionalità
«Dopo cinque mesi, mi scrissero che non c’era una mole
di lavoro sufficiente per due persone e che potevo prendermi ancora tre mesi di
mateità facoltativa. Iniziarono a rispondere meno alle mail e a rimandare un
incontro per riformulare la nostra situazione. Quando, finalmente, si decisero
a farmi andare in ufficio, chiedendomi di portare il pargolo per poterlo
finalmente conoscere… mi dissero che molti clienti avevano ritirato i loro
contratti, che erano nel periodo più buio della loro storia aziendale e che la
mia figura non poteva esser economicamente contemplata. Rimasi senza parole,
con il bimbo in braccio. Improvvisamente invasa da una fragilità senza
confronti. La mia professionalità veniva trattata come merce e barattata in
cambio della possibilità di sfruttare una giovane disponibilissima a non esser
retribuita benché lavorasse 10 ore al giorno. Mi dissero che, anche se la
qualità dei contenuti sarebbe stata più scadente, loro necessitavano di
manovalanza a costo zero, e, dal momento che nel frattempo il mio contratto
sarebbe scaduto, la mia presenza non sarebbe più stata necessaria».
 Scelte che bruciano
Scelte che bruciano«Mi tormentai due settimane sul da farsi: ripresentarmi
comunque e pretendere il posto (in virtù della mateità il contratto prevedeva
un prolungamento dello stesso per un certo periodo); iniziare una lunga causa
legale per pretendere il risarcimento di tutti i contributi non pagati, delle
ferie e di quant’altro; cercare un compromesso. Per avere chiarimenti mi
presentai al Nidil (il sindacato dei lavoratori atipici) da cui non ebbi alcuna
risposta esauriente, a dimostrazione del fatto che in materia di contratti a
progetto, la formulazione di una vera tutela sindacale era ancora ben lontana.
L’unica soluzione era agire, privatamente, per via legale. Ebbi timore di
affrontare una sfida simile perché avrei potuto farmi terra bruciata per altre
eventuali collaborazioni. La sensibilità e l’emotività accentuata dalla mia
nuova situazione esistenziale (e ormonale), l’allattamento e le cure continue
al piccolo, il desiderio di riprendermi la mia vita e la mia serenità senza
dover tirar fuori le unghie in un’aula di tribunale, mi fecero demordere.
Scelsi la via del compromesso e patteggiai un risarcimento per i mesi di
prolungamento del contratto. Ancora adesso la scelta mi brucia. La tutela della
mateità è simbolo di civiltà e il non esser stata tenace nel rivendicare
quello che era giusto è una ferita ancora aperta. Con il tempo, però, ho
iniziato a riprendere coraggio e fiducia in me stessa, a ricostruirmi
un’identità che mi sembrava persa e a riorganizzarmi, come madre, come donna,
come professionista».

Essere dirigenti significa saper fare l’equilibrista: tra
lavoro, figli, casa e marito. La libertà della donna passa attraverso il mutare
della mentalità predominante che vede ancora la «madre» come l’unica addetta
alla cura dei figli.
«Dopo
la laurea in architettura, vinsi un dottorato in pianificazione territoriale e
urbanistica. Fu un’esperienza di approfondimento e di rilievo ma non riponevo
molte speranze nella carriera universitaria. Così, quando ebbi un responso
positivo da un concorso presso l’ufficio tecnico per l’urbanistica e l’edilizia
privata di un ente territoriale, non esitai.
Dal 1996 al 2002 cercai sempre di conciliare casa e
lavoro in maniera sistematica, con non pochi sacrifici. La mia primogenita
nacque nel 1998, e il secondo nel 1999. Nel 2002 diventai la responsabile
dell’ufficio e, se da un lato acquisii maggior flessibilità nell’orario
lavorativo, dall’altro una maggiore dipendenza mentale e un forte ingombro
psicologico iniziarono a penetrare nelle ore dedicate alla famiglia. Non è
semplice staccare la spina, allontanare i pensieri del lavoro e ritornare a
vestire il ruolo di madre. Basta lo squillo di un telefono o il ricordo di una
mail da inviare d’urgenza e i figli si ritrovano privati della tua presenza. La
mia sensazione è sempre stata quella di dovermi dividere: tra l’esser madre,
donna, moglie, professionista, organizzatrice della casa. Le identità sono
tante, le sfumature personali altrettante, e in questo volerci essere per tutti
e in maniera perfetta, ho rischiato spesso il bu out».
 La conciliazione e i sensi di colpa
La conciliazione e i sensi di colpa«Ho sempre cercato di essere un’acrobata e di vestire i
miei tanti panni in misura tale da non deludere gli altri e me stessa. Senza
reti familiari in soccorso e con la penuria di nidi e di servizi per
l’infanzia, l’incastro tra lavoro e vita privata è stato un gioco da
equilibristi. E allora, ecco le corse per non perdere le assemblee scolastiche
dei ragazzi, il controllo quotidiano del diario prima di sprofondare nel letto,
la partecipazione a qualche laboratorio nelle loro classi, la volontà di
cercare sempre e comunque un dialogo e delle attività ricreative da fare
insieme. Accanto a tutto questo va ricordato che oggi, 2014, in Italia e in
modo trasversale a tutti gli strati sociali, la cura dei figli rimane ancora
prevalentemente a carico della madre. Con un cambio di paradigma e una maggiore
collaborazione da parte dei padri, forse, si potrebbero conciliare meglio le
due sfere. Rimane, ed è indubbiamente figlio di una cultura femminile ancora
arretrata e in parte maschilista, il senso di colpa per non essere solo “una” e
per non rivestire in toto quella figura. Per quanto io faccia, anche
sacrificando tutto il tempo di cui avrei bisogno per me stessa, rimane immutata
la sensazione che, con un orario più agevole sul lavoro e meno responsabilità,
potrei seguire meglio la crescita, sia didattica che umana, dei miei figli».
La libertà passa attraverso il mutare della mentalità
«Il fatto di trovarmi, sovente, unica donna ai tavoli di
lavoro manageriali, presieduti dagli alti vertici, mi ha portato ad affinare
delle arti di “difesa”. Più di una volta ho dovuto rispondere a battute
prettamente maschiliste. Con l’esperienza, la costruzione di una forte identità
e una buona quantità di letture “di genere”, ho imparato a rispondere a tono e
a non cedere di fronte a chi vuole farmi sentire inadeguata o un’arrivista che
cerca il riconoscimento a tutti i costi, e minando così la mia autostima.
Oggi, con un terzo figlio di soli tre anni (avuto over
40), ho maturato la consapevolezza che l’unica via in Italia per potersi godere
i figli, sia quello di scegliere autonomamente di declassarsi, sia come
posizione che come retribuzione. Seppur senza rimpianti per le mie “acrobazie”
quotidiane e le mie scelte di vita, sto iniziando a progettare in questi
termini. Per me potrà voler dire riappropriarmi di una fetta di mateità. Per
il genere femminile in Italia è una sconfitta. Ancora una volta siamo noi donne
a dover rinunciare alle nostre potenzialità!».

Una laurea in scienze politiche con una tesi su tematiche
interculturali. Un lavoro come addetta alla vendita di una nota catena di
articoli sportivi, in cui il 70% dei collaboratori sono donne ma solo il 30%
ricopre cariche dirigenziali. Un difficile incastro tra orari lavorativi e
famiglia.
«Dopo
due anni di lavoro come ricercatrice sociale sui temi dell’immigrazione, per
riuscire ad avere una maggiore stabilità economica, accettai un posto da
commessa in una grande catena di articoli sportivi. Con l’arrivo delle mie
prime due bimbe divenne difficile riuscire a ritrovare qualche collaborazione
nel settore dei miei studi e, per necessità familiari, il lavoro che doveva
essere momentaneo divenne definitivo. Oggi come oggi, con l’arrivo del mio
terzo piccolo di non ancora due anni, le difficoltà nel conciliare gli orari
scolastici e di vita delle figlie con un lavoro che prevede tui fino alle 21,
dal lunedì al sabato, ed un unico giorno libero settimanale, riunire la
famiglia è sempre più impegnativo. L’abusato termine “flessibilità” nasconde
una realtà che non aiuta a far combaciare i diversi tasselli della vita
famigliare, soprattutto quando si riduce al comunicare sempre all’ultimo minuto
i tui di lavoro ai dipendenti».
Un part time con orari sempre improvvisati
«Per poter gestire casa e famiglia ho scelto l’opzione
del part time, ma dal momento che gli orari dei tui vengono comunicati
settimanalmente, le difficoltà organizzative permangono e ricadono sul
compagno, sui propri genitori/nonni (se si ha la fortuna di averli) o sulle
baby sitter.
Questo essere sempre sospesa e in attesa delle decisioni
altrui mi crea un forte senso di precarietà e di dipendenza, sia da chi ha il
potere di decidere circa il mio lavoro, sia da chi mi aiuta nella gestione
familiare. Inoltre, il calendario scolastico, con festività e vacanze, coincide
con i periodi di maggior impegno lavorativo. Ne consegue che non è sempre
possibile stare con le bambine durante le vacanze natalizie, pasquali o estive
che siano. Al contrario, si hanno maggiori possibilità di andare in ferie quando
le scuole sono aperte e di conseguenza sono spesso costretta a scegliere tra
rinunciare ad attività con la famiglia – riducendo le ferie a un periodo da
trascorrere a casa – e far perdere giorni di scuola ai figli».
Domeniche al lavoro e nessun incentivo
«Un’ulteriore penalizzazione per chi deve conciliare il
tempo del lavoro con quello della famiglia è rappresentata senz’altro dal
decreto Monti che consente ai negozi di restare aperti 24 ore su 24, sette
giorni su sette. Un emendamento che avrebbe dovuto far nascere nuovi posti di
lavoro, ha invece obbligato gli stessi lavoratori ad avere sempre meno giorni
festivi, senza incentivi di alcun tipo, e a ridurre ancor più il tempo da
dedicare alla famiglia. Questa è la mia storia ma è rappresentativa di una condizione
generale delle donne sposate e con prole che subiscono una discriminazione
rispetto alle colleghe nubili le quali, secondo i responsabili di settore,
risultano più meritevoli di aumenti su base oraria. In questo mondo che volge
il capo al passato, quello che posso fare come donna e come madre è continuare
a sensibilizzare le persone su questo tema e a lottare affinché siano garantiti
i minimi diritti e, un domani, possa esistere uno spaccato sociale più a misura
di “mamma” alle mie bambine».
Gabriella
Mancini
Tre voci di esperienze transnazionali
Mateità, emigrazione e intercultura
Il contributo alla natalità dato dalle madri di cittadinanza
non italiana è importantissimo. L’Istat stima che nel 2010 oltre 104 mila
nascite (il 18,8% del totale) siano attribuibili a madri straniere. Le famiglie
con un componente non italiano sono pari al 6,9%, un dato triplicato negli
ultimi dieci anni, e le convivenze sono circa 600 mila (200 mila i matrimoni). Dati
che parlano da soli dell’eterogeneità della nostra rete sociale, delle
trasformazioni apportate dal fenomeno migratorio e della costruzione di una
nuova geografia umana. Una tunisina e due italiane con mariti o compagni di
nazionalità straniera, ci raccontano il loro essere madri nell’Italia di oggi,
i sogni sul futuro e le sfide quotidiane.

4. Emna
Emna è una donna tunisina, un’amica complice e solidale, una
donna piena di risorse. È venuta in Italia per raggiungere il marito nel 2005,
da neo sposa, e nel 2006 è diventata una mamma. Ecco la sua storia.
«Mi
sono laureata in scienze delle relazioni inteazionali in Tunisia e ho
lavorato per anni come assistente al responsabile marketing di una grossa
azienda. Il mio lavoro mi piaceva, rappresentava una sfida e una nuova
avventura ogni giorno, in un ambiente sereno dove il comune denominatore era
far crescere il personale e lavorare sulla stima di sé stessi e del gruppo.
Poi ho conosciuto il mio futuro marito e, sull’onda
delle scelte esistenziali, l’ho seguito in Italia dove viveva e lavorava già da
alcuni anni. Ho lasciato volutamente alle spalle carriera e lavoro e ho aperto
una nuova pagina della mia vita. Dopo solo un anno da “italiana” sono rimasta
incinta e mio marito è stato il mio grande alleato durante tutta la gravidanza.
Mi ha sostenuto nell’iter della mateità: dal consultorio, agli ospedali, alle
visite e, soprattutto, mi ha facilitato nella traduzione della lingua. Poi,
pian piano, mi sono iscritta a un corso di italiano e, grazie allo studio, ho
iniziato a muovermi con più facilità nel territorio. Quando si aspetta un
bambino si ha bisogno di certezze: saper leggere le ecografie e capire cosa
dicono i medici diventa fondamentale. Le sfumature della lingua e gli sguardi
sono importanti».
Primi tempi tra amore e solitudine
«Quando è nato il mio primogenito si sono contrapposti
in me due sentimenti: la gioia e la solitudine. Ogni volta che qualcuno apriva
la porta della mia camera in ospedale, sussultavo. Immaginavo di veder entrare
tutta la mia famiglia. Mi è mancato tantissimo quel calore famigliare,
quell’amore e quella cura che (in particolar modo da noi in Tunisia) viene
donata alla puerpera.
Nei primi tre mesi della mia nuova vita da mamma, mi
mancavano le mie radici, la mia terra, la mia famiglia. Per avere un figlio
all’estero devi essere forte, rigida, non hai nessuno che ti aiuti, il tempo
per te stessa è cancellato in virtù di tutte le mansioni pratiche che devi
svolgere. Le più piccole cose quotidiane, se ti senti fragile, iniziano a
diventare difficili: alzarti e rialzarti, infilarti le scarpe, presentarti in
modo dignitoso. Alle insicurezze del mio essere neo mamma si aggiungevano i
problemi burocratici: non è stato semplice avere un permesso di soggiorno per
poter tornare in Tunisia dalla mia famiglia. Quando riuscii a esplicare tutte
le pratiche e potei tornare qualche tempo nel mio paese, riuscii a vivere il
puerperio che non avevo potuto vivere in Italia. Le donne coccolavano il
piccolo e me. Un bagno turco al pomeriggio, qualche massaggio, un taglio ai
capelli e tante confidenze amichevoli. La cura della mia persona si univa alla
piacevolezza dello stare insieme a persone care».
La mia vita è in Italia
«Passati due mesi ho capito che dovevo tornare. La mia
vita era in Italia. La prima cosa da fare era un corso e ho pensato di fae
uno per mediatrice culturale. Per fare ciò il piccolo doveva stare all’asilo.
Come per tutte le mamme italiane ho fatto la mia trafila per un posto al
comunale, ho atteso che si snellisse la lista d’attesa e, quando è arrivato il
mio tuo, mi sono rimessa in carreggiata come donna.
Per fortuna il nido scelto, un comunale della zona, mi
ha offerto una sorta di nuova famiglia. Quella che mi mancava: dall’economa,
alle maestre, alle mamme. Queste relazioni, consolidate nel tempo, mi hanno
favorita quando è nata la secondogenita e il puerperio è stato diverso. A otto
mesi ho avuto comunque un po’ di depressione. Quindici giorni di rifiuto del
cibo e una sola volontà: stare a letto. Fosse successo con il primogenito avrei
fatto molta più fatica a riprendermi, ma questa volta avevo seminato e
coltivato complici amicizie. Questo volle dire tantissimo. Poco per volta, mi
rialzai in piedi, ricominciai a uscire, ad accompagnare i bimbi, a fare un
ulteriore corso come Oss e, pian piano, tornai a vivere».
Prima la famiglia, poi il lavoro…
«In Italia ho perso una carriera, l’affetto dei parenti,
la stabilità lavorativa. Qui, in balia dell’attuale crisi economica, ho dovuto
metter da parte le aspirazioni per una professione idonea ai miei studi e
accettare anche mansioni più umili. La socializzazione mi ha aiutato in parte a
ricucire lo strappo con la mia nazione e a elaborare i cambiamenti. Cosa ho
guadagnato dall’esperienza italiana? La risposta è nel mio cuore: probabilmente
nel mio paese d’origine oggi mi sarei affermata lavorativamente ma non avrei
incontrato la persona giusta e non sarei riuscita ad avere la serenità
familiare di adesso. Le incertezze permangono ma la lotta continua,
supportata da quella forza e quella rete che tifa per me».
Le parole chiave di Emna, come donna e come madre migrante
«Nella mia storia di donna e madre migrante un punto
fermo è stato, ed è tuttora, dare una buona immagine di me stessa e del mio
paese. Educazione, dignità personale, cultura e un forte senso
dell’aggregazione sono indispensabili. Adattarsi alle regole del paese di
accoglienza mantenendo le proprie radici mi ha aiutata a guadagnarmi il
rispetto della gente e a essere sempre credibile. La credibilità e l’educazione
vanno a braccetto e sono trasversali a tutte le nazionalità. Non esistono
stranieri e italiani, ma persone! Su questo nesso si fonda il mio pensiero e il
mio modo di essere donna, madre e di vivere in un paese che non è quello della
mia nascita ma che è ormai la mia casa. Sono certa che un domani, non lontano,
anche la Emna professionista si riguadagnerà il suo spazio in questa fetta di
mondo».

5. Melissa
Italiana e sposata con uno straniero. Poi la separazione e
la gestione affettiva e quotidiana dei figli. Tra pedagogia e sfide sul lavoro.
«Quando
ho capito che avrei cresciuto da sola i miei figli ho, in un certo senso,
provato un sentimento di sollievo. Ho metabolizzato velocemente che due
genitori separati o divorziati con un rapporto sereno, o almeno civile, possono
dare molto di più ai loro figli. In principio lo sconforto era dovuto
principalmente al timore di non saper affrontare da sola la crescita dei
bambini. Mi domandavo spesso se stavo facendo il meglio per loro e mi interrogavo
sulla loro sofferenza, vivendo tutto con grandi sensi di colpa. Nonostante il
rancore verso il padre dei piccoli (un maschio e una femmina che oggi hanno 10
e 9 anni) mi sono imposta, sin dall’inizio, di non lamentarmi mai di lui
davanti a loro, per dare loro una bella immagine del papà e confortandoli
sull’amore paterno. Il dialogo sulle motivazioni delle scelte fatte,
indipendenti dall’affetto figliale, mi hanno aiutata a vincere la rabbia».
Rientro al lavoro, tra nidi privati e qualche ostilità
«Terminata la mateità dovetti
ricorrere a un nido privato che allora, nel 2004, comportava già una retta di
400 € al mese. Dopo
qualche tempo venni chiamata dal nido comunale e iniziai finalmente a pagare in
base al reddito, trovando anche un ambiente più professionale, umano e
competente. Due anni dopo, per la piccola, venni a conoscenza dei micro nidi
famigliari che, senza cifre assurde, garantivano un ambiente armonioso per i
bambini. Dalle ore 13 fino al mio rientro dal lavoro la piccolina era affidata
a una tata, e tutto ciò comportava un’ulteriore spesa. Rispetto ai paesi nord
europei, le strutture per la prima infanzia e per la gestione dell’estate dei
bambini piccoli sono ancora totalmente inadeguate.
Il ritorno al lavoro dalla mateità
è stato anche il tempo delle ostilità, sottili e dolorose. Mi sono trovata a
dover subire battute non molto spiritose, atteggiamenti infastiditi e qualche
critica, anche da parte di donne e madri, come se al posto di una mateità di
5-6 mesi, mi fossi concessa un soggiorno ai Caraibi. Tutto ciò mi ha fatto
pensare che in Italia siamo noi cittadini, con la nostra mentalità antiquata e
incivile, a essere i primi responsabili della scarsità di alcuni servizi e
diritti che non dovrebbero invece esser messi in discussione».
Pregiudizi e credibilità dei genitori
«Non ho avvertito pregiudizi nei confronti del mio
essere una madre single ma, spesso, ho percepito compassione da parte di altri
genitori e un irrigidimento verso i nomi arabi dei bambini. Sguardi circospetti
di circostanza mi accompagnano ma, con il tempo, sono diventata forte e la
compassione, come il disprezzo altrui, mi fa sorridere. Riuscire a crescere da
sola i miei bambini e a guadagnarmi, giorno dopo giorno, il loro rispetto e
affetto, mi ha insegnato molto. Con l’età si rischia di dimenticare le emozioni
e i sentimenti che si avvertivano nell’infanzia e nella fanciullezza.
Innalzarmi al loro livello e mantenere viva la bambina che c’è in me, mi aiuta
a capire e a dialogare con i miei figli, mi aiuta a essere coerente e
credibile. Quello che cercano i bimbi di oggi è solo questo: credibilità. Una
dote che può regalare loro quell’equilibrio interiore utile per vivere con un
po’ di serenità questa vita».
 Italiana. Un’esperienza di lavoro in Burkina Faso diventa
Italiana. Un’esperienza di lavoro in Burkina Faso diventa
l’inizio di una nuova esistenza. Una scelta controcorrente, una gravidanza in
solitaria e una nuova famiglia italo-africana, con un futuro tutto da
inventare.
«Lavoravo
da qualche anno presso alcune cornoperative sociali come educatrice della
comunicazione. Nel marasma della crisi italica mi potevo ritenere fortunata
poiché, seppur con magri stipendi, ero riuscita ad avere un contratto a tempo
indeterminato. Sentivo, però, che mi mancava qualcosa. Il mondo del sociale mi
aveva offerto una grande occasione ma, dopo la prima ondata di emozioni data
dalla relazione con l’altro, mi aveva lasciato un sapore amaro in bocca e una
certa demotivazione. La ragione va ricercata nell’organizzazione del settore
stesso che tende a sovraccaricare di lavoro e a soffocare le persone senza far
esprimere al massimo l’umanità e la creatività degli educatori. A 33 anni, con
la voglia di reinventarmi e la giusta motivazione, decisi allora di partire per
il Burkina Faso e di progettare un percorso di arteterapia locale. L’Africa,
d’altro canto, era sempre stata una terra dal forte magnetismo per me. Una
volta atterrata e visitatone un piccolo angolo, l’esperienza ha confermato il
sentimento, e il desiderio di conoscerla più a fondo, percorrerla ed entrarvi a
fae parte».
Una nuova vita fuori… e dentro di me!
«Iniziai a condurre un atelier di arte terapia dove,
attraverso l’attività manuale e artistica, si elaboravano percorsi
psico-dinamici. All’interno di questo cammino, iniziammo un progetto di teatro
di marionette e fu in quell’occasione che incontrai Didier, esperto di teatro
sociale. Non è mai solo una la ragione che porta a innamorarsi di un’altra
persona. Di Didier mi colpì senza dubbio il suo essere aperto al mondo esterno,
la sua autenticità e la sua naturale predisposizione all’attenzione verso la
persona umana. Avevo programmato un viaggio di tre mesi nei dintorni africani e
un breve ritorno a casa in Italia (“nassaratenga” la terra dei bianchi in
lingua moorè) quando la scoperta, tanto improvvisa quanto dolce, di aspettare
un bambino, rivoluzionò i miei piani. I primi controlli medici evidenziarono
una gravidanza “a rischio” e la necessità di un cerchiaggio. Non mi rimaneva
che scegliere l’Italia per tutelare nel miglior modo il prosieguo della
gravidanza e la salute del piccolo. La vita aveva cambiato le carte in tavola.
Non ero più io a dover tornare in Burkina ma Didier a venire in Italia».
Un’onda di limiti burocratici tra l’Africa e l’Italia
«Le peripezie iniziarono quando Didier richiese il
passaporto per espatriare. Nonostante tutte le garanzie richieste
dall’ambasciata (lettere d’invito in originale, estratti conto, buste del
salario e la fotocopia dell’atto di proprietà della casa) le autorità
rilevavano sempre qualche piccola mancanza nella documentazione. Passarono
alcuni mesi, la mia pancia cresceva ma il passaporto di Didier continuava a
esser negato, nonostante un continuo lavoro congiunto tra Italia e Africa. Il
fatto di voler poi rientrare nella terra africana, non era contemplato e
compreso dai funzionari locali. A quel punto, rassegnata a partorire sola e a
partire per l’Africa con un neonato, ricontattai l’ambasciata italiana per
chiedere il riconoscimento della bimba da parte del padre».
 Finalmente insieme con Wendkuni
Finalmente insieme con Wendkuni«Dopo mille peripezie e ostacoli, una voce amica
dall’ambasciata mi annunciò che, vista la situazione, avrebbero concesso
finalmente il passaporto a Didier. Ma la trepidazione non era ancora terminata.
Didier non raggiunse l’Italia ma rimase bloccato in Belgio dove venne
sottoposto a ulteriori accertamenti. Appena riuscì a chiamarmi, dopo un
atterraggio nel cuore della notte a Milano, iniziarono le prime contrazioni e,
sette ore dopo, a Torino, nacque Ilesdor.
È stata l’avventura più incredibile della mia vita.
Ilesdor è un nome inventato. Opera del padre, il giorno in cui gli comunicai di
essere incinta: significa “lui è d’oro” (Il est d’or) anche se in realtà
avrebbe dovuto essere elle, ma suonava meglio il. E proprio per
la sua voglia di venire al mondo e le circostanze così particolari in cui ha
fatto capolino nel mio utero si chiama anche: Wendkuni, dono di Dio in
moorè».
Condividere la vita, tra pregiudizi e differenze culturali…
«Nel cosiddetto occidente, non si sono abbattuti su di
noi i pregiudizi sociali. Abbiamo trovato ovunque accoglienza e simpatia,
curiosità e affetto. Li abbiamo però vissuti negli ostacoli burocratici, nella
lontananza forzata, nella nostra forsennata ricerca per “ritrovarci” e vivere
insieme. In tutto questo cammino di avvicinamento ho sentito forte, da parte
delle autorità, il preconcetto di un occidente “formato eden” e “dell’uomo
nero” che tenta di fuggire dalla sua povera e arretrata terra. La nostra è una
storia nata nell’avventura e che oggi si ritrova a condividere il quotidiano.
Come per tutte le coppie, le differenze possono creare delle difficoltà. Nel
nostro caso vale la dicotomia: a lui l’aspetto relazionale, a me quello
organizzativo. In fondo al cuore sento che sono piccolezze superabili e che
l’autenticità è la caratteristica portante della nostra unione».
Un futuro di madre e professionista in Africa
«Essere madre in Africa mi allarga il cuore, perché
l’Africa è “mamma Africa”. Le immagini si sovrappongono ed è come se la natura
avesse realmente connotati di femminile, accogliente ed accudente, questa
terra. Ovviamente i servizi per l’infanzia di cui lamentiamo la penuria in
Italia, lì non esistono proprio ma ci sono le persone che rendono (quasi)
superflui questi servizi. Una serie di zie e di nonne locali (vere e acquisite)
potrà aiutarmi con la piccola mentre cercherò di realizzare un progetto
multidisciplinare di arteterapia con altri professionisti e sarò il braccio
destro di Didier nella costruzione della sua futura fattoria. Fortificata dalla
nostra relazione e dall’amore per Ilesdor so che combatterò con una grande
forza interiore per poter tradurre in realizzazioni tutti quei desideri celati
nei nostri cuori».
Gabriella Mancini

Sei
donne, sei storie, sei voci. Un piccolo coro che si unisce alla grande realtà
statistica italiana. Siamo il peggior paese in Europa in tema di occupazione:
solo il 65% delle donne senza figli lavora, segue un 60,6% di quelle con un
figlio, il 54,8% con due figli e il 42,6% con tre figli. I servizi per la prima
infanzia, carenti e costosi, contribuiscono a mantenere alto il livello di
disoccupazione per le donne con bambini sotto i tre anni. Dai racconti delle
nostre donne emerge, oltre alle varie difficoltà di conciliazione tra lavoro e
famiglia e le inadeguate politiche sociali in merito, una mentalità ancora
retrograda atta a delegare quasi esclusivamente alla donna la cura della
famiglia. E questo, aldilà di ogni estrazione culturale o sociale. Allo stesso
tempo, questo lavoro domestico, dato per scontato, non è né riconosciuto né
sostenuto da un apparato giuridico, sociale e retributivo che lo tolga dalla
precarietà, ne riconosca la dignità come «lavoro» e ne valorizzi il grande e
indispensabile contributo che dà a tutta la società.
La Cnn ha recentemente pubblicato una classifica dei
migliori paesi per le mamme lavoratrici. Su otto, sette sono in Europa: si
tratta di Islanda, Svezia, Danimarca, Francia, Paesi Bassi, Finlandia e
Norvegia. All’ottavo posto c’è il Canada. Sono paesi dove il diritto al lavoro
e alla mateità non può e non deve essere violato, in nome di un codice etico
e civile che fa rima con la progressione dell’umanità.
Alcune domande sorgono: che bisogna fare per
rivoluzionare un modus pensandi così cristallizzato e trasformare questo
stato di cose? Cosa fare perché la mateità e l’educazione dei figli non diventi un privilegio per ricchi? Cosa
fare perché la famiglia (uomo, donna e figli) – non la carriera, la produzione,
l’utile aziendale – continui a essere al centro della nostra vita sociale?
Le risposte sono difficili a darsi, visto che più
elementi – politici, sociali e antropologici – dovrebbero intervenire
all’unisono. La riflessione merita però un approfondimento e una lente focale
su un terreno più ampio. Se l’esser
genitore al femminile comporta spesso la rinuncia al lavoro o la
decontestualizzazione della persona in più spaccati sociali, con un alto
rischio di alienazione, molte risposte vanno sicuramente ricercate nel nostro
modello societario attuale. Un modello che prevede (in misura trasversale per
uomini e donne) la produzione senza sosta e la corsa alla competizione in ogni
ambito. Varrebbe allora la pena di agire tutti insieme per trasformare in realtà
le parole, oggi considerate «utopiche», di Silvano Agosti che, nel suo libro Lettere
dalla Kirghisia disegna un paese «ideale» dove: «[…] in ogni settore
pubblico e privato, non si lavora più di tre ore al giorno, a pieno stipendio,
con la riserva di un’eventuale ora di straordinario. Le rimanenti 20 o 21 ore
della giornata vengono dedicate al sonno, al cibo, alla creatività, all’amore,
alla vita, a se stessi, ai propri figli e ai propri simili. La produttività si è
così triplicata, dato che una persona felice sembra essere in grado di
produrre, in un giorno, più di quanto un essere sottomesso e frustrato riesce a
produrre in una settimana […]». Un ribaltamento di paradigma, questo, che
rivoluzionerebbe un sistema al collasso e – forse – annegherebbe le
diseguaglianze in virtù della formazione di un essere umano più completo e ricco
interiormente.
Gabriella Mancini
Elena Gianini Belotti, Dalla parte delle bambine,
Feltrinelli 1982, II ed.
Loredana Lipperini, Ancora dalla parte delle bambine, Feltrinelli 2007
Loredana Lipperini, Non è un paese per vecchie,
Feltrinelli 2010
Chiara Saraceno, Sociologia della famiglia, Il Mulino 2013
Chiara Saraceno, Pluralità e mutamento.
Riflessioni sull’identità al femminile,
Il Mulino 1987, IV ed.
Chiara Saraceno, Conciliare famiglia e lavoro. Vecchi
e nuovi patti tra sessi e generazioni, Il Mulino 2011Chiara Saraceno, Mutamenti della famiglia e politiche sociali in Italia, Il Mulino 2003
Ringraziamenti
Ringraziamo le donne intervistate per la disponibilità
nel raccontarci e raccontarsi.

Geografia e anagrafica delle nascite in Italia
Si nasce poco in Italia, e da mamme sempre più in là con
l’età. Rispetto al 2011, nel 2012 sono nati 12 mila bambini in meno.
Secondo i dati del Bilancio demografico della
popolazione residente dell’Istat, sono stati 534.186 gli iscritti in
anagrafe per nascita nel 2012, oltre 12 mila in meno rispetto al 2011. Nel 2012
il numero medio di figli per donna si attesta a 1,42 (1,29 figli per le
cittadine italiane e 2,37 per le straniere).
Il dato conferma la tendenza alla diminuzione delle
nascite avviatasi dal 2009: oltre 42 mila nati in meno in quattro anni. Il calo
delle nascite ha riguardato per lo più le coppie in cui entrambi i genitori
sono italiani, quasi 54 mila in meno rispetto al 2008.
I nati da genitori entrambi stranieri, invece, sono
ancora aumentati, anche se in misura più contenuta rispetto agli anni
precedenti (2.800 nati in più negli ultimi tre anni), e ammontano a poco meno
di 80 mila nel 2012 (il 15% del totale dei nati). Se a questi si sommano anche
i nati da coppie in cui uno dei genitori non è italiano si ottengono poco più
di 107 mila nati (il 20,1% del totale delle nascite). Considerando la
composizione per cittadinanza delle madri straniere, ai primi posti per numero
di figli si confermano le rumene (19.415 nati nel 2012), al secondo le
marocchine (12.829), al terzo le albanesi (9.843) e al quarto le cinesi
(5.593). Da notare che queste quattro comunità raccolgono da sole quasi il 50%
delle madri straniere in Italia.
(fonte: Istat)
Per le straniere è peggio
Partecipazione
al mercato del lavoro
1. Tasso di occupazione più
elevato delle italiane (nel 2010 pari a 50,9% vs. 45,7%) ma:
• maggiore diminuzione con la crisi (in due anni
–1,9% punti) inferiore nelle regioni del Nord (49,5% vs. 57%);
• più basso in presenza di figli (42,7% vs.
50,6%) anche per mancanza di rete familiare oltre che per motivi culturali.
2. Forti differenze del tasso
di occupazione per comunità (superiore al 90% per le filippine e inferiore al
35% per albanesi e marocchine).
3. Tasso di disoccupazione più
elevato (nel 2010 13,3% vs. 9,3%).
4. Media primi 3 trimestri del
2011 il tasso di
occupazione scende di 0,5 punti, il tasso di disoccupazione sale di 0,2 punti.
Scarsa
la qualità del lavoro
1. Più della metà svolge un
lavoro non qualificato (58% vs. 9% delle italiane).
2. Il 40,1% svolge un lavoro
domestico presso
le famiglie (1,7% le italiane).
3. Oltre una straniera su due
svolge un lavoro per il quale è richiesto un titolo di studio inferiore a
quello posseduto (51,1% vs. 19,8%).
4. La concentrazione in lavori
poco qualificati comporta una bassa paga mensile: 788 euro vs. 1.131 euro delle
italiane.

Disoccupazione al femminileIn Italia il calo dell’occupazione è quasi esclusivamente
maschile. […] mentre per
l’occupazione femminile, dopo il calo del 2009, si osserva una crescita nel
2011 e nel 2012. Nel 2013, con l’aggravarsi del quadro recessivo anche per le
donne, si evidenzia una diminuzione dell’occupazione (-128 mila unità, pari a
-1,4% rispetto al 2012). Nel complesso dei cinque anni della crisi (2009-2013),
l’occupazione degli uomini si è ridotta del 6,9%, a fronte di un calo dello
0,1% per le donne.
Soltanto una parte dell’occupazione femminile ha
però tenuto con la crisi. La quota di donne
occupate continua a essere molto bassa (il 46,5%), di 12,2 punti inferiore al
valore medio della Ue28. La sostanziale tenuta registrata in Italia è il
risultato di un insieme di fattori: il contributo delle occupate straniere,
aumentate di 359 mila unità tra il 2008 e il 2013 a fronte di un calo delle
italiane di 370 mila unità (-4,3%), la crescita delle occupate con 50 anni e più
per l’innalzamento dell’età pensionabile e quella di coloro che si immettono nel
mercato del lavoro per sopperire alla disoccupazione del partner.
Nella fascia di età tra 15 e 49 anni, il tasso di occupazione cala per tutte le donne, non
solo per le giovani che ancora vivono all’interno della famiglia e che sono
state maggiormente colpite dalla crisi, ma anche per le madri sole, quelle in
coppia con o senza figli e le single. Il tasso di occupazione delle madri è
pari al 54,3 per cento, mentre sale al 68,8 per cento per le donne in coppia
senza figli. […]
Aumentano le donne breadwinner, ovvero crescono le famiglie con almeno una persona di
15-64 anni in cui è la donna ad essere l’unica occupata, specialmente tra le
madri in coppia. La crescita riguarda 591 mila famiglie (34,5% in più). Nel
Mezzogiorno al loro aumento si associa la riduzione delle famiglie sostenute
unicamente dal lavoro dell’uomo.
Peggiora la situazione di conciliazione dei tempi
di vita delle donne. Cresce la quota di donne
occupate in gravidanza che non lavora più a due anni di distanza dal parto
(22,3% nel 2012 dal 18,4 nel 2005), soprattutto nel Mezzogiorno dove arriva al
29,8%. Aumenta anche la quota di donne con figli piccoli che lamentano le
difficoltà di conciliazione tra chi il lavoro lo mantiene (dal 38,6% al 42,7%).
Da: Istat, Rapporto annuale 2014,
pag. 85,
pubblicato il 28 maggio 2014

Tags: mateità, mamme, lavoro, carriera, discriminazione, impiego, servizi sociali, famiglia, società, disoccupazione, donne
Gabriella Mancini





 Storia di un giovane missionario
Storia di un giovane missionario C’è sempre una prima volta, dicono. La prima volta
C’è sempre una prima volta, dicono. La prima volta




 Inchiesta «mobile money», denaro virtuale / 2
Inchiesta «mobile money», denaro virtuale / 2 Carrefour. Siamo nel grosso comune popolare all’uscita
Carrefour. Siamo nel grosso comune popolare all’uscita Secondo Georges Andy René,
Secondo Georges Andy René, All’inizio non fu facile: «La
All’inizio non fu facile: «La
 Anche Theguerre pur
Anche Theguerre pur
 E continua: «Questa
E continua: «Questa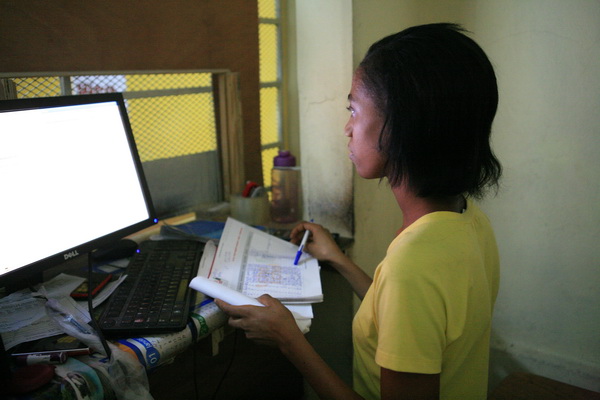
 Poi ci
Poi ci Port-au-Prince. Al secondo piano di uno stabile a Delmas
Port-au-Prince. Al secondo piano di uno stabile a Delmas Reportage da un fronte sconosciuto.
Reportage da un fronte sconosciuto. 
 La posta in gioco
La posta in gioco







 Secondo
Secondo










 Negli ultimi mesi sui media inteazionali c’è stato uno
Negli ultimi mesi sui media inteazionali c’è stato uno
 Nella
Nella La
La Partendo
Partendo
 Dopo
Dopo


 Essere
Essere
 Un contratto a progetto per anni in un’agenzia di
Un contratto a progetto per anni in un’agenzia di Scelte che bruciano
Scelte che bruciano
 La conciliazione e i sensi di colpa
La conciliazione e i sensi di colpa



 Italiana. Un’esperienza di lavoro in Burkina Faso diventa
Italiana. Un’esperienza di lavoro in Burkina Faso diventa Finalmente insieme con Wendkuni
Finalmente insieme con Wendkuni




.JPG)
.JPG)
.JPG)