Sogni non impossibili
Racconti di donne «straniere»
 di Rahma Nur, Federica Ramella Bon, Chou Mei
di Rahma Nur, Federica Ramella Bon, Chou Mei
Chen Susanna,Maria Enrica Sanna e Keréne Fuamba
Per gentile concessione del «Concorso
letterario nazionale Lingua Madre»
Questo Dossier narrativo, curato da Gigi Anataloni per MC, è
dedicato a tutte quelle donne coraggiose che, sradicate spesso a forza dalla
loro terra, lottano per un futuro di pace, armonia e frateità in questo
nostro paese di grande generosità e accoglienza, ma attraversato da pericolosi
brividi di intolleranza e razzismo.
Le foto delle autrici dei racconti sono state foite da
Lingua Madre. Tutte le altre foto sono puramente simboliche e non strettamente
connesse con le storie raccontate.
 Volevo essere miss Italia
Volevo essere miss ItaliaRahma Nur [Somalia](*)
Denny
Mendez sorrideva anche se le lacrime di gioia e sorpresa le rigavano il bel
viso da adolescente. La sua bella e scura massa di morbidi capelli ricci era in
contrasto con quella coroncina di luci brillanti da Miss che cercava di tenere
in equilibrio sulla testa, mentre le altre ragazze del concorso la assalivano
per congratularsi con lei, invidiose e sorprese anche loro che avesse vinto!
Lei, una Miss Nera! Ma mica siamo in America qui, ma cosa sta succedendo mai?
Io e mia madre non eravamo così
appassionate di concorsi televisivi, men che meno di Miss Italia. Ma quell’anno
ci mettemmo davanti alla TV ogni sera, incuriosite da quella ragazza dominicana
che cercavamo con lo sguardo durante il programma. Non sapevamo se tifare per
lei o no, ma stavamo lì a guardare trepidanti. Poi scoprii che mia madre tifava
eccome! Era orgogliosissima di vedere finalmente una ragazza nera che competeva
con le classiche bellezze italiane. Io ero scettica, forse anche un po’
invidiosa. Be’, non è che io avessi mai parteggiato per i concorsi di bellezza,
li trovavo anche mortificanti a dirla tutta. Ero solo invidiosa di questa
ragazza dominicana, arrivata in Italia solo pochi anni prima, che ancora non
parlava un italiano fluente e probabilmente non sapeva nulla né di Manzoni né
di Lucio Battisti! Ma che diritto aveva? Mi sentivo defraudata, di cosa ancora
non lo sapevo, ma ero un po’ scocciata. Speravo che a rappresentare la parte più
colorata di tanti italiani come me fosse proprio una ragazza italiana, nata o
cresciuta qui come me e tanti altri immigrati di seconda generazione. Invece,
guarda un po’ chi era riuscita ad arrivare fino a lì!
Ok a livello fisico non potevo proprio competere con la bella Denny. Lei era
una giovane adolescente, alta, magra, bella, con splendidi capelli lunghi. Ora,
non è che io fossi brutta, anzi, a detta di molti ero una bella giovane donna
somala, con i classici lineamenti somali: bocca piccola, naso piccolo e occhi
scuri; una caagione color cioccolato Lindt; ma avevo superato da qualche anno
l’età massima per essere accettata ad un concorso di bellezza; poi c’erano
alcuni problemi tecnici come la mia altezza che era ben al di sotto del minimo
richiesto ed altre piccole cosette, nonché, last but not least, non
credo che due superbe stampelle azzurre e un’elegante camminata claudicante
fossero nella lista dei requisiti per diventare una Miss. Forse avrei potuto
aspirare a Miss Disabile…!
Con questo non pensate che io ce l’avessi con Denny
Mendez, forse un pochino sì, ma poi, chi sono io per giudicare una ragazzina in
cerca del suo momento di celebrità?
Il
giorno dopo, i giornali erano pieni di immagini di Denny. C’era chi giorniva
perché sembrava che in Italia qualcosa stesse per cambiare: finalmente si erano
accorti che c’erano persone diverse, ragazze bellissime anche se non
esattamente come le solite copie di Sofia Loren o Gina Lollobrigida; ma c’era
anche chi polemizzava e vedeva questa vincita come un’ingiustizia. Io mi
trovavo tra due fuochi; se qualcuno si diceva contrario, io mi arrabbiavo e confutavo
che oramai in Italia c’erano italiani diversi e che era ora di aprire gli occhi
alla realtà dell’immigrazione e che Denny era un’apripista per tutti noi (anche
se sotto sotto, la vedevo come un’usurpatrice: io ero più italiana di lei!).
Un giorno mi trovai con una mia cara amica e iniziammo a
parlare del concorso; pensavo che lei fosse felice che avesse vinto Denny
Mendez, essendo mia amica; invece la trovai molto critica su questo argomento.
Disse che non era giusto che avesse vinto perché lei non rappresentava la
classica bellezza italiana, la cultura e la storia italiane. Mi sentii
sprofondare: rimasi senza parole. Di certo non mi aspettavo una critica così
dura da una mia amica. Allora le chiesi: se avessi partecipato io, con la mia
lunga storia di immigrata, arrivata in Italia da piccolissima, cresciuta a
spaghetti, Battisti e letteratura italiana, sarebbe stato meglio?
Lei rispose che era la stessa cosa: non rappresentavo la
classica bellezza italiana; anche io come Denny ero nera, ricciolina e
proveniente da un altro continente! Mi offesi a morte: ma come? Ai suoi occhi
non ero più italiana di Denny Mendez? Non dissi una parola, mi sentivo
profondamente ferita, discriminata e disillusa. Eppure parlavamo di musica, di
film, di libri e ci trovavamo così simili, così complementari. Avevamo
respirato la stessa aria, ascoltato le stesse canzoni, studiato gli stessi
autori e amato le stesse storie. Eravamo affini in tantissime cose. Avevamo
trascorso ore e ore a parlare di tutto; anche se io provenivo da una famiglia
diversa, somala, africana; anche se io mangiavo a volte cibi diversi che lei
aveva imparato ad assaporare; anche se la mia famiglia aveva una religione
diversa, tradizioni diverse, io e lei ci ritrovavamo in tante cose. Parlavamo
anche di politica e anche lì le nostre idee combaciavano. Com’era possibile che
ora, per un banale concorso di bellezza, ci fosse una differenza così abissale
tra di noi? Non ero anch’io italiana come lei?
In
quel momento ripercorsi la mia storia come un veloce flashback. L’Italia
ero anch’io, mia cara! Molto più di tante persone di mia conoscenza. L’Italia
ero anche io perché l’amore per questa terra me lo ero conquistato giorno dopo
giorno con le difficoltà che ho dovuto affrontare fin dall’età di cinque anni
mezzo, quando il fato mi aveva condotta qui molti anni fa. L’Italia ero anch’io
in fila davanti alla questura di Roma per rinnovare il permesso di soggiorno e
poter continuare a frequentare la scuola dove studiavo i classici latini o lo
Stil Novo; le regioni e i fiumi italiani; la Giovine Italia e le Guerre
d’Indipendenza. L’Italia ero anch’io quando salivo sull’autobus strapieno e a
volte mi capitava di urtare la solita vecchietta petulante che, appena si
girava verso di me, stringeva la borsetta e borbottava: «’Sti negri, ma perché
non se ne tornano a casa loro!», e io rispondevo freddamente astiosa: «Mi
dispiace per lei ma casa mia è proprio a due fermate da qui, scendo subito non
si preoccupi!». L’Italia ero anch’io quando, in Canada in vacanza, soffrivo le
pene dell’inferno perché non riuscivo a trovare i pomodori pelati giusti per
fare un bel ragù e mangiare le tagliatelle come avevo imparato da mia mamma o
cercavo canzoni italiane alla radio e trovavo solo nostalgiche note cantate da
Mino Reitano o Peppino di Capri che non amavo particolarmente, invece di
Baglioni o Battisti che avevano accompagnato la mia adolescenza. L’Italia ero
anch’io quando, dopo tanti anni di permessi di soggiorno rinnovati finalmente
ero riuscita ad ottenere la cittadinanza. Per anni mi ero sentita né carne né
pesce, né somala né italiana. Ero straniera nella mia stessa terra; se volevo
andare a fare un corso all’estero non potevo perché non mi rilasciavano il
visto; se pensavo di cercarmi un lavoro, desistevo subito: chi mai avrebbe
assunto una straniera e per di più disabile? L’Italia ero anch’io e forse anche
di più quando arrivò il momento del giuramento e l’ufficiale comunale mi fece
alzare la mano destra, sentii il cuore accelerare il battito e la gola seccarsi
– «Ripeta dopo di me», disse il messo comunale, ed io con voce tremante recitai
dopo di lui: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservae
lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di
tutte le persone». Parole bellissime che ripeterni lentamente, assaporandone il
significato, pensando agli articoli della Costituzione Italiana da cui erano
stati presi e che avevo studiato a scuola nelle lezioni di educazione civica;
che menti illuminate avevano redatto una sessantina di anni prima, quando
l’Italia si stava riprendendo dalla disperazione, dalla devastazione della
Seconda guerra mondiale; quando quelle stesse menti di giovani uomini avevano
lottato per la libertà di pensiero ed espressione, per l’uguaglianza tra gli
uomini e le donne. Forse quelle stesse parole che avevo appena detto,
dovrebbero essere recitate da tutti gli italiani che nascono e crescono in
questa meravigliosa terra e non si rendono conto della ricchezza e della
profondità che si cela dietro quel trascurato libro che raccoglie gli articoli
della Costituzione.
Io
sono l’Italia, quella di oggi, modea, multiculturale e multietnica, ricca di
sfumature e diversità, «bianca, nera, rossa, gialla perché, Lui ci vede uguali
davanti a sé» come recita una canzone che cantavo da bambina.
L’Italia sono anche io e non importa il colore della mia
pelle o le mie origini; non importa se non rappresento il classico canone di
bellezza italiana perché ci sono altri canoni che rappresento: quelli
culturali, quelli di pensiero, quelli di educazione e di vita trascorsa: ho
tutti i diritti di essere Miss Italia, perché è l’Italia di oggi che
rappresento!
L’Italia sono anch’io e siete tutti voi, italiani da
generazioni o da prime, seconde, terze generazioni.
___________________
(*) Rahma Nur, Volevo essere Miss Italia, pubblicato su Lingua
Madre Duemiladodici – Racconti di donne straniere in Italia, Edizioni
SEB27.
Il racconto di Rahma Nur ha vinto il Premio Speciale Rotary Club Torino Mole
Antonelliana al VII Concorso letterario nazionale Lingua Madre, 2012.
RAHMA NUR nasce a
Mogadiscio, in Somalia, il 14 dicembre 1963. Arriva in Italia nel 1969 in cerca
di cure mediche a causa di un serio problema di salute. Qui, infine, si
stabilisce e nel 1989 riesce ad acquisire la cittadinanza italiana. Vive e
studia a Roma e dal 1993 insegna in una scuola primaria statale.

 Spazio arcobaleno
Spazio arcobalenoFederica Ramella Bon [Italia](*)
In collaborazione con le alunne del CTP di Cuneo
Viaggio introspettivo
tra piccoli miracoli
Il mio registro è
colorato, parla lingue sconosciute, racconta storie lontane e vicine, di vite
nuove, spezzate, appena nate. Il mio registro canta con voce potente, con
melodie roche, con tristi nenie. Il mio registro sono loro, donne, madri,
figlie, nonne. Vite intrecciate, vite rallentate, vite accelerate, vite
esagerate. Vite di donne in cammino.
Olivia
«Da grande farò la scienziata. Sì, voglio studiare la Terra,
la luce, l’acqua. Voglio analizzare le particelle che compongono una bolla di
sapone, voglio contare le linee di simmetria di un fiocco di neve e ammirae
ogni volta la perfezione».
Questi pensieri mi hanno tenuto compagnia durante il
volo Belfast-Torino, lo scorso agosto. Guardavo giù: il lago Neagh si
allontanava e i soffici monti Moue sembravano ormai tane di lepri. Quando poi
anche il Foyle si è mostrato in tutta la sua interezza, ho capito che l’Irlanda
era ormai lontana e il sogno Italia più vicino. «It’s a miracle!»1.
Un anno intero. Trecentosessantacinque giorni e forse qualcosa in più.
Incognite, quante incognite. L’idea di dedicare un anno della mia vita
all’Italia mi è venuta due anni fa, nel giorno del mio ventiquattresimo
compleanno. Sul cartoncino di auguri di Sean c’era scritto «Fly over the moon,
Olivia!». Vola oltre la luna. Mi spiegò che nella vita aveva imparato ad
allargare i confini, a dilatare spazio e tempo e a rimpicciolire le paure. Ma
non aveva mai voluto cancellare i suoi sogni. Sean aveva vissuto i Troubles2,
e i Troubles avevano fatto di lui un uomo.
Dall’alto le nuvole mi ricordavano la panna montata e
l’aereo diventava un cucchiaino d’argento che si tuffava e si riempiva ingordo.
È iniziata così la mia avventura italiana, con ingordigia, sulla scia di
quell’aereo.
Ed eccomi qui: ragazza alla pari presso la casa di
un’ostetrica, madre di due gemelli. Non appena acclimatata con le mie nuove
mansioni di cuoca-baby-sitter-donna di servizio, ho cercato una scuola che
potessi frequentare per imparare l’italiano. Ora, seduta su questa sedia
ballerina, mi accarezzo un ricciolo guardandomi intorno: questa classe è troppo
piccola per ospitare tutto questo mondo. Si sentono accenti africani, sapori
arabi, profumi orientali; si respira quella tipica complicità di chi condivide
uno spazio neutro, nuovo, tutto da gustare. Mi sento piccola tra queste donne,
io che ho potuto scegliere di venire qua. Il cucchiaio d’argento sprofonda
sempre di più nell’universo di panna montata, nel punto in cui diventa densa,
nel punto in cui sente di dover tollerare un peso, prima di riemergere carico.
Nel banco accanto al mio è seduta Malaika, una giovanissima capoverdiana,
incinta all’ottavo mese. Chissà, magari anche in Africa chi scorge il primo
dentino del neonato deve comprargli un paio di scarpette. Arrossisco, incredula
di aver davvero formulato questo pensiero innocente. Sposto lo sguardo oltre a
questo pancione coperto di rosso e osservo le mani delle altre compagne, le
loro rughe, le loro scarpe, i loro sguardi disorientati, i loro monili di
legno. L’insegnante inizia a fare l’appello ed è come se capissi che tutto il
mondo non è paese, che il segreto è nella scoperta, nella tacita convivenza in
questo spazio arcobaleno di storie non raccontate, di desideri inseguiti, di
tenacia. E di nostalgie addomesticate.
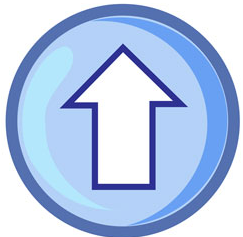 Inese
IneseSta scorrendo
l’elenco, ecco, ci siamo quasi. «Ines?»… Lo sapevo. Scontato. «Inese. Mi chiamo Inese!». L’insegnante prende
dall’astuccio una matita e traccia un piccolo segno orizzontale sul registro,
forse proprio sotto quella “e” del mio nome che gli italiani non vogliono pronunciare.
Oggi è il mio primo giorno di scuola, di scuola
italiana. Mio marito Giorgio mi ha proposto questo corso di alfabetizzazione,
ma io sono scettica, decisamente scettica. Conosco un solo linguaggio
importante, quello della musica, quello che da Riga mi ha catapultata fin qua,
sulle arie di Enescu, di Ravel, di Brahms. Quel linguaggio che da bambina mi ha
affascinata così tanto da obbligarmi a vendere i pattini da ghiaccio per tre
lezioni di solfeggio in più; quel mondo che poi, da adolescente, mi ha permesso
di ricomprarli, quei pattini, con i guadagni dei concerti al Teatro dell’Opera
Lettone.
Ho quarant’anni e quattro figli, rimasti a Jourmala con
i nonni. Ora sono parcheggiata qui, “mamma-musicista-sognatrice utopica”. Una
bellissima donna, mi dicono. Un enigma impossibile, ribatto io. Mi manca il
Golfo di Riga, con quella sua macchia scura centrale a forma di cuore: quanta
vita ho dedicato ad ammirare quel piccolo isolotto, Ruhnu, immaginando le sue
spiagge deserte, il gusto del freddo e di una skābputra3
fumante, sorseggiata in silenzio. Quel silenzio. Brīnums4,
mi veniva da pensare, era un miracolo. Seguivo il volo delle cicogne e cercavo
le ali degli angeli tra le nuvole. Non avrei mai creduto di avere il coraggio
di abbandonare tutto.
Italia per me significa amore, rinascita, speranza. Ma
significa anche abbandono, rischio. Fallimento. Il mio ego musicista ha trovato
l’Eden: uno spazio per esprimersi, per mettersi in gioco, per farsi adulare e
applaudire. Una parte del mio cuore è riuscita a scorgere un nido, ad
assaporae il tepore, a desiderae la protezione come una droga; cosa rimane
invece della Inese mamma? Cosa rimane di quella donna dolce e premurosa, quella
che il sabato preparava gli sklandu rauši5
per i suoi bambini? Mi sento svuotata. Svuotata come una cartuccia di
inchiostro rosso appena finita, in cui il colore ha lasciato traccia di sé;
presto però non ne rimarrà che l’involucro, uno sterile pezzo di plastica.
Capricciosa ed egoista. Questo è il mio pensiero mentre l’insegnante mi scruta,
sono stata egoista.
Non riesco a spostare lo sguardo: la massa di riccioli
fulvi che cadono a grappoli sulle spalle della ragazza seduta davanti a me, mi
cattura, mi penetra negli occhi. Quella ribellione di forma e colore mi ricorda
una sonata di Hindemith, note intrecciate in tempesta, da districare con il mio
archetto con movimenti secchi, il gomito alto e lo sguardo fiero. La ragazza
parla di sé in un italiano piuttosto incomprensibile, ma l’espressività dei
suoi occhi mi basta per capire che in lei c’è trasparenza, c’è bontà, c’è un
animo ancora innocente. Ora tocca a me, devo presentarmi e non c’è un direttore
d’orchestra a indicarmi il tempo da seguire.
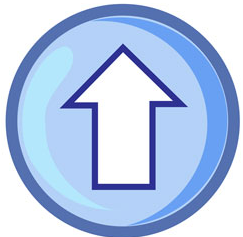 Luciana
LucianaIl chiarore lunare
emanato dal volto della mia vicina di banco mi fa male agli occhi. Perché è così timida? Perché ha detto solo tre
parole, perché tocca già a me? Che cosa posso dire io, ora? Questa Inese ha
raccontato che è una musicista, che suona la viola all’Opera, che è madre… E
io? Sarò concisa, sarò sincera. Questo corso di Italiano io lo devo fare. Sono
obbligata a venire a scuola tre volte alla settimana, dopo o prima del tuo.
Se voglio tenermi stretto il lavoro all’ospedale devo imparare a parlare questa
lingua. Me l’ha detto tante volte la Signora Mirella: «Luciana, ieri ti ho
detto di andare nel reparto F, non di pulire gli uffici del terzo piano! Se
continui a non capire ciò che ti dico, ti dovrò sostituire». E allora
impariamolo questo italiano, questa musica in «a» e in «e», queste parole
lunghissime e queste frasi romanzate. Lo so, non mi sono mai sforzata, cercavo
di capire con gli occhi, di cogliere tra le sfumature degli sguardi ciò che la
gente aveva intenzione di dirmi. Sul lavoro però non ha mai funzionato, bisogna
essere veloci, nessuno ripete, nessuno scandisce lentamente la frase «I bagni
del reparto ortopedia sono ancora da pulire», oppure «La mensa è un inferno,
corri a sistemarla». Un inferno, chiamare la mensa un inferno… Questa è
bella… Trenta milioni di poveri in Colombia, l’ho letto lunedì su El
Espectator. Io sono stata obbligata a partire. Li ricordo bene quei giorni:
all’improvviso tutto è diventato insustancial, impalpable6. Era come correre dietro ad un sasso lanciato con rabbia nel
Caquetà. E io correvo, correvo, sapevo di doverlo prendere ma come in un incubo
i miei piedi erano pesanti, ancorati al rosso stridente della mia terra; il
fiume non rallentava la sua corsa, anzi, scorreva sempre più rapido e pareva
ridesse mentre i miei occhi tentavano di penetrae le acque, cercando quel
sassolino tra una miriade di altri sassolini. Impossibile. Serviva un milagro7.
Un giorno poi un aereo è decollato e atterrato. Per tre
volte. Italia, freddo, ciao Orinoco, ciao Antioquia. Vagavo tra i ricordi, mi
perdevo tra gli scai rimasugli del mio io, mi sforzavo di sentire nella bocca
il sapore salato della pelle di mia madre, volevo toccarla, volevo pizzicarla,
fingevo di farmi trasportare dagli alisei oltre al Maracaibo. Ma no, nulla, di
fronte a me. Solo grigio, fumo, macchine, grigio, freddo, fumo. E ancora
grigio, e ancora fumo.
Sono passati tre anni e adesso, in questa classe,
circondata da altre donne che hanno sensazioni comuni alle mie, sento di voler
essere felice mentre tento di presentarmi. «Ciao a tutte, sono Luciana e sono
colombiana. Sono arrivata da Bogotà tre anni fa e il mio sogno più grande è
quello di entrare ancora una volta nel santuario di Las Lajas per mano a mia
madre, durante la processione del Corpus Cristi. Per me Italia significa
ossigeno, dopo una lunga apnea. Un po’ come gustare una fetta di lechona8
sorseggiando un tinto9 bollente».
Teste che si voltano verso di me, mi sento studiata e
provo disagio, ma in un attimo tutto cambia e tutto l’universo femminile
racchiuso qui mi dà pace, mi dà conforto, mi aiuta a liberarmi dal fantasma del
fiume che scorre veloce, dalla mia corsa senza fiato, dal muro nero che mi
aspetta sempre alla fine di quella pazza corsa. I miei occhi vagano nella
classe, tra capelli ispidi e treccine, tra niqab e dashiki, tra maglie di
cachemir e unghie laccate di rosso; mi blocco sulle braccia muscolose di
Judith, una donna namibiana che trasmette energia, le cui vibrazioni positive
giungono fino a me e mi pervadono di quella magia che solo l’armonia può
creare. Il muro nero diventa luce, la luce diventa sentimento, il sentimento
diventa azione. E l’azione mi rende donna, tra altre donne, in corsa per mano
alla vita.
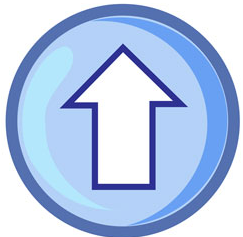 Kim ovvero Suor
Kim ovvero Suor
Marie-Agnes
Forse
ho sbagliato a venire. Ma no, no! Non devo demoralizzarmi così. Ho imparato
tante cose nella vita senza perdermi d’animo, imparerò anche l’italiano. Ma è
così difficile, sarà un’impresa ardua. Suor Zyma mi ha avvisata, «Vedrai,
all’inizio ti sembrerà impossibile riuscire a capire qualcosa, figurati
parlare!», non si sbagliava. Non c’è nulla che accomuni il coreano
all’italiano, nulla, non un suono, non una parola, non un gesto. Una cantilena,
ecco cosa mi ricorda sentire parlare questi italiani, una di quelle cantilene
che le nonne sussurrano ai nipoti per farli addormentare, sugli argini del
fiume Han. Analizzo chi mi sta di fronte, chi mi sta accanto, chi mi sorride
mentre io faccio finta di comprendere ciò che sta avvenendo qui, intorno a me,
elargendo sorrisi compiaciuti a tutti. A tuo le mie compagne di classe parlano,
chi sorridendo, chi arrossendo, chi con uno sguardo severo. La donna che ha
parlato per ultima ha dei lunghi capelli lucenti, scuri come il sesamo nero che
noi coreani mettiamo un po’ dappertutto. Gli occhi di questa giovane donna
sorridevano, poi si sono riempiti di nero per intenerirsi di nuovo dopo un
breve istante. Chissà cos’ha raccontato, vedevo la sua mente vagare tra i
ricordi, le sue mani accartocciarsi una sull’altra, le sue dita fremere; ho
letto la sua storia attraverso quelle unghie rosicchiate, come in segreto. Ora
però tutti gli occhi sono puntati verso di me, l’insegnante mi sorride, mi
chiama per nome e con la mano fa un gesto che interpreto come: «Tocca a te, Kim».
E allora io raddrizzo le spalle, mi accomodo meglio sulla sedia, mi schiarisco
la voce, faccio finta di non capire che tocca proprio a me e guardo la mia
vicina di banco con sguardo interrogativo. Lei con un’occhiata mi rimanda
all’insegnante e allora decido di dire le tre parole che so, quelle che ho
voluto conoscere subito, appena arrivata a Milano, dopo un volo di diciotto ore
proveniente da Seoul. «Io sono Marie-Agnes, suora missionaria, perché Dio è
amore». Sorridono tutte, come inebriate dalla mia rivelazione, come se un
anelito della mia devozione le avesse avvolte in un abbraccio caldo, come se il
nome del nostro Dio fosse solo Amore, carità, fratellanza. Mi scrutano,
impazienti che il mio racconto si gonfi di particolari ma «Non so italiano»,
bisbiglio. Nasce forte in me il desiderio di raccontarmi, di aprirmi a loro; il
potere del sorriso delle mie nuove amiche riesce ad allontanarmi dall’odore
della violenza che la mia Terra ha subito, il ricordo di tutti quei poveri e
della loro corsa verso il buio, nelle braccia putrefatte della segregazione.
Qui c’è dolcezza, c’è un nido per un piccolo che sta per emettere il suo primo
vagito, c’è forza, c’è coraggio. Vorrei raccontare a tutte loro che anch’io un
giorno sono stata coraggiosa e ho voluto inseguire Gesù, fino in fondo. Fino a
Cuneo. Proprio qui, dove il Movimento Contemplativo Missionario ha accettato la
mia richiesta di permanenza, dove i miei sessanta anni non hanno spaventato
nessuno, dove la mia esperienza è necessaria e il mio aiuto importante. Qui,
dove sto dimenticando il sapore del Kimchi e mi sto arricchendo di nuove
sensazioni, qui dove nessuno vende bachi da seta ai lati delle strade e dove le
formiche rosse sono un pericolo, non un sollievo per il mal di stomaco, qui
dove i fiori non si mangiano ma si mettono nei vasi. Qui, uno spazio nuovo,
colorato, dove l’insegnante mi guarda e con un gesto accarezza tutte noi. E io
dico: «Qui è gijeok10, qui è miracolo».
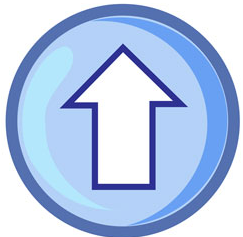 Malaika
Malaika
Mi guardo le mani, le
mie mani callose, ora umide, ora gelide. Stringo tra le dita una penna nuova di zecca e aspetto il mio tuo, qui, in
quest’angolo di pace. Mi sembra che i miei polmoni necessitino di più ossigeno,
adesso che Malik sta per affacciarsi sul mondo. Oggi scalcia più del solito e
nemmeno la radice di zenzero mi aiuta a calmarlo. Poso la penna, dopo aver
scritto «Scuola-Italiano» sulla prima pagina di questo quaderno sgangherato. Mi
piace proprio essere dove sono, anche se le mie mani non hanno fermezza; le
guardo e penso a tutti gli anni in cui mi hanno seguita, in cui hanno raccolto
fagioli, bacche di caffè, hanno pulito pesci, aragoste, hanno lavato conchiglie
e coralli, hanno asciugato lacrime e hanno stretto altre mani con passione.
Il corallo, che incanto il corallo. Mi porto le dita al
naso ma non è rimasto nulla di quell’odore di sale, di schiuma, di mare. Sogno
spesso di essere ancora sulla barchetta di legno di John: il silenzio navigava
con noi, seduto sulla cassa dipinta di giallo, rispettato come un ospite atteso
da tempo. Quando raggiungevamo il luogo scelto iniziavamo a canticchiare e
andavamo avanti per ore, finché il buio non ci intimava di tornare a riva.
Mio figlio invece non crescerà con il mare
all’orizzonte, mio figlio nascerà in questa città piena di luci e di rumori,
piena di macchine che corrono, piena di persone che si svegliano in un luogo
chiuso per recarsi in un altro luogo, ancora più chiuso. Proprio questo mi
manca: lo spazio aperto che mi riempiva gli occhi e più guardavo il cielo e più
forte respiravo, tanto da sentire nei polmoni, nelle ossa, in ogni mia vena,
tutto quell’universo che brillava intorno a me. Non c’era un momento della
giornata che preferivo per avvicinarmi al mare e guardare lontano: l’alba era
magica, con quella luce chiara e splendente, il mattino si accompagnava con i
canti degli uccelli che volavano paralleli al mare. A mezzogiorno poi, il
colore del cielo era così intenso che tutto pareva diventare blu; era magnifico
stare seduti sulla sabbia, con le mie sorelle e i miei fratelli, tenendo fra le
ginocchia una ciotola di kacthupa. Al tramonto il blu diventava arancio
e il mare era così calmo che sembrava una coperta soffice, sulla quale era
facile immaginare di rotolare, facendosi avvolgere da quel colore bollente, era
un milagre11 essere al mondo. Rotolavamo, rotolavamo, e i nostri
capelli ci coprivano il viso, non riuscivamo più a vedere il cielo, ma
guardavamo giù, nel mare, vedevamo i pesci, imitavamo i loro movimenti, li
seguivamo e cercavamo di prenderli. Poi ci svegliavamo da questo stato di sonno
immaginario e tornavamo a casa.
Quando qui mi chiedono da dove provengo e io rispondo
Cabo Verde, tutti mi sorridono, adottando quell’espressione di chi sogna di
vedere quei luoghi, prima o poi.
Ho salutato casa mia, un giorno. Era buio, c’era anche
il vento. Il vento, già… È stato come se volesse portarci via ancora più in
fretta. Ci spingeva, ci incoraggiava, ci sussurrava piano che avremmo visto
luoghi migliori, tempi migliori. Mi sforzo per rivivere quelle mie ultime ore
da «capoverdiana-che-vive- nella-sua-terra». Avrei voluto riempirmi la bocca
del sapore delle banane fresche, avrei voluto trattenere sulla pelle il profumo
del mio sole e qualche granello di sabbia tra le dita dei piedi. Sono in Italia
da ormai otto anni e ancora oggi, prima di entrare in casa, mi tolgo le scarpe,
le scrollo sul pavimento desiderosa di veder scendere un piccolo granello di
sabbia luccicante.
Il mio registro non
si chiude, le parole delle mie alunne lo tengono sempre aperto, dando voce a
quell’infinito di emozioni, ricordi, desideri e obiettivi che le rendono vive.
Grazie a Olivia, Inese, Luciana, Kim, Malaika, ma anche a Kristine, Rosa,
Danielle, Aisha, Sandy, Judith, Spresa, Rukya, Vera, Marina… Donne capaci di
piccoli, grandi miracoli.
____________________
(*) Federica Ramella Bon, Spazio Arcobaleno,
pubblicato su Lingua Madre Duemilatredici – Racconti di donne straniere in
Italia, Edizioni Seb27.
Il racconto di Federica Ramella Bon ha vinto il Premio Sezione Speciale
Donne Italiane del VIII Concorso letterario nazionale Lingua Madre,
2013.
FEDERICA RAMELLA-BON nasce a Cuneo nel 1979. Docente di lingue straniere presso le
scuole secondarie di primo e di secondo grado; per alcuni anni ha insegnato in
diversi Ctp (Centri territoriali permanenti) della provincia, venendo così a
contatto con aspetti della multiculturalità che – dice – non conosceva e che
l’hanno appassionata. Da sempre ama scrivere e raccontare, le piace la
letteratura, l’arte e la psicologia sociale, soprattutto quella legata ai
fenomeni migratori. Compone poesie per la rivista letteraria online «Peripheral
Surveys».
Note
1 «It’s a miracle»: è un miracolo.
2 Troubles: è il nome con cui si indica la
cosiddetta «guerra a bassa intensità» che si è svolta tra la fine degli anni
‘60 e la fine degli anni ‘90 in Irlanda del Nord.
3 Skābputra: zuppa di orzo acido.
4 Brīnums: miracolo.
5 Sklandu rauši: tortini a base di patate.
6 Insustancial, impalpable: inconsistente,
impalpabile (lasciato volutamente in lingua originale).
7 Milagro: miracolo.
8 Lechona: piatto tipico colombiano a base di
carne di maiale.
9 Tinto: caffè.
10 Gijeok: 기적, miracolo.
11 Milagre: miracolo.
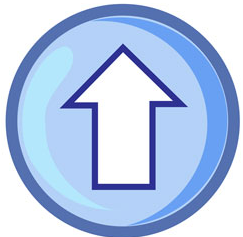
 Panini verdi
Panini verdiChou Mei Chen Susanna [Cina](*)
La
signora Qin era entusiasta, aveva appena sentito per telefono suo fratello
minore, che quel giorno era diventato nonno; stava raccontando del lieto evento
a sua figlia maggiore, Anna Lin, sperando di darle una spinta affinché anche
lei si decidesse a sposarsi e darle un nipotino. Anna Lin sapeva come si
sarebbe svolto il dialogo e, con rassegnazione, ascoltava la madre, fissando le
statuine rappresentanti dame dell’antica Cina, intente a suonare una il pi’pa,
l’altra il guzheng, una terza lo er-hu1,
e l’altra il flauto traverso, circondate da alberi con foglie di giada e fiori
di agata dai diversi colori, poste sui ripiani nella parete verde acqua di
fronte al divano blu sul quale era seduta.
– Sai, il tuo cuginetto Roby ha avuto una figlia, l’hanno chiamata Kate!
– Kate?!? –, le aveva risposto Anna Lin con
un’espressione divertita, pensando a quanto fossero oramai altri tempi quei
lontani Anni ‘80, quando i cinesi che venivano in Italia, per facilitare la
comunicazione nei diversi ambiti di scambio quotidiano, che fosse scuola o
lavoro, sceglievano anche dei nomi italiani per sé e per i loro figli: Paolo,
Maria, Michele, Sara, Giovanni, Lucia.
– Effetti della globalizzazione –, riprese Anna Lin.
– Cosa vuol dire globa… – le aveva chiesto la Signora
Qin, sapendo che non poteva trattarsi di nulla di troppo positivo, visto il
tono snob con cui l’aveva detto sua figlia.
– In cinese è 全球化,
quanqiuhua. Quando dei gusti diventano uguali per tutti –, le aveva
risposto un po’ superficialmente sua figlia, preoccupandosi più che altro di
arrivare al nocciolo della questione e poco di approfondire il significato del
termine «globalizzazione».
– Beh, almeno lui si è sposato prima di te ed è già
diventato papà. Tuo cuginetto Roby ha solo 21 anni, tu invece, che ne hai 32,
ancora niente.
Ed eccola – stava pensando Anna Lin – che riparte con la
solita tiritera: e quando ti sposi? Oramai sei vecchia, guarda che più aspetti
più potresti avere dei problemi ad avere figli, potrebbero essere deboli,
oppure potresti non avee proprio, mica rimani giovane per sempre! Un getto
continuo di parole, tante parole.
– Come sarebbe bello se diventassi nonna anch’io; sono
la sorella maggiore e sarò l’ultima a diventarlo, se mai lo diventerò! Eppure,
Anna Lin, non sei brutta, insomma, c’è di peggio.
– Grazie mamma.
– Com’è possibile che non riesci a trovare nessuno?
Anna Lin sapeva che la madre una volta presa quella
strada non l’avrebbe lasciata tanto facilmente, le prossime frasi sarebbero
state sui suoi fallimenti in tutti i settori: non sei sposata, non hai figli,
ma non hai nemmeno un lavoro fisso.
– Nonostante tutti questi anni passati a studiare per
laurearti, non hai trovato un lavoro decente.
«Come Volevasi Dimostrare», adesso partirà con l’elenco
dei figli delle sue amiche o parenti lontanissimi, che hanno tutti dei lavori
bellissimi, super pagati, in giro per il mondo, e tutto questo senza essere
laureati!
– La mia amica Alian mi ha detto che sua figlia ha
trovato lavoro per una banca, è sempre in trasferta, a te piace viaggiare no? E
la pagano bene.
– Sì sì mamma, immagino. Come la figlia dell’amica della
mamma di Lisa, che poi si è scoperto avere un contratto di apprendistato.
Adesso
l’hanno lasciata a casa, vero? Al suo posto non hanno preso una neo-laureata,
che non sa nemmeno leggere una fattura, che sia in italiano o in cinese?
Anna Lin doveva sempre controbattere, questo lo sapeva
bene la Signora Qin, con sua figlia non era facile.
– Accompagnami a Porta Palazzo2,
devi aiutarmi a fare la spesa.
– Va bene –, rispose Anna Lin, pensando che sua madre
fosse molto abile a cambiare argomento e che per il momento l’assalto era
rimandato, almeno fino al prossimo invito per matrimonio o nascita di bebè.
Quand’era piccola, Anna Lin andava tutti i giorni al
mercato di Porta Palazzo con sua nonna Elena. Gli amici cinesi di famiglia
quando la vedevano le dicevano che era il sacchettino profumato della nonna, un
modo poetico per dirle che le era sempre attaccata.
Con
la nonna avevano dei giri di commissioni quotidiane: panettiere, lattaio, «campagnini»
(così li chiamava la nonna) che avevano una loro sezione del mercato, dietro la
tettornia dell’orologio, con le bancarelle di prodotti che negli ultimi anni
venivano definiti a chilometro zero. La nonna Elena passeggiava tra le
bancarelle sorridente, chiacchierava coi commercianti, che fossero cinesi o
italiani, pugliesi o piemontesi, la sua gentilezza era un linguaggio
universale. Anche la Signora Qin accompagnava spesso la suocera a fare la
spesa; quando, all’inizio degli Anni ‘80, appena arrivata, ancora non sapeva
una parola di italiano e si sentiva così lontana dalla sua terra, il mercato le
ricordava un po’ casa; aveva imparato a mangiare nuovi cibi, come i formaggi,
il sugo di pomodoro, il gelato; o a sentire come i sapori di prodotti comuni
anche con la Cina fossero comunque diversi. Ma non aveva rinunciato a portare
nella nuova casa alcune tradizioni culinarie del suo paese.
Negli ultimi anni al mercato di Porta Palazzo riusciva a
trovare quasi tutto, perché avevano aperto molti negozi di alimentari cinesi e
dai «campagnini» c’erano bancarelle di frutta e verdura orientali coltivati da
contadini cinesi nelle terre del torinese.
– Cosa dobbiamo comprare? –, chiese Anna Lin, più per
spezzare il silenzio tra lei e la madre che per reale desiderio di sapere,
mentre camminavano nel viale alberato dove le fermate dei mezzi pubblici erano
affollate da quei volti della multiculturalità che a lei piacevano tanto, perché
così non si sentiva più una dei pochi a essere straniera. Perché pur essendo
nata in Italia, pur avendo una parte genetica anche italiana, pur avendo più
amici italiani che cinesi, agli occhi dei più era sempre una straniera. Quando
parlava la gente le diceva stupita: «Ma come parli bene italiano!», nello
stesso modo in cui in Francia le facevano i complimenti per come parlasse bene
il francese, in Germania il tedesco o in Inghilterra l’inglese. Peccato che lei
fosse italiana, non solo ma anche.
– Un po’ di cose per fare i panini verdi –, le rispose
la signora Qin.
– Entriamo prima qui –, disse la signora Qin alla
figlia, davanti all’ingresso del primo negozio cinese della via, le cui vetrine
erano ricoperte di annunci colorati, scritti coi caratteri cinesi: parrucchiere
in via YZ, si vendono schede telefoniche scontate, prenotazione biglietti aerei
per Shanghai/Beijing (Pechino)/Wenzhou, signora 50enne cerca lavoro come
baby-sitter, e altri.
La signora Qin analizzava i prodotti esposti sugli
scaffali: la farina di riso lì costava circa venti centesimi in più rispetto al
negozio accanto; però c’era il preparato per barbecue di quella marca
che gli altri negozi non avevano, quindi ne prese due bustine.
– Ah Signora Qin! Come stai? – disse avvicinandosi una
signora magra, dalle gote arse dal sole, come solo chi lavora all’aperto sotto
il sole può avere.
– Ah buongiorno Yujing! Come stai? –, le rispose la
Signora Qin.
– Bene. Stai facendo la spesa? Cosa compri?
– Alcune cose per la festa Qing Ming3.
– Tu fai dei panini verdi buonissimi! A me non vengono
così bene, il ripieno è meno saporito e il colore dell’impasto mi viene
pallido.
– Devi usare gli spinaci, danno un colore più acceso.
Nel ripieno metti del bambù, dei funghi secchi e anche dei fagiolini secchi se
li hai. I tuoi figli stanno bene? La maggiore sta per partorire vero?
– Sì, le voglio cucinare degli spaghettini col vino di
riso.
– Mamma –, la interruppe Anna Lin. La signora Qin ignorò
sua figlia. In realtà non lo faceva di proposito, in famiglia glielo facevano
sempre notare, che quando parlava con qualcuno in cinese, o guardava la tv
cinese (che fosse film, o concerto, o telegiornale) non era «impostata» nella
modalità «lingua italiana».
– Mammmma! Vanno bene questi bambù? – le chiese Anna Lin
mostrandole un barattolo dall’etichetta verde con l’immagine di germogli di
bambù gialli.
– No, quelli sono tagliati a fette. Prendi il barattolo
con l’etichetta bianca, quelli sono interi.
– Chi è quella ragazza, signora Qin? –, chiese curiosa
Yujing.
– Mia figlia maggiore.
– Oh, non ti assomiglia per niente. In realtà non sembra
nemmeno cinese… È sposata?
– No e non ci pensa proprio.
– Se vuoi ti presento il figlio di Miyan, ha quasi la
sua età, anche lui non è ancora sposato, sta studiando medicina; forse è del
segno del bue4, va bene con tua figlia no?
– Mia figlia non vuole queste cose combinate… Adesso
devo andare a finire la spesa. Ci vediamo Yujing.
Tra
uno scaffale e l’altro dei tre negozi cinesi e tra una chiacchierata con un
conoscente e l’altro, madre e figlia avevano comprato tre pacchetti di farina
di riso, uno di funghi secchi, due confezioni di pasta di riso, due di
preparato per salsa barbecue, uno di pasta di farina di patate dolci, un
barattolo di germogli di bambù (di cui Anna Lin si lamentava per il peso) e una
bottiglia formato famiglia di salsa agro-piccante.
Dai «campagnini» invece, aveva comprato due chili di
cime di rape, le melanzane lunghe e i cavoletti cinesi.
– Per pranzo fai il riso con le cime di rapa, mamma?
– Se vuoi. Dopo pranzo però tu e tua sorella mi dovete
aiutare a fare i panini verdi.
Anna Lin sapeva che sua madre in realtà non aveva
bisogno del loro aiuto, che se la cavava benissimo anche da sola; lo faceva per
insegnare alle figlie come prepararli.
Stava riflettendo che, in effetti,
avrebbe dovuto imparare a cucinare alcuni determinati piatti, almeno per
mantenere le tradizioni. Sarebbe mai riuscita a cucinare da sola i panini
verdi? O a preparare il vino di riso? O dei semplici panini bianchi al vapore?
Tutte le tradizioni della cultura di sua madre, e quindi anche della sua,
sarebbero andate perse. Come avrebbe cresciuto i suoi figli? Ma forse il punto
era davvero un altro, quello su cui sua madre insisteva tanto: avrebbe mai
avuto dei figli?
Dopo
pranzo, mentre nella cucina di casa disponeva sul tavolo in file composte i
panini verdi, Anna Lin notò la loro irregolarità: quelli di sua madre erano
tutti della stessa dimensione, i suoi no: qualcuno era più pieno, qualcuno
sgonfio, qualcuno più tondo; e fu colta da un angosciante senso di vuoto, la
consapevolezza che le mancava qualcosa, non sapeva definire di preciso cosa, ma
sentiva di non aver più tempo, di doversi affrettare per imparare, per
recuperare, per ottenere ciò che non aveva.
___________________
(*) Chou Mei Chen Susanna, Panini verdi,
pubblicato nell’antologia Lingua Madre Duemilatredici – Racconti di donne
straniere in Italia, Edizioni Seb27.
MEI CHEN SUSANNA CHOU nasce il 24 novembre 1976 a Che-Kiang (Repubblica Popolare
Cinese). Laureata in Lingue e Letterature Straniere (cinese e tedesco) presso
l’Università di Torino, dopo varie esperienze in ambito turistico-commerciale,
inizia a lavorare, in Germania, nel settore dell’organizzazione culturale,
proseguendo poi la sua attività in Italia. Ha organizzato festival musicali in
Piemonte, con particolare riguardo verso le sonorità inteazionali.
Parallelamente all’attività culturale (www.asiae.org) collabora con diverse
associazioni, occupandosi anche di traduzione.
Note
1 Strumenti a corde della tradizione cinese.
2 Porta Palazzo: il più grande mercato di Torino.
3 La Festa Qing Ming (清明节, Qing
Ming Jie) è la festa cinese della pulizia delle tombe, che ricorre generalmente
nel mese di Aprile del calendario gregoriano.
4 Uno dei dodici segni dello zodiaco cinese,
suddiviso per anni e non per mesi.
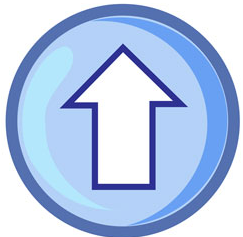
 Con gli occhi di Keréne
Con gli occhi di KeréneMaria Enrica Sanna e Keréne Fuamba [Italia e Congo](*)
Il
volo era durato appena venti minuti, Pantelleria vista dall’alto aveva la forma
di un rene umano, ma la cosa più inquietante è che appariva piccolissima: non
avrei mai creduto che il pilota, dopo averci miracolato evitando con cura i
cocuzzoli delle montagne limitrofe, sarebbe anche riuscito a centrare quella
pista così piccola da ricordare le portaerei in uso durante la Seconda guerra
mondiale!
Non sapevo dove andare, ma non mi preoccupavo più di
tanto: mi avevano detto che per giungere alla scuola del paese, sarebbe stato
sufficiente chiedere un passaggio ad uno di quei panteschi molto
disponibili che passano casualmente dalle parti dell’aeroporto proprio all’ora
degli arrivi, e che per soli cinque o dieci euro ti fanno il «favore» di
accompagnarti in macchina, persino davanti alla scuola.
In effetti, in 5 minuti ero già arrivata. Dopo le
pratiche di segreteria e le presentazioni col personale della scuola e con il
preside, al suono della campanella finalmente era giunto il momento di entrare
in classe.
Per rompere il ghiaccio cominciai a presentarmi
scrivendo il mio nome sulla lavagna e parlando un po’ di me. Ero riuscita ad
attirare la loro attenzione, adesso toccava a loro presentarsi. Mentre i più
audaci facevano a gomitate nel contendersi la parola, non poté passare
inosservata, seduta al primo banco della fila centrale, una ragazza dagli occhi
grandi e scuri: era magrolina, ben vestita, e sembrava molto riservata.
La presentazione della classe procedeva rapida e
ordinata: tutti volevano fare bella figura!
Dulcis in fundo
toccò a Keréne, la ragazza al primo banco, che timidamente sorrise e dopo un
paio di tentativi, lodevoli ma buffi, rinunciò alla sua impresa.
I compagni mi spiegarono che non parlava bene l’italiano
perché era arrivata in Italia da pochi mesi.
La mattina seguente, misi sul banco di Keréne il
dizionario di francese. Avevo un’intera classe da seguire e non avrei potuto
dedicare troppo tempo a lei, che comunque sembrava aver gradito la novità.
Per sondare la classe e le eventuali lacune
grammaticali, decisi di assegnare un tema.
Volendo dare a tutti la possibilità di scrivere senza
problemi, scelsi un titolo aperto:
«Una giornata indimenticabile…»
Keréne, si tuffò sul dizionario e per due lunghe ore non
staccò mai gli occhi dal foglio. Tutti si fermarono per la ricreazione, ma lei,
caparbia, continuò a scrivere. Quella che per tutti gli altri era la lingua
madre per lei era un ostacolo da dover aggirare!
A fine giornata, dopo aver ritirato tutti gli elaborati,
mi avviai verso casa.
Tra un panino e un caffè, cominciai la correzione dei
temi della III B.
In quei fogli c’era di tutto: da Disneyland alle
Piramidi, dal primo bacio alla Play-Station II.
Ma ad un tratto il registro cambiò: il tema di Keréne si
presentava con una grafia pulita ed ordinata…
«Sono
nata in Congo, giunta a Pantelleria per caso: ho una sorella poco più grande di
me e tre fratellini piccoli e vivaci. Mia mamma è sempre riuscita a far fronte
a tutte le esigenze familiari: è una donna in gamba e non si è tirata indietro
quando papà le ha proposto di spostarsi più a Nord nella speranza di garantire
a noi un futuro migliore. Mio papà è un insegnante di francese ed ha deciso di
raggiungere la Libia per migliorare le aspettative di vita dell’intera
famiglia: lì ci sono scuole che meglio retribuiscono i loro docenti. Così
decidiamo di partire, il viaggio è lungo ma ne vale la pena. Giunti lì ci
inseriamo molto bene: siamo una famiglia numerosa, benestante e felice. Tutto
sembra aver preso una giusta piega ma nell’aria c’è un nuovo fermento di libertà:
sta per iniziare la “primavera araba”, che per noi è semplicemente un’altra
guerra. Dopo giorni di terrore sotto i bombardamenti, papà decide di partire
per l’Italia, trovando posto su uno di quei famigerati barconi che solcano
copiosi il Mediterraneo. Siamo in sette e quindi paghiamo una somma ingente,
ma, a differenza di tanti altri disperati, papà ha i soldi per acquistare i
biglietti. Nel cuore della notte, nascondendoci dalla sorveglianza militare
armata, riusciamo ad imbarcarci e, tra lo schianto delle bombe ed altre mille
paure, a prendere il largo.
Il mare sembra agevolare la nostra fuga, il vento è buono.
Oggi è mercoledì 13 aprile 2011, sono le 5:00.
Il sole non è ancora sorto, attorno c’è buio fitto, dopo
cinque giorni di navigazione qualcuno dice che siamo vicini ad uno scoglio: no,
non è uno scoglio, è Pantelleria.
Il mare è agitatissimo e ci fa sbattere l’uno contro
l’altro; il barcone, carico di 192 persone, sembra impazzito, sbattuto da onde
minacciose che ci sommergono da tutti i lati.
Il barcone è sempre più vicino agli scogli, l’impatto è
orrendo e devastante, ho il cuore in gola, per davvero lo sento palpitare
proprio lì: e pensare che fino a quel momento avevo sempre creduto che quello
fosse soltanto un modo di dire!
Uno squarcio sulla fiancata dell’imbarcazione. La paura è
grande e, sperando che sia tutto finito, accenno una preghiera di ringraziamento:
«Dio mio, spero che questo non si ripeta mai più nella mia vita…», ma non
immagino minimamente quello che ancora mi aspetta.
Improvvisamente siamo catapultati letteralmente in mare:
i più fortunati rimangono attaccati al barcone, altri sono ormai in balìa delle
onde… E molti di noi non sanno nuotare.
Solo grazie all’aiuto della guardia costiera e dei
volontari che si prodigano tirandoci fuori dall’acqua, io, i miei fratelli, mia
sorella e mio padre ce la caviamo.
La mia mamma purtroppo no! Lei non ce la fa… Non sa
nuotare e le onde non le lasciano scampo. Forse, se avessi saputo nuotare,
l’avrei potuta salvare io. Il dolore, lo sconforto, sono grandissimi. L’inferno
non può essere peggio di questo, ed io ci sono stata!
Nel frattempo perdo i sensi, vengo salvata a fatica: ho
promesso alla mamma che saremmo rimasti tutti uniti e che mi sarei occupata dei
bambini.
Ci ricoverano per alcuni giorni in ospedale; gli
abitanti della piccola isola non ci fanno mancare nulla; i medici, appena
possibile, ci portano in obitorio per salutare per l’ultima volta la mamma. I
nostri cuori sono straziati dal dolore, sono ferite difficili da rimarginare,
ti segnano la vita, anzi te ne tolgono anche un po’.
La mia mamma, la mia giovane e bellissima mamma… Non la
rivedrò mai più.
Devo però aiutare i miei fratellini che forse soffrono
più di me.
Al funerale ci sono tante persone, i militari, il
sindaco e tutti i superstiti alla sciagura.
Appena dimessi dall’ospedale, una famiglia ci ospita
nella propria abitazione: stiamo bene con Giuseppina e Mariano, ci trattano
come figli, non dimenticherò mai la loro accoglienza.
Nel mese di maggio andiamo a Trapani per ricevere i
documenti necessari alla nostra permanenza a Pantelleria. Al nostro ritorno da
Trapani ci sistemiamo in una casa che papà ha preso in affitto.
Io e mia sorella Aicha, anche se di diverse età, ci
iscriviamo a scuola: purtroppo ci inseriscono in terza media perché non abbiamo
con noi alcuna attestazione scolastica; i miei fratellini Vianì e Raìs alla
scuola elementare, ed il piccolo Eest all’asilo.
Col passare dei giorni conosciamo tanti ragazzi e
ragazze. I primi momenti a scuola sono difficili, non riusciamo a comunicare
con gli altri e ho tante difficoltà anche nel relazionarmi con i professori.
Mi piacerebbe un giorno continuare i miei studi
frequentando l’università, vorrei studiare per poter realizzare il mio sogno
che è quello di diventare una pediatra per aiutare i bambini a crescere e per
soccorrere coloro che hanno più bisogno. Un giorno toerò nella mia Africa per
dare una mano ai più bisognosi».
Avevo
letto quel tema tutto d’un fiato, asciugandomi di continuo gli occhi per
riuscire a decifrare le parole che si sfocavano dentro le mie lacrime.
Un senso di colpa mi assalì improvvisamente pensando
alla sofferenza che le avevo procurato assegnando la stesura di quel tema.
D’improvviso mi sembrò di vedere i suoi occhi limpidi,
trasparenti e pieni di luce.
Con il passare dei giorni, osservavo i progressi che
faceva la piccola Keréne: si impegnava moltissimo, stava mettendo a frutto la
sua intelligenza ma ancora di più la sua voglia di vivere.
Ogni giorno, tornando a casa, pensavo a lei e a come
avrei potuto aiutarla senza sembrare invadente. Non perché avesse bisogno
d’aiuto materiale, quello non le mancava, era ben voluta da tutti. Keréne aveva
bisogno d’amore, di un abbraccio, di una carezza, di una parola affettuosa. Lo
scorso giugno ha conseguito la licenza media col massimo dei voti.
Quest’estate è venuta a casa mia in vacanza: pur avendo
terrore del mare, ha desiderato fortemente che le insegnassi a nuotare…
Mi ha detto: «Prof, sogno ogni notte la mamma che mi
chiede aiuto e non riesco mai a tirarla fuori dall’acqua, scompare sempre tra
le onde… Ma se imparo a nuotare, un giorno riuscirò finalmente a salvarla».
L’ho abbracciata piangendo, ma lei scostandosi mi ha
stretto le mani e guardandomi intensamente, mi ha sorriso.
————————————
(*) Marika Sanna e
Keréne Fuamba, Con gli occhi di Keréne, pubblicato su Lingua Madre
Duemilatredici – Racconti di donne straniere in Italia, Edizioni SEB27. Il racconto di Marika Sanna e Keréne Fuamba è stato selezionato al VIII
Concorso letterario nazionale Lingua Madre, 2013.
KERÉNE FUAMBA nasce nel
1996, in Congo. Per sfuggire alla guerra civile la sua famiglia si trasferisce
in Libia, appena prima della «fioritura» della primavera araba. In fuga verso
l’Italia, nel 2011, naufraga sulle coste di Pantelleria, perdendo la mamma.
Comincia così a frequentare la scuola in Italia: nel 2012 consegue la Licenza
Media con il massimo dei voti. Frequenta attualmente con profitto il Liceo
delle Scienze Umane, collaborando attivamente con l’Associazione Teatro
Instabile di Sicilia nella difesa dei diritti e dell’impegno civile.
Nell’estate del 2012 ha presentato l’evento culturale «Teatro tra sole e sale»
e la performance teatrale La mafia uccide, il silenzio pure, ispirata
all’omicidio di Peppino Impastato. Vorrebbe presto realizzare il suo sogno,
diventare pediatra, per tornare in Congo e aiutare i bambini bisognosi della
sua terra.
MARIA ENRICA SANNA vive a Erice Casa Santa, in Sicilia. Laureata in Lettere e
specializzata in Tecniche innovative nella didattica, è una «docente precaria»,
che insegna nelle scuole medie e superiori. Da sempre impegnata nel sociale,
cornordina progetti di recupero rivolti a soggetti svantaggiati. Ha acquisito
qualifiche professionali nel campo teatrale e culturale. Attualmente si occupa
in modo particolare di formazione dei giovani e del loro impegno civico.
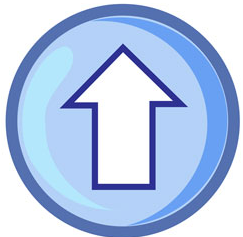 Lingua Madre
Lingua Madre Il concorso letterario nazionale Lingua Madre,
Il concorso letterario nazionale Lingua Madre,
ideato da Daniela Finocchi, giornalista da sempre interessata ai temi inerenti
il pensiero femminile, nasce nel 2005 e trova subito l’approvazione e il
sostegno della Regione Piemonte e del Salone Internazionale del Libro di
Torino.
Il concorso è il primo a essere espressamente
dedicato alle donne straniere – anche di seconda o terza generazione –
residenti in Italia che, utilizzando la nuova lingua d’arrivo (cioè
l’italiano), vogliono approfondire il rapporto fra identità, radici e mondo
«altro». Una sezione speciale è riservata alle donne italiane che vogliano
raccontare storie di donne straniere che hanno conosciuto, amato, incontrato e
che hanno saputo trasmettere loro «altre» identità.
Il concorso letterario vuole essere un’opportunità
per dar voce a chi abitualmente non ce l’ha, cioè gli stranieri, in particolare
le donne che nel dramma dell’emigrazione/immigrazione sono discriminate due
volte. Un’opportunità di incontro e confronto, perché il bando non solo ammette
ma incoraggia la collaborazione fra le donne straniere e italiane nel caso
l’uso della lingua italiana scritta presenti delle difficoltà.
(da www.concorsolinguamadre.it)
Pubblichiamo i racconti di queste pagine per
gentile concessione del «Concorso letterario nazionale Lingua Madre», a cui
vanno i nostri ringraziamenti più sinceri.
Chi volesse partecipare al concorso può inviare i
racconti e/o le fotografie a:
Concorso letterario nazionale Lingua Madre
Casella Postale 427
Via Alfieri, 10 – 10121 Torino Centro
Tags: donne, migranti, integrazione, accoglienza
Varie Autrici
 C’è stato
C’è stato
 Diario di un giovane da Isiro / 4
Diario di un giovane da Isiro / 4
 Un libro,
Un libro,
 Da Nyeri, Cronache
Da Nyeri, Cronache
 Nata nel 1997, Rádio
Nata nel 1997, Rádio
 1. Un paese diviso
1. Un paese diviso

 Volevo essere miss Italia
Volevo essere miss Italia Spazio arcobaleno
Spazio arcobaleno Panini verdi
Panini verdi Con gli occhi di Keréne
Con gli occhi di Keréne Il concorso letterario nazionale Lingua Madre,
Il concorso letterario nazionale Lingua Madre,