 Viaggio in Cile / 2
Viaggio in Cile / 2
Uccisioni, sparizioni, prigionia, tortura, persecuzioni. I
costi umani della dittatura del generale Pinochet sono stati molto alti. A Santiago abbiamo
visitato il «Museo della memoria e dei diritti umani». Un’opera con cui il Cile
ha voluto abbattere i muri della negazione e dell’occultamento. Per costruire
il proprio futuro senza dimenticare il passato.
Santiago
del Cile. La si nota appena dal metro si esce su Avenida Matucana. È una
costruzione color verde smeraldo a forma di parallelepipedo che sovrasta una
piazza ad anfiteatro, costruita sotto il livello stradale. La struttura del
«Museo de la memoria y los derechos humanos» è modea, ma anche sobria come si
conviene a un luogo che racchiude la memoria di 17 anni di dolore e sofferenza.
Inaugurato
l’11 gennaio del 2010, il Museo è infatti uno spazio destinato a dare visibilità
alle violazioni dei diritti umani commesse dallo stato cileno tra l’11
settembre 1973 e il 10 marzo 1990, durante il governo del generale Augusto
Pinochet.
L’entrata
è dalla piazza «interrata», Plaza de la memoria, che a sua volta ospita una
serie di grandi pannelli in cui si raccontano, con testi e immagini, le lotte
dei popoli latinoamericani contro le dittature. Dall’Argentina al Guatemala:
mai dimenticare che praticamente tutti i paesi del continente hanno conosciuto
regimi repressivi, spesso legati in un’unica trama (il Plan Condor)1.

La parete delle vittime
Il
museo offre ai visitatori un panorama completo di quegli anni attraverso
immagini, giornali e documenti video dell’epoca, testimonianze audio,
interviste ai sopravvissuti.
Il
cuore «emozionale» della struttura è però un balcone interno che si trova al
secondo livello. Ha pareti di vetro e candele elettriche che delimitano i suoi
lati. Davanti a esso si apre una vasta parete su cui sono state collocate
migliaia di foto in bianco e nero, piccole e grandi, nitide o meno: sono i
ritratti delle vittime della dittatura. Che però (e per fortuna) non rimangono
volti anonimi e senza voce. Al centro del balcone è stato infatti posto un
leggio elettronico attraverso il quale qualsiasi visitatore può conoscere nome,
cognome e storia di ogni persona ritratta nelle immagini appese.
Lo
schermo tattile riproduce la parete con tutte le sue foto e l’elenco dei nomi.
Scegliamo a caso. Al tocco dello schermo si apre una finestra con la foto
ingrandita e le informazioni sulla vittima. Leggiamo qualche storia: «David
Silberman Gurovich, 35 anni, ingegnere, comunista, sparito dal 4 ottobre 1974»;
«Eugenia del Carmen Martínez Heández, 25 anni, operaia tessile, sparita a
Santiago il 24 ottobre 1974»; Ida Amelia Vera Alamarza, 30 anni, architetto,
membro del Mir2,
sparita il 19 novembre 1974»; «Jorge Humberto Nuñez Canelo, 27 anni,
commerciante ambulante, sparito a Santiago il 30 settembre 1973»; «Rosa Elena
Morales Morales, 46 anni, del partito comunista, sparita 18 agosto 1976 a
Santiago»; «María Cecilia Magnet (Mapu) Ferrero, 27 anni, sociologa, sposata
con il medico argentino Guillermo Tamburini (Mir), spariti il 16 luglio 1976 a
Buenos Aires». Persone comuni di diversa età, provenienza, condizione sociale
la cui esistenza fu spezzata dal regime. «Nessuno può negare, disconoscere,
minimizzare o banalizzare la tragedia dei diritti umani in Cile. Ci
saranno differenti interpretazioni circa le cause della frattura democratica.
Ci saranno distinte interpretazioni sull’eredità del regime autoritario. Però
sul costo umano che il Cile pagò, non dovrebbero esserci divergenze». Sono
parole pronunciate da Michelle Bachelet il giorno della posa della prima pietra
del museo, nell’ottobre 2008. Al contrario di molti politici, la presidente può
parlare con cognizione di causa. Suo padre Alberto morì in carcere, sua madre e
lei stessa passarono per Villa Grimaldi, uno dei principali luoghi di
detenzione e tortura del regime3.
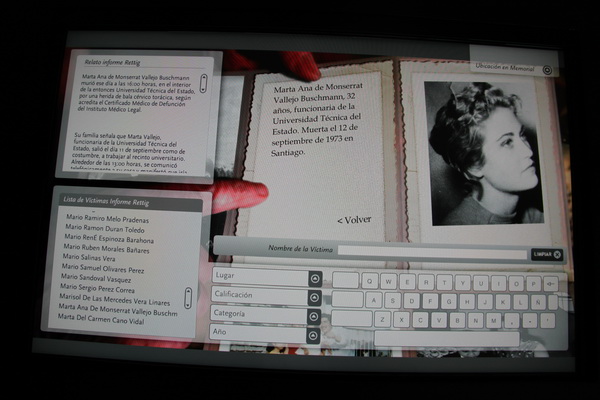
Pro e contro
La Chiesa cattolica non si oppose – almeno inizialmente – al golpe
del generale Pinochet. Troppe erano le paure rispetto all’ideologia socialista
di Salvador Allende e troppi i legami tra Vaticano e Stati Uniti. Il generale
poi era un cattolico e un devoto alla Madonna. Nell’aprile 1987, durante la
visita di papa Giovanni Paolo II, il dittatore si fece fotografare sul balcone
de La Moneda assieme al papa. Tuttavia, il fronte pro-Pinochet non fu mai
monolitico: una parte della Chiesa cilena contrastò da subito il golpe.
Il museo dedica ampio spazio ad alcune di queste persone. La
figura più conosciuta fu il cardinale Raúl Silva Henríquez, arcivescovo di
Santiago durante la breve esperienza di Salvador Allende e nei primi 10 anni
della dittatura. Era il cardinale che provava «una profonda ribellione contro
la menzogna, la violenza, l’ingiustizia, l’arroganza e la mancanza di rispetto
dei diritti umani»4. Fu soprattutto il cardinale che fondò prima, con altre 5
denominazioni religiose, il «Comitato per la
pace in Cile» (Comité para la Paz en Chile) e, immediatamente
dopo lo scioglimento dell’organismo ecumenico (avvenuto il 31 dicembre 1975),
la «Vicaria della solidarietà» (Vicaria
de la solidaridad)5, espressione della sola Chiesa cattolica. Questa concentrò il
proprio lavoro su due aree: la difesa dei diritti umani e la loro promozione,
compiti assolti con la concretezza che l’urgenza storica esigeva. Nel primo
numero di quello che in seguito diventerà un rapporto mensile, la Vicaria
scriveva: «È evidente che in un paese non possono sparire persone. (…) Il
Goveo ha l’obbligo pubblico di dare una risposta circa la situazione degli
“scomparsi”». E nel paragrafo seguente: «La tortura esiste ed è deplorevole per
il nostro paese»6.
L’ultimo
responsabile dell’organizzazione fu mons. Sergio Valech, che la guidò fino alla
sua chiusura, nel 1992. Proprio a causa della sua opera in favore dei diritti
umani, nel 2003 mons. Valech fu chiamato a presiedere la «Commissione nazionale
sulla prigionia politica e la tortura», che lavorò (in due periodi distinti)
per colmare le lacune lasciate dalla Commissione Rettig. Il suo secondo
rapporto, uscito nell’agosto 2011, è quello che – almeno fino a oggi – fornisce
i dati più aggioati sulla dittatura di Pinochet: le persone morte o scomparse
furono 3.065, le vittime di abusi 40.018.
Meno in vista dei prelati, ma non meno importanti, furono due
semplici sacerdoti, che – per opporsi al regime – persero la vita: Juan (Joan)
Alsina e André Jarlan.
Padre
Alsina, spagnolo, fu fucilato a Santiago il 19 settembre del 1973, appena una
settimana dopo il golpe di Pinochet. La frase che disse al suo carnefice è
rimasta negli annali: «Mátame de frente porque quiero verte para darte el perdón»
(Uccidimi di fronte perché voglio vederti per concederti il perdono).
Anche
il sacerdote francese André Jarlan viveva a Santiago, nel quartiere de La
Victoria, roccaforte antigovernativa. Rimase ucciso il 4 settembre 1984 durante
una retata dei carabineros. Tristemente famosa è la foto che ritrae il
suo corpo senza vita seduto alla scrivania, con il capo colpito da un
proiettile e reclinato sulla Bibbia, aperta sul Salmo 129.


Il Museo è una scuola
Quando si toccano argomenti delicati come i diritti umani, è
difficile commentare senza correre il rischio di cadere nella retorica o,
peggio, nell’ipocrisia. Per questo è importante che esistano luoghi come il
Museo della memoria e dei diritti umani. Su una parete di cemento, nei pressi
della sua entrata, sta scritto a lettere cubitali: «El museo es una escula»
(il museo è una scuola). Una frase apparentemente banale ma certamente vera. Al
di là delle possibili, differenti visioni della storia (non soltanto cilena),
mettere in luce le sofferenze e le miserie umane, le vittime e i carnefici non è
mai un esercizio inutile.
Paolo Moiola
(fine seconda puntata – continua*)
Note
1 – Con Plan Condor s’intende una complessa (e
oscura) operazione di politica estera degli Stati Uniti volta ad impedire l’instaurarsi di governi di sinistra
nei paesi latinoamericani. Ebbe luogo tra l’inizio
degli anni Settanta e l’inizio degli anni Novanta. Riguardò soprattutto Cile,
Argentina, Bolivia, Brasile, Perù, Paraguay e Uruguay.
2 – Mir: Movimiento
de Izquierda Revolucionaria; Mapu: Movimiento
de Acción Popular Unitaria.
3 – Su Michelle Bachelet si veda il
relativo capitolo nel libro di Paolo Moiola-Angela Lano, Donne
per un altro mondo, Il Segno dei Gabrielli editori, 2008,
pagg. 262-267.
4 – «Una profunda rebeldía ante la
mentira, la violencia, la injusticia, la prepotencia y la falta de respeto a
los derechos humanos». La presidente Bachelet ha ricordato questa frase sia in
occasione della posa della prima pietra (10 dicembre 2008) sia in occasione
della inaugurazione del Museo (11 gennaio 2010).
5 – Un’interessante
lettura del pensiero del cardinale si può avere in: Guillermo Sandoval, Heán
Sepúlveda, Rodolfo Bonifaz, El Cardenal de los
trabajadores, Centro di Estudios Laborales Alberto
Hurtado, Santiago 2000. Il libro è scaricabile gratuitamente da internet.
6 – Pagina 10 de Reflexion
1, febbraio 1976. Reperibile sul sito:
wwww.archivovicaria.cl.

A colloquio con mons. Luis Infanti
de la Mora
Acqua, terre, mari,
minerali: «Basta con la svendita
delle risorse»
A differenza del suo primo mandato, la presidenta
Bachelet non potrà proseguire sulla strada del neoliberismo, dimenticando equità
ambientale e sviluppo sostenibile. Oggi è fondamentale porre un freno a imprese
invasive e irresponsabili. E la Chiesa non deve farsi comprare dai poteri
economici e politici. Mons. Luis Infanti de la Mora, combattivo vescovo
dell’Aysén, ragiona secondo una prospettiva teologica, ma senza perdere di
vista la concretezza.
Nato in provincia di Udine, Luis Infanti de la Mora
arriva in Cile nel 1973, all’età di 19 anni, come seminarista dell’Ordine dei
Servi di Maria. Dopo gli studi all’Università cattolica di Santiago, è a
Cochabamba, in Bolivia, per 8 anni. Ordinato sacerdote, nel 1995 arriva a
Coyhaique, capoluogo dell’Aysén, la Patagonia cilena. Nel dicembre del 1999 è
nominato vescovo del vicariato apostolico di Aysén.
Mons. Infanti
guadagna notorietà internazionale quando si schiera contro il megaprogetto
HidroAysén, lottando a fianco delle popolazioni locali e di «Patagonia senza
dighe» (Patagonia sin represas), un movimento popolare simile a quello «NoTav»
degli albori. Una scelta di campo tutt’altro che banale: un vescovo di origini
italiane si oppone a un’opera che vede proprio l’Italia in prima fila,
considerando che l’attore principale di HidroAysén è l’Enel, azienda in cui lo
stato italiano è l’azionista più importante.
 Mons. Infanti, sul web si legge che HidroAysén – il consorzio tra
Mons. Infanti, sul web si legge che HidroAysén – il consorzio tra
Enel-Endesa e Colbún (della famiglia cilena Matte) – avrebbe ridimensionato di
molto il proprio megaprogetto idroelettrico sui fiumi Baker e Pascua della Patagonia
cilena. Ciò risponde al vero o si tratta di malainformazione?
«In Aysén
l’impresa HidroAysén (italiana e cilena) da vari anni ha progettato 5 grandi
dighe per produrre energia idroelettrica in favore delle miniere di rame al
nord del Cile, a quasi 3.000 chilometri di distanza. Il megaprogetto di
HidroAysén è stato finora paralizzato per l’opposizione di grandi settori della
popolazione. Oggi ci sono molti segnali che indicano la sua imminente morte,
anche perché il nuovo governo di Michelle Bachelet sembra contrario alla sua
realizzazione. Ricordo che, nel febbraio-marzo del 2012, l’indignazione
popolare portò a paralizzare per 40 giorni tutta la regione, unendo in un’unica
voce di protesta Patagonia sin represas (Patagonia senza dighe),
pescatori, commercianti, studenti, autotrasportatori. In tutto ciò la Chiesa
dell’Aysén ha avuto un ruolo rilevante».
In che modo?
«Affiancando
le varie organizzazioni e i settori sociali che si sono espressi contro questo
progetto. Pubblicando una lettera pastorale Danos hoy el agua de cada dia
(Dacci oggi la nostra acqua quotidiana), in cui, oltre a presentare con
argomentazioni precise i motivi del rifiuto di questa iniziativa
imprenditoriale, noi abbiamo messo in discussione la proprietà dell’acqua
nell’Aysén e in Cile. Con una visione etica e spirituale, abbiamo aiutato a
prendere coscienza della sua importanza come elemento vitale di sempre maggior
rilievo in tutto il mondo. Abbiamo infine evidenziato una sorta di nuova
colonizzazione dei paesi del Nord verso i paesi del Sud, una colonizzazione che
trasforma l’acqua in una merce emarginando grandi settori della popolazione,
condannandoli alla povertà se non addirittura alla morte».
Lei parla di «merce» e non di «bene pubblico»…
«Il tema della
privatizzazione dell’acqua (proprietà e gestione monopolistica dell’Enel,
attraverso la controllata Endesa Chile) è entrato come tema prioritario nella
società cilena e sta dando impulso anche a un movimento per cambiare l’attuale
Costituzione politica dello Stato, approvata nel 1980, in piena dittatura di
Pinochet e quindi antidemocratica».
Gran parte della crescita economica del Cile è fondata sullo
sfruttamento delle proprie risorse naturali: risorse minerarie, foreste, acqua,
risorse ittiche. Si tratta di uno sfruttamento «sostenibile»? E ancora: è
realisticamente possibile avere uno sfruttamento «sostenibile» o si tratta di
una contraddizione in termini?
«La politica
neoliberista in Cile ha aperto le porte alla svendita delle risorse naturali
alle imprese multinazionali, le quali fanno i loro interessi e si preoccupano
solo dei propri guadagni. E certamente non delle necessità delle popolazioni.
La cosiddetta “responsabilità sociale delle imprese” non ha una efficacia reale
nei territori e con le comunitá in cui le imprese operano. Prova di ciò sono le
continue proteste in tutto il Cile contro imprese invasive e irresponsabili,
appoggiate da legislazioni che le avallano».
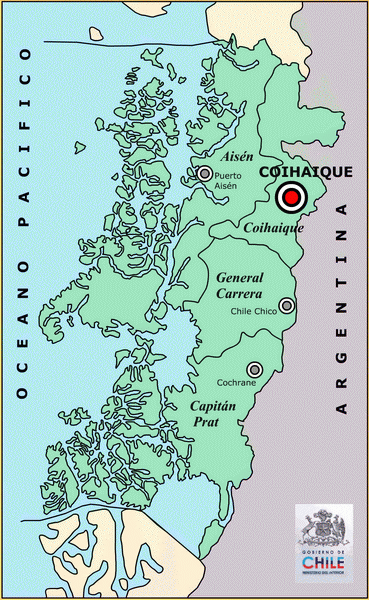 Il programma di governo di Michelle Bachelet parla – alla pagina 126 –
Il programma di governo di Michelle Bachelet parla – alla pagina 126 –
di «equità ambientale» e di «sviluppo sostenibile». La presidenta riuscirà in
questo o si tratta soltanto di mera propaganda?
«Nel suo
governo precedente Michelle Bachelet ha dato numerosi esempi di voler
approfondire il sistema liberista portato avanti dai tempi della dittatura di
Pinochet: la “equidad ambiental” e il “desarrollo sustentable” non sono state
dunque tra le sue priorità. Nell’attuale gestione di governo non potrà fare lo
stesso. Perché la coscienza, le esigenze, l’intervento e la partecipazione
della popolazione cilena la obbligheranno a tenere fede agli impegni presi nel
suo nuovo programma di governo».
Lo stato – in Cile come in Italia e nella maggior parte dei paesi – non
sembra voler capire che la difesa dell’ambiente è una questione cruciale per il
presente e il futuro. Tuttavia, troppo spesso i cittadini sono i primi a non
rispettare l’ambiente. È d’accordo con questa affermazione? Se sì, cosa
occorrerebbe fare per porvi (rapidamente) rimedio?
«La difesa
dell’ambiente e le nostre relazioni di comunione con esso incontrano sempre
maggiore coscienza nei cittadini, anche se non sempre si traducono in
atteggiamenti e stili di vita nella quotidianità.
In questi
tempi in cui anche la Madre Terra lancia profonde grida di sofferenza come
“dolori di parto”, in qualità di religiosi, noi abbiamo una gran responsabilità
nell’annunciare, vivere e celebrare la nostra fede in Dio Creatore, che ha dato
vita ad ogni creatura affinché cresca e si sviluppi con pienezza. Diventa
allora responsabilità essenziale dell’essere umano – con la sua saggezza, la
sua scienza, il suo amore, la sua lungimiranza – impegnarsi per costruire “i
cieli nuovi e la terra nuova”. Percepisco che la spiritualità biblica del Dio
Creatore e Redentore ha profonda sintonia con la spiritualità vissuta da San
Francesco d’Assisi e anche con le modalità di vita dei popoli indigeni e di chi
rispetta, ama e lotta per promuovere la comunione e la bellezza di ogni essere
creato, soprattutto dell’essere umano».
Secondo lei, i popoli indigeni hanno – mediamente – un rispetto maggiore
della natura o questo è un luogo comune per enfatizzare il loro ruolo?
«Fatte salve
le differenze tra uno e l’altro, tutti i popoli indigeni hanno una cultura
profondamente spirituale di comunione e di incontro con la Divinità attraverso
le creature e specialmente attraverso la natura (acqua, boschi, clima, vento,
fuoco…). Ciò li porta a un profondo rispetto e condivisione dei beni naturali,
che sentono come parte intimamente unita alla loro vita. Quando sono invasi e privati del loro ambiente,
come succede con sempre maggiore frequenza nella società consumista, si sentono
violentati fisicamente, spiritualmente e moralmente. Offesi nel loro stesso
stile di vita».
 Una parte della Chiesa cattolica e della gerarchia in particolare ha
Una parte della Chiesa cattolica e della gerarchia in particolare ha
timore a schierarsi dalla parte degli ambientalisti, perché li considera troppo
vicini a posizioni ideologiche di sinistra, spesso viste come antitetiche
rispetto ai dettami evangelici. Si tratta di un timore fondato?
«Tra gli
ambientalisti ci sono varie linee ispiratrici e varie posizioni, come anche
nella Chiesa cattolica e in ogni organizzazione umana.
La dottrina,
oggi, merita un maggior approfondimento della fede nel “Dio Creatore” e nella
proclamazione originaria del popolo della Bibbia che “la terra è di Dio”,
contrapponendola a certe persone e organizzazioni umane che si sentono signori
e padroni dei beni comuni. Se questo approfondimento teologico e pastorale
della Chiesa porta a posizioni e decisioni simili a qualche gruppo o movimento
o partito o organizzazione, non deve destare alcun timore.
Grazie anche
agli ultimi papi, la Chiesa cattolica sta prendendo più coscienza del tema
ambientale e dei suoi gravi problemi (terra, acqua, alimenti, estrattivismo,
cambiamento climatico, …) e della povertà come struttura sociale imposta dai
poteri depredatori della vita. Mi pare che oggi la sua scelta di campo sia
dalla parte degli impoveriti, degli emarginati, dei silenziati, facendo la
stessa opzione di Cristo».
I poteri economici sanno essere molto persuasivi. Secondo lei, è
possibile resistervi?
«La Chiesa,
compresa la gerarchia, soprattutto in America Latina, sempre con maggior
evidenza non si lascia comprare dai poteri economici e politici che la
vorrebbero tenere come alleata per silenziare la sua missione profetica di
fedeltà a Cristo e all’umanità. Le strategie del potere, del dolce e gentile
potere, molte volte hanno uno spirito diabolico. Preghiamo sempre per non
cadere in questa pericolosa tentazione».
Paolo Moiola
 Siti web:
Siti web:
Libri:
• Luis Infanti de la Mora, Dacci
oggi la nostra acqua quotidiana, Emi, Bologna 2010.
• Patricio Rodrigo S. – Juan Pablo
Orrego S. (a cura di), Patagonia chilena sin represas, Ocho Libros
Editores, Santiago 2007. Questo (bellissimo) volume è scaricabile gratuitamente
dal sito di Patagonia sin represas.
La
Chiesa cilena e Pinochet
DAL «BALCONE» AL MARTIRIO
• padre Juan (Joan) Alsina – Sacerdote spagnolo, fucilato a
Santiago il 19 settembre del 1973, una settimana dopo il golpe di Pinochet.
• padre André Jarlan – Sacerdote francese, ucciso dai carabineros
il 4 settembre del 1984 a La Victoria, durante la repressione di una
manifestazione contro la dittatura.
• cardinale Raúl Silva Henríquez – Nel 1973 fu cofondatore del «Comité
para la Paz en Chile». Dopo la sua chiusura forzata, il 1 gennaio 1976 fondò la
«Vicaría de la Solidaridad», organismo di assistenza sociale e legale alle
vittime della giunta del generale Pinochet. Nonostante pressioni e minacce,
l’organismo lavorò fino alla caduta della dittatura.
• monsignor Sergio Valech Aldunate – Fu l’ultimo responsabile (dal 1987
al 1992) della «Vicaría de la Solidaridad». Fu presidente della «Commissione
sulla carcerazione politica e la tortura» (Commissione Valech).


Diritti umani in Cile
Dalla violazione al riscatto
• 1973, 11 settembre – 1990, 10 marzo: Dittatura del
generale Augusto Pinochet.• 1990, aprile – 1991, febbraio: Lavoro della «Comisión
Nacional de Verdad y Reconciliación». Il risultato finale è l’«Informe Rettig»,
che sarà giudicato insoddisfacente.
• 1992, febbraio – 1994, febbraio: Lavoro della «Corporación
Nacional de Reparación y Reconciliación».
• 2003, settembre – 2004, novembre: Lavoro della «Comisión
Nacional sobre Prisión Política y Tortura», nota anche come «Comisión Valech»,
dal nome del suo presidente, mons. Sergio Valech.
• 2010, febbraio – 2011, agosto: Lavoro della seconda
Commissione Valech. Nel rapporto finale si riconosce che la dittatura di
Pinochet ha fatto 40.018 vittime e 3.065 persone morte o sparite.
• 2010, 11 gennaio: Apre a Santiago il «Museo de la Memoria
y los Derechos Humanos».
________________________________
Siti
internet:
Ringraziamenti
Si ringraziano per l’aiuto e la disponibilità María Luisa Ortiz e Alejandra
Tapia, dirigenti del Museo della memoria di Santiago.
* Nella prossima puntata: l’incontro con i pescatori dell’isola di Chiloé;
l’intervista con il vescovo di Ancud, mons. Juan María Agurto Muñoz, e altro
ancora.
Tags: Cile, dittatura, memoria, Pinochet, Michelle Bachelet, Luis Infanti de la Mora, museo, Chiesa, acqua, risorse, Chiloé
Paolo Moiola







 Indice:
Indice:


 Caritas ambrosiana: il valore di un percorso
Caritas ambrosiana: il valore di un percorso

 Charles
Charles Quello
Quello




 Viaggio in Cile / 2
Viaggio in Cile / 2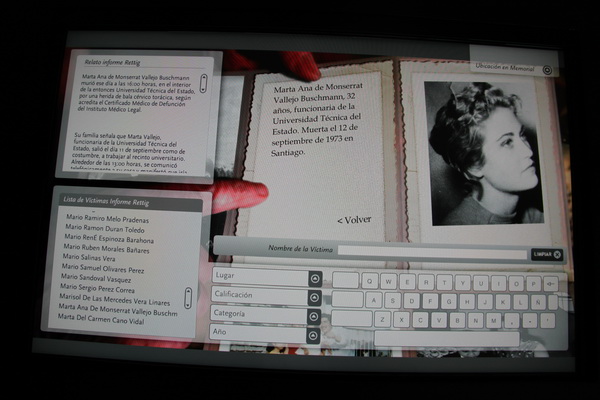



 Mons. Infanti, sul web si legge che HidroAysén – il consorzio tra
Mons. Infanti, sul web si legge che HidroAysén – il consorzio tra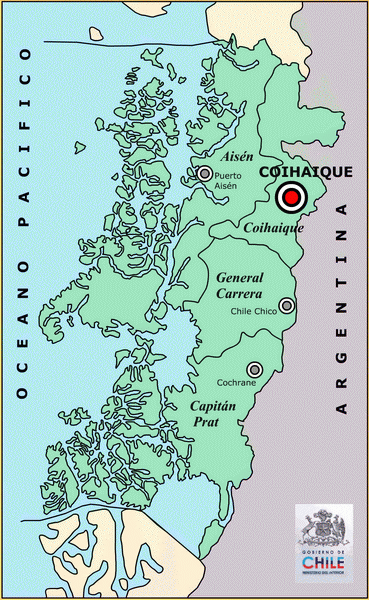 Il programma di governo di Michelle Bachelet parla – alla pagina 126 –
Il programma di governo di Michelle Bachelet parla – alla pagina 126 – Una parte della Chiesa cattolica e della gerarchia in particolare ha
Una parte della Chiesa cattolica e della gerarchia in particolare ha Siti web:
Siti web:

 L’espansionismo cinese
L’espansionismo cinese









 Reportage «faticoso»
Reportage «faticoso» Incontro con il capo supremo del Vodù
Incontro con il capo supremo del Vodù  Un cartello segnala casa sua, il Péristyle de Mariani, ovvero il
Un cartello segnala casa sua, il Péristyle de Mariani, ovvero il






