Acqua, nuove battaglie

comuni.
Dopo i risultati del referendum del 2011 sull’acqua come
diritto umano, i movimenti si organizzano ed estendono la battaglia ad altri
beni comuni e alla democrazia. Il rifiuto della mercificazione della vita, il
recupero della responsabilità delle autorità pubbliche, la domanda di nuovi
spazi di partecipazione politica. Lavorando sul locale senza perdere la visione
globale.
Giugno 2011: gli Italiani si pronunciano contro la privatizzazione dei
servizi idrici, rivitalizzando, con sorpresa di molti, il referendum come
strumento di partecipazione politica. A quasi tre anni di distanza da quel
voto, a che punto siamo? La battaglia referendaria sull’acqua appare da diversi
punti di vista una vittoria mutilata.
Senza dubbio il referendum ha contribuito a rappresentare
e affermare il vasto consenso popolare esistente in merito al fatto che l’acqua
deve essere considerata un diritto umano e bene comune, legittimando
giuridicamente e politicamente la gestione pubblica dei servici idrici. A
questi principi si richiamano ormai, almeno a parole, anche quei politici e
rappresentanti delle istituzioni che in passato guardavano con favore a un
ruolo più incisivo del mercato nella gestione dei servizi idrici. In virtù del
risultato referendario, l’acqua in molti casi è rimasta fuori dai processi di
privatizzazione e di cessione di quote delle società pubbliche di gestione dei
servizi locali, come i rifiuti e i trasporti. Anche se non sono mancati
tentativi da parte del governo Berlusconi e poi di quello Monti di ribaltare il
risultato referendario, introducendo alcune disposizioni che di fatto
riproponevano le norme abrogate dal referendum.
Dal punto di vista tecnico e giuridico, il primo dei due quesiti
referendari ha eliminato l’obbligo per gli enti locali, introdotto nel 2008 dal
cosiddetto Decreto Ronchi, di mettere a gara la gestione dei servizi idrici
entro la fine del 2011 per affidarla a società pubbliche, private o miste. La
normativa ora in vigore è quella europea, che prevede anche la gestione «in
house», ovvero da parte di Spa a intero capitale pubblico, la formula al
momento più diffusa in Italia, che il Decreto Ronchi intendeva invece superare.
Dal punto di vista politico, tuttavia, per il Forum italiano dei movimenti per l’acqua, l’indicazione emersa dal referendum è quella dell’affermazione
di una gestione squisitamente pubblica dei servizi idrici, che dovrebbe passare
per il superamento della forma dell’Spa, anche se interamente pubblica, in
quanto governata comunque dal diritto privato e orientata alle logiche del
profitto e della massimizzazione degli utili. Questa convinzione ha ispirato
diversi percorsi di ripubblicizzazione dei servizi idrici, promossi dal
movimento e da alcuni rappresentanti degli enti locali in diverse città
italiane. Il caso più conosciuto è quello di Napoli, dove il sindaco Luigi de
Magistris, all’indomani del referendum, ha nominato Alberto Lucarelli e Ugo
Mattei – giuristi estensori dei quesiti referendari – rispettivamente Assessore
ai Beni Comuni e Vice presidente di Arin Spa, la società di gestione del
servizio idrico napoletano. Il loro lavoro ha portato alla trasformazione di
Arin in azienda speciale di diritto pubblico, Abc Napoli (Acqua Bene Comune).
Nell’ottica di una gestione più partecipata e democratica, che superi i vizi
delle precedenti esperienze di gestione pubblica, la nuova azienda prevede
anche un’assemblea di indirizzo in cui siedono rappresentanti dei lavoratori,
degli utenti e dei movimenti ambientalisti.
A Reggio Emilia, è stato invece istituito un forum provinciale cui
partecipano i rappresentanti delle istituzioni locali e dei movimenti, con il
mandato di ridefinire l’assetto della gestione dei servizi idrici alla luce del
risultato referendario.
Questo percorso ha portato alla revoca a fine 2012 della
concessione della gestione del servizio idrico a Iren, società multi-utilities
che opera nella gestione di acqua, energia e rifiuti in Piemonte, Liguria ed
Emilia. Il nodo da sciogliere resta quello della natura del nuovo soggetto che
gestirà il servizio idrico: azienda speciale sul modello di Napoli, come
chiedono i movimenti, o Spa «in house», come preferiscono gli
amministratori locali, preoccupati di non appesantire troppo i bilanci dei loro
comuni accollandosi anche le spese del servizio idrico. Percorsi analoghi sono
stati attivati in tutta Italia – Torino, Palermo, Imperia, Savona, Varese, Forlì,
Piacenza – attraverso raccolte firme e proposte di delibere di iniziativa
popolare per la ripubblicizzazione del servizio idrico, presentate nei consigli
comunali e provinciali.
Il secondo quesito referendario, in nome del principio «fuori i
profitti dall’acqua!» ha invece sancito l’eliminazione della quota di
remunerazione del capitale investito, fissata per legge ad un tasso del 7%, dal
calcolo della tariffa del servizio idrico. All’indomani del referendum,
tuttavia, le Autorità d’ambito territoriale ottimale (Aato, le istituzioni che
governano il servizio idrico integrato) non hanno adeguato le tariffe al
risultato referendario, preoccupate dalla necessità di continuare a pagare gli
interessi dei capitali presi a prestito per realizzare gli investimenti nel
settore idrico. Nel 2012 il governo Monti ha affidato all’Authority per
l’Energia elettrica e il Gas (Aeeg) le funzioni di regolazione e di controllo
dei servizi idrici, con il mandato di definire il nuovo metodo tariffario.
Il Forum dei movimenti per l’acqua ha espresso un giudizio
negativo sulle proposte dell’Aeeg, accusandola di far rientrare dalla finestra
nel nuovo calcolo della tariffa i profitti per i gestori, sotto la
denominazione «costo della risorsa finanziaria». Insieme a Federconsumatori, il
Forum ha promosso diversi ricorsi presso il giudice di pace e i Tar (in
Lombardia, Toscana, Emilia Romagna), per ribadire l’illegittimità delle scelte
delle Aato e dell’Aeeg. Il Forum ha anche lanciato una «Campagna di Obbedienza
Civile», che invita i cittadini a farsi interpreti in prima persona della
traduzione pratica del secondo quesito referendario, attraverso un’autoriduzione
della bolletta pari alla componente relativa alla remunerazione del capitale
investito.
Nella visione del Forum dei movimenti per l’acqua, le azioni per
la piena realizzazione dei risultati referendari hanno finito per assumere il
significato politico più ampio di denuncia della crisi della democrazia
rappresentativa e dei canali tradizionali di partecipazione politica, partiti
in primis, considerati ormai impermeabili alle istanze della società e incapaci
di tradurre in politiche concrete l’espressione della volontà popolare.
In risposta a questa crisi, il riferimento ai
beni comuni orienta anche l’auto rappresentazione del movimento stesso,
suggerendo nuove forme di partecipazione politica attraverso quella che alcuni
militanti come Marco Bersani definiscono «la democrazia dei beni comuni».
L’idea è che un soggetto politico impegnato a battersi per la difesa dei beni
comuni, non può essere ispirato alle logiche verticistiche, elitarie o
addirittura personalistiche che negli ultimi tempi hanno caratterizzato i
partiti politici. Di qui, le caratteristiche organizzative scelte dal Forum dei
movimenti per l’acqua: una base di militanti volontari e non professionisti, il
rifiuto di leadership carismatiche, il ricorso al metodo del consenso
per prendere le decisioni, una struttura orizzontale e decentrata, fondata su
comitati locali gelosi della propria autonomia, per cui anche la semplice
istituzionalizzazione della segreteria operativa del Forum a Roma è stata
interpretata da alcuni come tentativo di centralizzare e mettere il cappello
sulla mobilitazione. In virtù del successo referendario e
della capacità di imporre la formula «acqua bene comune» nel dibattito
pubblico, la mobilitazione per l’acqua pubblica si è così trasformata in
battaglia paradigmatica per i beni comuni e la democrazia, contro la
privatizzazione e la mercificazione della politica e della vita. Ciò sembra
esser confermato dal riferimento sempre più frequente alla categoria dei beni
comuni anche nell’ambito di altri movimenti sociali. L’intento è quello di
sottolineare la loro connessione con i temi dell’acqua o di adottare strategie
e pratiche d’azione analoghe a quelle del Forum, con l’auspicio di replicarne
il successo.
In molti casi, la diffusione della narrazione dei beni comuni e
delle pratiche a essa collegate sviluppate nell’ambito della battaglia per
l’acqua avviene per osmosi, attraverso le esperienze di militanti attivi sia
nel movimento per l’acqua che in altri contesti.
Ad esempio, Domenico Finiguerra, sindaco tra i più attivi nel
movimento per l’acqua, è tra i fondatori del Forum dei movimenti per la terra e
il paesaggio. Luca Martinelli, giornalista di Altreconomia e Marco Bersani di
Attac sono tra gli animatori del Forum per una nuova finanza pubblica e
sociale.
I rappresentanti della Cgil-Funzione pubblica che militano anche
nel movimento per l’acqua, come Corrado Oddi, contribuiscono a introdurre il
vocabolario dei beni comuni nelle attività del sindacato. Giuristi come Ugo
Mattei partecipano alla riflessione su come tradurre l’idea di beni comuni in
pratiche concrete nel contesto delle occupazioni del Teatro Valle a Roma e
della Torre Guelfa a Milano.
Per quanto eterogenee in termini di soggetti coinvolti, temi,
durata nel tempo ed efficacia, queste battaglie sembrano accomunate da tre
istanze manifestate attraverso il richiamo ai beni comuni. Innanzitutto il
rifiuto della mercificazione della vita, ovvero dell’estensione delle logiche e
degli strumenti del mercato, della concorrenza e della competitività ad ambiti
sempre più estesi della nostra quotidianità.
In secondo luogo la richiesta di una riassunzione di responsabilità
da parte delle autorità pubbliche, che inverta la rotta della privatizzazione o
dell’estealizzazione di competenze le quali vengono invece individuate come
costitutive del bene comune e strategiche per il governo del territorio. Infine
la domanda e la pratica di nuovi e più ampi spazi di partecipazione politica,
attraverso l’adozione di nuove forme di attivismo che contribuiscano a
ridefinire identità e appartenenze.
In questa prospettiva, affinché il movimento per l’acqua continui
a svolgere un’azione pionieristica di elaborazione culturale e politica, due
appaiono come i principali nodi da sciogliere. In primo luogo quello dei rischi
legati alla «giuridizzazione» della battaglia: per influenza dei saperi tecnici
coinvolti nel movimento e per la natura stessa delle questioni di attualità sul
tavolo, l’azione del movimento negli ultimi anni si è tradotta soprattutto in
iniziative e rivendicazioni di natura giuridica, dalle vertenze legali
all’enfasi sulla natura del soggetto gestore: azienda pubblica vs Spa.
Infatti, per loro natura, i beni comuni richiedono la pratica
dell’interdisciplinarietà, che di sicuro potrebbe giovare al movimento
nell’affrontare in maniera più organica le principali questioni legate alla
gestione del ciclo dell’acqua, come ad esempio il dissesto idro-geologico del
territorio italiano.
In secondo luogo, l’enfasi sull’attuazione a livello locale dei
referendum rischia di far trascurare la dimensione internazionale del tema
acqua. Una delle originalità del movimento per l’acqua, nato alla fine degli
anni ‘90 su impulso dei Social forum, del Contratto Mondiale sull’Acqua
proposto dall’economista Riccardo Petrella, e dal lavoro di educazione alla
cittadinanza globale delle Ong di cooperazione internazionale allo sviluppo è
proprio quello di esser riuscito a tenere insieme la dimensione locale del tema
con quella globale. I movimenti europei per l’acqua sono stati i primi a
utilizzare in Europa il nuovo strumento dell’Iniziativa dei cittadini
europei introdotto dal Trattato di Lisbona, raccogliendo l’anno scorso le
firme per presentare una proposta di legge sul riconoscimento del diritto umano
all’acqua. I seguiti di questa campagna potranno aiutare la riscoperta della
dimensione internazionale del tema, oltre che contribuire a riempire di
contenuti il dibattito su identità, ruolo e prospettive dell’Europa.

Il libro
«Si scrive Acqua…
Attori, pratiche e discorsi nel
movimento italiano per l’acqua bene comune»,
Senza inseguire leadership carismatiche, ignorato
dall’establishment politico e mediatico, il movimento Acqua bene comune ha
saputo coinvolgere e tenere insieme una coalizione vasta e plurale, riferendosi
a principi morali e diritti fondamentali, adottando un’ottica non solo locale
ma anche globale, e portando avanti una battaglia paradigmatica per la
democrazia e il bene comune. Il libro nasce dalla volontà di riflettere sugli
elementi e le pratiche che hanno reso possibile questa esperienza e sul suo
significato politico più ampio.
Il volume, oltre a essere acquistabile in versione cartacea,
è scaricabile gratuitamente dal sito dell’editore.
www.aaccademia.it/siscriveacqua.
Emanuele Fantini




 L’inversione di tendenza. Polonia meta d’immigrazione
L’inversione di tendenza. Polonia meta d’immigrazione



 Diario di un anno nella pastorale migranti
Diario di un anno nella pastorale migranti Alla fine di gennaio 2013 mi
Alla fine di gennaio 2013 mi























 L’associazione parte con due motivazioni: portare avanti
L’associazione parte con due motivazioni: portare avanti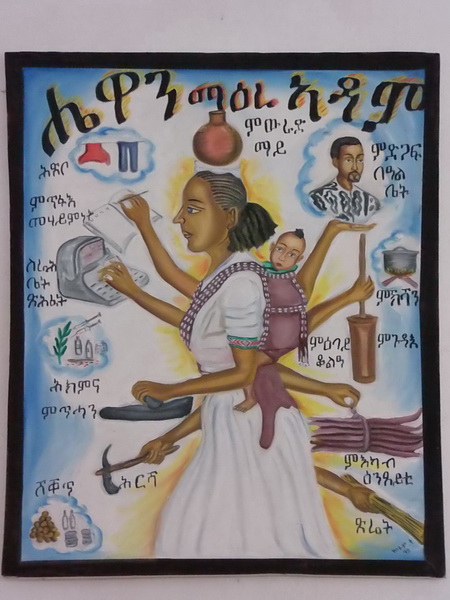 A Keren le suore cappuccine stavano aprendo in quel
A Keren le suore cappuccine stavano aprendo in quel

.JPG)
 Nei primi anni dopo l’indipendenza, l’Eplf si trasforma
Nei primi anni dopo l’indipendenza, l’Eplf si trasforma