Egitto: Prima e dopo la primavera araba
Riflessioni e fatti sulla libertà religiosa
nel mondo – 11
Secondo le ricerche del Pew Forum è uno dei paesi al mondo in
cui maggiormente viene violata la libertà religiosa. L’Egitto ha fin dalle sue
origini modee una grande difficoltà a risolvere il conflitto tra potere
statale e potere religioso. La cosiddetta primavera araba ha sparigliato le
carte sul tavolo dando maggiore peso alle autorità religiose e alla sharia. Ma
tutto è in movimento.
Chiunque voglia iniziare a
occuparsi di Egitto si renderà immediatamente conto che non potrà non
considerare il fattore religioso. La società egiziana in patria e in
emigrazione (ad esempio la comunità egiziana in Italia) ne è profondamente
intrisa, e questo non riguarda solo i musulmani.
In Egitto circa il 90% della popolazione è costituito da musulmani
sunniti, l’1% da musulmani shiiti, l’8-12% da cristiani, in maggioranza della
Chiesa ortodossa copta, e il restante da altre minoranze, tra le quali i
baha’i e gli ebrei (questi ultimi
stimati dall’Inteational Religious Freedom Report stilato dal
Dipartimento di Stato degli Usa in meno di 200 individui nel 2008, e in circa
100 nel 2012).
Per quanto riguarda la comunità cristiana, nonostante la Chiesa
copta ortodossa ne rappresenti la maggioranza, è importante considerare la
presenza di altre chiese: quella cattolica (con le sue sette denominazioni:
copto-cattolica, greco-melchita, maronita, siriaca, caldea, armena e latina),
quella greco-ortodossa, e quelle anglicana ed evangelica. Uno dei problemi
posti dalla predominanza della Chiesa copta ortodossa, messo in evidenza da
Michael Fitzgerald, ex presidente del Pontificio consiglio per il dialogo
interreligioso, oggi nunzio apostolico al Cairo, è il fatto che le autorità,
sia quelle del precedente regime che quelle dell’odierno governo, tendono a
vedere tutti i cristiani come copti e a considerare il loro papa Tawadros II
come loro unico rappresentante.
Altra questione posta dalle minoranze religiose riguarda la
presenza di comunità non riconosciute che si trovano private della maggioranza
dei diritti. Il caso più eclatante è quello della comunità baha’i, che a
partire dagli anni Sessanta è stata disconosciuta e interdetta, le sono stati
confiscati tutti i beni, con l’ovvia conseguenza dell’impossibilità di
costruire o mantenere propri luoghi di culto.
Secondo Elisa Ferrero, giornalista freelance, profonda
conoscitrice del contesto religioso egiziano, che abbiamo sentito proprio sul
tema della libertà di religione in Egitto, «la nuova costituzione ha radicato
l’esclusione di altre religioni. Paradossalmente ha riconosciuto maggiormente i
cristiani, dando alla Chiesa ortodossa copta la prerogativa di decidere su
alcune questioni come la famiglia, i matrimoni, l’eredità. Questo non è
piaciuto a molti cristiani che preferiscono invece uno stato laico in cui sia
effettivamente garantita la libertà di credo di tutti».
La libertà
religiosa prima della primavera araba
Gianluca Parolin, costituzionalista italiano e professore di
diritto comparato presso l’Università Americana del Cairo ci offre
un’interessante analisi della libertà religiosa in Egitto dal punto di vista
giuridico. Nel suo articolo La libertà religiosa nell’Egitto post coloniale
descrive la relazione tra politica e religione in Egitto dalle sue origini
modee a oggi, e le principali questioni (nella maggior parte dei casi ancora
aperte) relative alla libertà religiosa. Lo studioso sostiene che la stessa
creazione dell’Egitto moderno – la quale coincide con l’affermazione di
un’autorità politica il cui controllo si estende al di là dell’ambito
precedentemente ricoperto, e che «progressivamente circoscrive, assedia,
penetra ed espugna il dominio dell’autorità religiosa, incidendo in tal modo
assai profondamente sul fenomeno religioso stesso» – potrebbe essere
ricostruita seguendo la ri-articolazione dello snodo tra fenomeno religioso e
autorità politica nei decenni.
Da Muhammad ’Ali (1769-1849), colui che è ritenuto il fondatore
dell’Egitto moderno, fino alla rivoluzione del 1952, infatti, sono stati erosi
gli spazi di autonomia della religione, ed è stato delineato un sistema
giuridico con aspirazioni esclusive, ma dalla natura plurale.
Tra l’inizio dell’Ottocento e la prima metà del Novecento, in
particolare, la relazione tra autorità politica e fenomeno religioso in Egitto
ha subito, secondo lo studioso, tre ri-articolazioni fondamentali. La prima ha
riguardato l’introduzione della gestione centralizzata delle fondazioni pie (waqf)
che ha sottratto alle autorità religiose l’indipendenza economica
trasformandole in «salariate» dello Stato. La seconda ha colpito la giurisdizione
dell’autorità religiosa con la creazione di giurisdizioni concorrenti che hanno
limitato l’area d’influenza del diritto confessionale. La terza ha coinvolto il
contenuto del diritto confessionale attraverso forti incursioni dell’autorità
politica, primo tra tutti nel diritto di famiglia.
La rivoluzione del 1952 ha infine portato a compimento il processo
cominciato nell’Ottocento.
Nella sua analisi Parolin evidenzia come nella seconda metà del
Novecento «l’autorità politica estende significativamente il suo controllo sul
fenomeno religioso con due operazioni di grande impatto»:
1) la giurisdizione dei giudici religiosi viene accorpata nel
sistema di tribunali statali, diventando una sezione specializzata dei
tribunali civili dello stato (pur mantenendo invariato il personale e il
diritto sostanziale applicato);
2) lo stato nazionalizza l’università al-Azhar, la maggiore
istituzione di formazione religiosa, disponendo che lo shaykh al-Azhar,
il suo vertice, venga nominato con decreto presidenziale e ridisegnando
l’impianto stesso della formazione offerta.
Primavera
Araba, trasformazioni religiose?
La situazione descritta è rimasta più o meno stabile fino agli
eventi del gennaio 2011 e alle dimissioni di Mubarak.
Diverse fonti sono concordi nell’affermare che la «rivoluzione»
egiziana sia stata portata avanti da forze diverse e che nelle proteste di
piazza Tahrir si respirasse un generale senso di unità e di orgoglio di essere
egiziani, prima che cristiani o musulmani, moderati o fondamentalisti.
Cristiani e musulmani erano insieme, «una sola mano», come titola Elisa Ferrero
il suo bel libro che descrive i giorni caldi della rivolta.
La «rivoluzione» del 25 gennaio non ha però assunto tra i suoi
temi la questione della libertà religiosa, e molti dei nodi irrisolti si sono
riproposti nei mesi successivi, soprattutto con la polarizzazione elettorale
(sia per le elezioni parlamentari sia per quelle presidenziali).
Sono due in particolare – riprendendo ancora Gianluca Parolin – le
questioni ancora aperte che continuano a generare tensioni interconfessionali:
la disciplina delle conversioni e quella degli edifici di culto non musulmani.
Per quanto riguarda il primo punto, la questione riguarda, ad esempio, i copti
ortodossi che si convertono all’islam per aggirare la severità del diritto di
famiglia copto ortodosso. Papa Shenouda, nel 2008, aveva infatti ridotto le
nove condizioni per divorziare, previste dalla legge del 1938, al solo
adulterio, spingendo molti copti alla conversione (a volte temporanea)
all’islam, per essere così in grado di annullare il proprio matrimonio. Tale
pratica ha causato spesso tensioni settarie anche gravi. Per quanto riguarda i
luoghi di culto non musulmani, da una parte l’art. 46 della Costituzione
egiziana impone «dieci condizioni» difficilmente rispettabili per la
costruzione, dall’altra la riluttanza e la discrezionalità delle autorità a
concedere l’autorizzazione, anche in presenza delle condizioni, rende il
rispetto della normativa rarissimo: la creatività dimostrata nell’aggirarla
pone, secondo Parolin, le comunità non musulmane nell’illegalità, e le espone a
rappresaglie che ciclicamente culminano in scontri con vittime e luoghi di
culto incendiati.
Oltre alle questioni legate ai «due nervi scoperti del sistema»
appena analizzati, nel dibattito pubblico dopo il 25 gennaio 2011 sono state
costanti le discussioni sul ruolo dell’islam nella vita pubblica egiziana e sul
ruolo dello stato nel fenomeno religioso. La prima delle due ha fortemente
polarizzato i processi referendari ed elettorali e si è riproposta anche in
occasione della stesura della «nuova» Costituzione. L’accesa campagna
referendaria, infatti – sempre riprendendo le analisi di Parolin – «non è stata
condotta se non sul rapporto tra islam e stato», con particolare riferimento all’art.
2 della Costituzione del 1971: «L’islam è la religione dello stato, l’arabo la
sua lingua ufficiale e i principi del diritto musulmano la fonte principale
della legislazione», anche se il pacchetto di emendamenti sottoposto a
referendum verteva su altro. Dopo il voto referendario pare che l’art. 2 sia
scomparso dal dibattito pubblico e tutte le successive bozze di Costituzione lo
hanno mantenuto fondamentalmente invariato. Questo anche perché l’art. 2 «gode
– secondo Parolin – di quella caratteristica ambiguità che fornisce alle
previsioni costituzionali di compromesso una lunga tenuta» avendo in sé diverse
possibili interpretazioni.
La polarizzazione ideologica riscontrata nella campagna per il
referendum pare essere stata presente anche nel lungo processo di elezione dei
due rami del parlamento e nelle elezioni presidenziali.
Per quanto riguarda il ruolo dello stato nel fenomeno religioso
significativo è stato il dibattito sulla riforma dell’università al-Azhar. La
sua nazionalizzazione aveva segnato l’apice della penetrazione del potere
politico nel campo religioso, oggi la Costituzione stabilisce l’indipendenza di
al-Azhar e prevede che essa revisioni tutte le leggi prima della loro
promulgazione, per controllare che non siano in contrasto con la sharia.
Il Dialogo
Interreligioso
Il 18 novembre 2012, la Chiesa copta ortodossa egiziana ha
ufficialmente insediato il suo nuovo pontefice, Tawadros II, che si trova ad
affrontare come prima sfida il confronto con l’islam politico al governo.
Proprio per questo, poco dopo la sua elezione, papa Tawadros ha dichiarato di
voler servire l’interesse del paese intero ponendo l’accento sul dialogo e
l’unità nazionale, considerando se stesso, innanzitutto, un cittadino egiziano.
Egli ha inoltre espressamente affermato di voler privilegiare il ruolo
spirituale della sua Chiesa, con particolare attenzione all’educazione dei
giovani. Così facendo è parso abbracciare la posizione di chi vuole il ritiro
della Chiesa dalla politica. Al tempo stesso, però, ha anche ribadito che i
cristiani si aspettano il pieno rispetto dei loro diritti.
Per quanto riguarda le altre Chiese cristiane, poi, proprio
quest’anno, al termine della Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani a
gennaio, è nato il Consiglio nazionale delle Chiese di cui fanno parte tutte le
cinque confessioni dell’Egitto. L’idea è che il consiglio possa contribuire a
rafforzare l’unità tra i cristiani, a lottare su alcuni temi comuni, e ad
affrontare discriminazioni e violazioni di diritti.
In conclusione possiamo dire che, se da un lato la situazione
della libertà religiosa in Egitto non ha subito grosse trasformazioni a livello
legislativo con il nuovo governo e la nuova Costituzione, dall’altro è vero che
a livello di società civile qualcosa si sta muovendo. Elisa Ferrero riconosce
infatti come «sia un po’ caduto il tabù della religione, e ci siano maggiori
confronti aperti sul tema delle minoranze (riconosciute e non) e dell’ateismo».
«Il Centro culturale Tawasul è una piccola associazione nata
al Cairo nel 2006, su iniziativa di un gruppo di musulmani laici
(intellettuali, professori universitari, artisti, giudici, giornalisti, ecc.),
con lo scopo di creare uno spazio di incontro per la conoscenza reciproca fra
Europa e mondo arabo, musulmani e cristiani, che privilegiasse la relazione
diretta tra individui, piuttosto che quella tra istituzioni. Il termine arabo
Tawasul, impossibile da tradurre in italiano con una parola sola, ben esprime
l’idea ispiratrice del Centro. Esso riassume in sé, infatti, il significato di
una «continua comunicazione attraverso una relazione di amore».
Il 28 e 29 ottobre 2010, Tawasul ha ospitato il Meeting del
Cairo, un’edizione egiziana del Meeting di Rimini. Il risultato più importante
dell’incontro è stato il coinvolgimento di centinaia di giovani volontari
egiziani, musulmani e cristiani di ogni denominazione, che hanno lavorato
insieme per giorni. L’esperienza di dialogo e condivisione non si è fermata con
la fine del Meeting, ma è proseguita fino agli eventi del gennaio 2011, poiché
gli organizzatori e i volontari avevano deciso di continuare a incontrarsi
regolarmente per discutere insieme dei problemi della società egiziana e
sviluppare iniziative per contribuire alla loro risoluzione.
In seguito agli attentati contro le chiese copte di
Alessandria d’Egitto del Capodanno 2011 il Centro ha chiesto ai suoi membri e
ai volontari del Meeting del Cairo di indossare qualcosa di nero in segno di
lutto, quindi ha domandato a ciascun volontario musulmano di visitare una
chiesa del proprio quartiere per porgere le proprie condoglianze, come gesto
visibile di solidarietà. Pochi giorni dopo l’attentato, è stato poi organizzato
un concerto di musica sacra, musulmana e cristiana insieme, in segno di
riconciliazione, e alcuni suoi membri hanno partecipato alla messa di Natale
del 6 gennaio. Infine, il giorno 7 gennaio, subito dopo la preghiera del venerdì,
Tawasul ha organizzato una breve dimostrazione sul piazzale della moschea della
Luce del Cairo, occupando quel luogo in silenzio, per breve tempo, per impedire
le consuete arringhe contro i cristiani, tenute da fanatici che spesso prendono
la parola dopo la funzione.
I responsabili del Centro sono convinti che la lotta contro
il terrorismo e il fanatismo religioso non si gioca soltanto sul piano politico
e della sicurezza, ma soprattutto e fondamentalmente sul piano culturale. Molti
in Egitto l’hanno capito e stanno agendo in tal senso, meritando tutto il
nostro appoggio e la nostra collaborazione. Queste persone hanno principalmente
bisogno di visibilità e occasioni per far sentire la propria voce, poiché
troppo spesso le società civili dei paesi arabi vengono fatte scomparire dai
mezzi di informazione che prediligono la cronaca degli eventi che dividono,
nonostante siano proprio le società civili a lottare quotidianamente contro i
profeti dello scontro di civiltà».
Tratto da Qualcosa di nero in segno di lutto di Elisa
Ferrero.
Viviana Premazzi



 L’autore – Marco Pontoni è caporedattore all’Ufficio stampa
L’autore – Marco Pontoni è caporedattore all’Ufficio stampa
 Michele De Michelis
Michele De Michelis Nel
Nel

.jpg) Dopo la morte di Hugo Chávez e le elezioni del 14 aprile.
Dopo la morte di Hugo Chávez e le elezioni del 14 aprile.  Padre Pablo, in Europa e in generale nel mondo
Padre Pablo, in Europa e in generale nel mondo


 Intanto, padre Pablo, nelle elezioni di domenica 14
Intanto, padre Pablo, nelle elezioni di domenica 14 Libertà di stampa a rischio
Libertà di stampa a rischio

 Media sotto tiro
Media sotto tiro




 UOMINI E COCA
UOMINI E COCA 



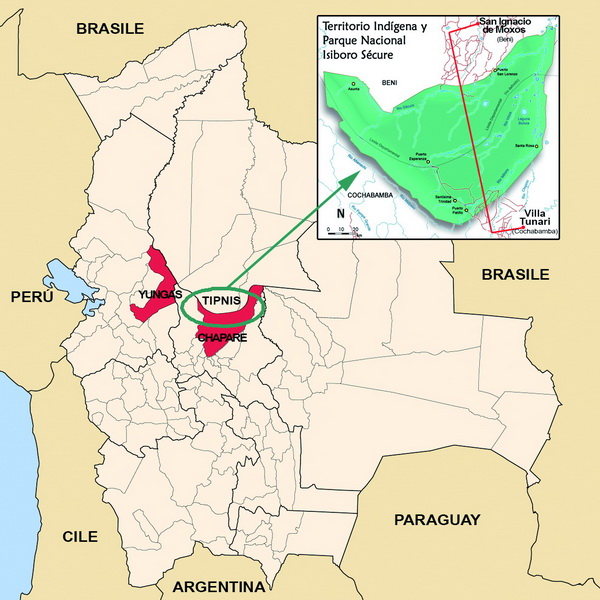 Il Tipnis è in pericolo. Il
Il Tipnis è in pericolo. Il



 I NUOVI TRAFFICANTI
I NUOVI TRAFFICANTI
 BABY-SOLDATI
BABY-SOLDATI 
 «SPOSE DI DIO»
«SPOSE DI DIO»
 SULLA STRADA
SULLA STRADA
 LAVORO INFERNALE
LAVORO INFERNALE
 VERGOGNA ITALIANA
VERGOGNA ITALIANA
.jpg) I MENDICANTI DI ALLAH
I MENDICANTI DI ALLAH
 SCHIAVI DEI DEBITI
SCHIAVI DEI DEBITI
 NELLE VISCERE DELLA TERRA
NELLE VISCERE DELLA TERRA