Minerali Insanguinati
Ricchezza di morte
Che cosa mi importa? In che modo mi
tocca un problema che riguarda popolazioni che vivono a migliaia di chilometri
da me? E, poi, perché devo essere considerato responsabile di conflitti di cui
si sa poco o nulla? Sembra di sentirle le domande che degli ipotetici ragazzi,
ma anche persone comuni, potrebbero porre a un (avventato) giornalista che si è
avventurato nel tema dei «minerali insanguinati» e proponesse loro un incontro
di sensibilizzazione.

Eppure, questo capitolo della
nostra storia contemporanea è molto più vicino a noi occidentali di quanto
sembri. È sufficiente guardarsi in tasca e prendere il proprio telefonino.
Quell’apparecchio, sempre più sofisticato, non potrebbe esistere senza alcuni
minerali (il coltan su tutti) provenienti dall’Africa. Minerali che vengono
estratti in miniere controllate da milizie (con la complicità di molti stati)
che, proprio dall’estrazione di quelle sabbie e pietre preziose, traggono il
sostentamento per continuare a combattere. Gli esempi in questo campo possono
essere numerosi: basti pensare all’impiego industriale del tungsteno, dello
stagno, dell’oro, ma anche al commercio dei diamanti.
L’Europa, per anni, non ha voluto varare leggi che
limitassero l’importazione di questi «minerali insanguinati». In tempo di
crisi, il timore era che ciò si trasformasse in nuovi costi per le imprese
continentali. L’esempio degli Stati Uniti, che nel 2010 ha approvato una
normativa che impedisce l’importazione di minerali dalla Repubblica Democratica
del Congo, ha spinto Bruxelles a scendere in campo. Il 20 maggio il Parlamento
europeo ha approvato un testo che limita l’importazione da zone di guerra. Ora
la parola passa alla Commissione europea che deve esprimersi prima che il testo
diventi definitivamente legge. In questo dossier abbiamo voluto fare il punto
su un tema delicato per l’Africa, ma che ha anche profonde ricadute sulle
nostre abitudini.
Repubblica
Democratica del Congo
 Una miniera a cielo aperto
Una miniera a cielo aperto
La ricchezza del suo
sottosuolo è anche la sua rovina. Un collaudato circuito criminale gestisce
l’estrazione clandestina in Congo e il contrabbando verso i paesi vicini. Così
il Rwanda diventa uno dei maggiori esportatori di coltan, pur non producendolo.
E si arricchisce, mentre nelle miniere si continua a morire.

«Si
pensa che la mafia sia presente solo in Italia. No, la mafia è attiva anche
nella Repubblica Democratica del Congo (Rdc). È un’organizzazione criminale
composta da politici locali, dirigenti delle grandi compagnie minerarie e
politici di paesi confinanti. E si alimenta delle nostre risorse». Monsignor
Fridolin Ambongo, vescovo di Bokungu-Ikela e amministratore apostolico di Kole,
non usa mezzi termini per denunciare lo sfruttamento illegale di minerali, ma
anche di legno e, in futuro, dell’acqua, del suo paese. «Molti anni fa –
osserva il vescovo – uno scienziato belga definì il Congo “uno scandalo
geologico”. Il mio paese ha un sottosuolo ricchissimo di minerali preziosi, ma
ha anche una foresta pluviale con legname pregiato e molti fiumi sempre gonfi di
acqua. E in futuro diventerà sempre più strategico controllare le risorse
idriche. Potrebbe essere uno stato ricco, in cui la popolazione vive in modo
pacifico e senza l’affanno della povertà. Invece i congolesi sono costretti
alla miseria, vessati dalle scorribande di milizie nazionali e straniere e sono
mal governati. La Rdc potrebbe essere un paradiso in terra, ma è un inferno».

Per meglio comprendere che cosa si nasconde dietro il
traffico illegale di minerali è necessario fornire alcuni dati. In questo ci
può aiutare il rapporto pubblicato dall’Unep (Programma delle Nazioni Unite per
l’ambiente) il 15 aprile e redatto in collaborazione con Interpol, alcune Ong e
istituzioni locali congolesi. Secondo questo rapporto, ogni anno vengono
contrabbandati dalle zone di guerra della Rdc un miliardo e 200 mila dollari
(circa 1,1 miliardi di euro) in oro, minerali preziosi, legname, carbone e
prodotti della fauna selvatica (avorio, ecc.). Questa ricchezza, in parte viene
portata in altre zone del Congo non toccate dal conflitto e, in parte,
all’estero (in prevalenza nei paesi confinanti). Solo dall’oro si otterrebbero
120 milioni di dollari (107milioni di euro), dal legno tra i 16 e i 48 milioni
di dollari, dai minerali tra i 7,5 e i 22,6 milioni di dollari. Senza contare
il bracconaggio, le tassazioni illegali, e altre risorse che producono profitti
per circa 28 milioni di dollari.
Questo traffico è gestito dalle milizie che operano sul
territorio, ma hanno collegamenti con grandi organizzazioni criminali
all’estero. Secondo un calcolo sommario dell’Unep, però, solo il 2% dei
profitti rimane in loco, il restante 98% finisce in mano a una rete criminale
che opera con la complicità degli stati confinanti: Burundi, Rwanda, Tanzania e
Uganda. Nonostante alle milizie locali rimangano poco più che le briciole di
questo immenso commercio illegale, i profitti riescono a mantenere almeno
ottomila uomini che combattono nelle fila di una cinquantina di gruppi armati.
«Queste milizie – spiega Massimiliano Pallottino, ricercatore del Centro
interdisciplinare di Scienze per la Pace dell’Università di Pisa, che si è a
lungo interessato di questo traffico – sono una pedina in mano alle grandi
organizzazioni criminali e vengono utilizzate per destabilizzare le aree
dell’Est del Congo, quelle più ricche di minerali. Questa destabilizzazione fa
buon gioco alle mafie locali perché nel caos è più semplice accaparrarsi le
risorse minerali e quelle naturali». Queste organizzazioni scommettono proprio
sulla confusione e sulla guerra, armando e finanziando ogni singolo gruppo
affinché nessuno prevalga e possa assumere una posizione dominante che
impedirebbe o modificherebbe i rapporti di forza attuali.

Come funziona il
traffico
Prima di addentrarci nell’articolato sistema di
sfruttamento dei minerali insanguinati in Rdc, è forse necessario fare una
premessa storica. Lo sfruttamento non è un fenomeno nuovo. A partire dagli anni
Settanta, quando a governare sul paese era il dittatore Mobutu Sese Seko, le
regioni orientali erano spogliate delle loro risorse da parte di una classe
politica rapace. Negli anni Novanta, in seguito al genocidio ruandese (1994),
le zone di confine tra Rdc, Uganda, Rwanda, Burundi sono diventate
particolarmente sensibili. È stato in quegli anni che molti miliziani hutu,
responsabili delle stragi in Rwanda, si sono rifugiati in Congo per cercare
protezione dalle vendette dei tutsi. Questi miliziani, per sopravvivere in
terra straniera, hanno iniziato a sfruttare le risorse immediatamente
disponibili e, in modo particolare, il coltan e l’oro i cui giacimenti sono
superficiali. Poco per volta si è strutturato un mercato complesso al quale non
partecipano più solo gli hutu ruandesi, ma anche milizie congolesi collegate
più o meno strettamente a governi stranieri (in particolar modo il Rwanda).
Il mercato illecito dei minerali si può descrivere come
strutturato in tre fasi distinte. La prima fase è quella dello sfruttamento
delle miniere. Queste possono essere controllate indifferentemente da milizie
oppure dalla popolazione locale o, ancora, da rifugiati. Per proteggerle, però,
la gente si arma creando insicurezza e violenza. In questo contesto, viene
estratto il materiale grezzo. Nel caso del coltan (ricordiamo che il 60% del
coltan estratto a livello mondiale proviene dalla Rdc), i minatori non hanno i
mezzi per separarlo dalle altre rocce e per raffinarlo. Essi hanno però la
necessità di vendere il coltan (ma anche altri minerali rari e l’oro), ma per
poterlo fare devono prima pagare tangenti alle milizie. Solo così ottengono il
via libera per portare il minerale agli intermediari, chiamati in francese comptornir
(banchi). Esistono comptornir nei pressi delle miniere o nei centri più
grandi dell’Est Congo (Goma, Bukavu). Questi intermediari, a differenza dei minatori,
hanno gli strumenti per trattare e valutare il minerale. Così lo rendono puro e
lo trasportano ad altri intermediari in Burundi, Rwanda o Uganda. «A Kigali,
Kampala o Bujumbura – continua Pallottino – esistono comptornir più grandi
che “ripuliscono” il minerale facendogli perdere la “cittadinanza” congolese e
facendolo diventare a tutti gli effetti ruandese, burundese, ma anche ugandese
e tanzaniano».
Infine il minerale viene venduto sul mercato
internazionale. Il coltan ripulito viene acquistato, tra le altre, da tre
grandi aziende che hanno sede in Cina, Germania e Kazakistan. Da esse viene
trasformato in semilavorati (polveri, leghe, lamine, ecc.) che poi vengono
venduti alle grandi multinazionali di prodotti elettronici: telefoni cellulari,
tablet, personal computer, piattaforme per i giochi, ecc.

«Inutile nascondersi dietro a un dito – osserva Frédéric
Triest della rete Eurac (European Network for Central Africa) – dietro
alle milizie che si combattono sul suolo congolese ci sono paesi stranieri:
Uganda, Burundi, ma, soprattutto, Rwanda. Sono questi stati a fomentare le
ribellioni. L’instabilità fa il loro gioco perché da essa traggono una
ricchezza notevole. Kinshasa non vuole intervenire, sia perché non ne ha la
forza, sia perché molti politici congolesi corrotti sono complici di questo
traffico».
In questi ultimi vent’anni è il Rwanda ad aver fatto la
parte del leone. Kigali ha finanziato molte milizie locali. Pensiamo all’M23,
un gruppo congolese a base etnica tutsi, che ha terrorizzato le zone di
frontiera. Proprio grazie ai finanziamenti e all’appoggio politico ruandesi ha
potuto controllare per anni la zona al confine tra Rwanda e Congo e sfruttae
a fondo le risorse minerarie, che venivano poi dirottate su Kigali. Ma, anche
dopo la sconfitta dell’M23 (2013), Kigali è rimasta la meta di buona parte dei
minerali preziosi, coltan e oro in particolare. Non è un caso che il Rwanda sia
diventato il primo esportatore mondiale di tantalio, estratto sotto forma di
coltan (vedi box sui minerali). Secondo le statistiche pubblicate a fine 2014
dalla Banca centrale di Kigali, nel 2013, ne ha esportato 2.466.025 kg, il 28%
del mercato mondiale del minerale, per un incasso di 134,5 milioni di dollari.
Nel 2014 ha raggiunto le 1.931 tonnellate per un controvalore di 87,4 milioni
di dollari. Il calo delle entrate è, in parte dovuto al calo della produzione,
in parte alla diminuzione del prezzo medio al kg. Il Goveo guidato dal
presidente Paul Kagame si è posto l’obiettivo di ottenere un guadagno di 400
milioni di dollari all’anno dal settore minerario entro il 2017. Ci riuscirà?
«Questi – osserva Triest – sono i dati ufficiali foiti dalla Banca centrale
ruandese. Non sappiamo quanto sia la reale capacità produttiva del paese e
quanto invece arrivi di contrabbando dall’Rdc. A nostro parere, il Rwanda sta
sfruttando le carenze della legge statunitense Dodd-Frank». Questa normativa
(vedi box) vieta l’importazione negli Usa di quattro minerali che si estraggono
nella Rdc. Coltan e oro vengono quindi portati in Rwanda (ma anche in Burundi e
Uganda), ed è qui che poi le multinazionali si approvvigionano acquistando
minerali «ripuliti». «È per questo motivo – sottolinea Triest – che abbiamo
chiesto che venga imposto un embargo alle nazioni che confinano con il Congo e
che la comunità internazionale imponga anche a Rwanda, Burundi e Uganda (e non
solo a Kinshasa) di sedersi a un tavolo di trattativa per riportare la pace
nella regione. È a questo tavolo che si deve discutere anche della questione di
una equa ripartizione delle risorse».

«Le responsabilità – osserva mons. Ambongo – sono
evidenti. Questo traffico sarebbe impossibile senza la partecipazione delle
autorità locali, che invece di pensare al bene comune, permettono lo scempio
del loro territorio e sono complici delle milizie; le autorità nazionali, che
non intervengono; le compagnie minerarie straniere, che sfruttano il
territorio, ma non pagano le tasse al paese e trasformano altrove i nostri
minerali; gli stati confinanti, che fomentano il caos per arricchirsi».
È la popolazione locale a pagare il prezzo più alto di
questa illegalità. Se, infatti, è vero che lo sfruttamento delle miniere
garantisce qualche provento ai congolesi, è anche vero che questi sono vittime
di sfruttamento e di violenze inaudite. Le miniere sono gironi infeali dove
uomini, donne e bambini sono costretti a scavare a mani nude o con mezzi di
fortuna per estrarre i minerali preziosi. Spesso le gallerie crollano facendo
numerose vittime, soprattutto tra i più piccoli. Se le persone non muoiono
lavorando, spesso si ammalano di malattie linfatiche a causa della
radioattività del terreno. Il costo sociale è elevatissimo. Migliaia di ragazzi
non frequentano la scuola. Molte donne sono vittime di violenze fisiche e
sessuali. Spesso le ragazze vengono avviate alla prostituzione. Chi può se ne
va, emigra verso altre regioni del Congo o all’estero. «I proventi delle
risorse minerarie – osserva Martin Kobler, responsabile della Monusco, la
missione Onu in Rdc – vanno a finire nelle mani di milizie che continuano ad
alimentare il conflitto invece di finanziare il sistema di infrastrutture
locali, le scuole, gli ospedali. Immaginate se potessimo spendere queste
centinaia di milioni di euro per pagare insegnanti, medici, e promuovere
business e turismo».
La Chiesa cattolica ha chiesto a più riprese alla
comunità internazionale di intervenire e di approvare normative inteazionali
che impediscano lo sfruttamento di questi minerali. «La legge Dodd-Frank –
conclude mons. Ambongo – è un’iniziativa che noi riteniamo positiva, anche se
va ulteriormente migliorata. Ci aspettiamo che anche l’Europa ne segua
l’esempio approvando una regolamentazione che impedisca l’utilizzo dei minerali
provenienti dalle zone di guerra della Rdc. Solo così si può creare un mercato
più trasparente e si possono spuntare le armi delle milizie e delle
organizzazioni che sfruttano il nostro territorio».

![]() Repubblica
Repubblica
Centrafricana (Rca)
Pietre preziose e religioni
In Rca dal 2013 si
combatte una guerra a sfondo religioso. Ma il traffico dei diamanti e dell’oro
ne sono una molla imprescindibile. Le milizie sedicenti cristiane e musulmane
si finanziano tramite il traffico illegale dei minerali. In gran parte estratti
da bambini in condizioni deplorevoli.
Forse
i più giovani non sanno neppure chi sia. Ma per chi oggi ha tra i 45 e i 60
anni, Jean Bedel Bokassa, il folle dittatore che si incoronò imperatore del
Centrafrica, è un ricordo vivo con il suo sfarzo esibito in una nazione
poverissima e la sua crudeltà nei confronti degli oppositori. Fu lui, tra
l’altro, a far conoscere al mondo la ricchezza mineraria del suo paese. Lo
fece, destando scandalo, quando regalò all’allora presidente della Repubblica
francese, Valery Giscard d’Estaing, alcuni diamanti. Furono quelle pietre a
costare la rielezione al Capo dello Stato transalpino e a spalancare le porte
della presidenza a François Mitterrand.
Dopo la caduta di Bokassa nel 1979, si sono susseguiti
una serie di golpe che hanno gettato il paese in uno stato di instabilità
continua, con ampie porzioni di territorio fuori dal controllo del potere
centrale. Ciò ha fatto sì che le ingenti risorse minerarie non potessero essere
sfruttate in modo razionale e i loro proventi investiti nello sviluppo. Negli
anni, neanche le multinazionali hanno investito in Centrafrica, nonostante le
grandi potenzialità. Troppo poche le infrastrutture, troppi i rischi: estrarre
lì comporterebbe costi troppo elevati. Così, gran parte della produzione di
diamanti (ma anche dell’oro che viene estratto in abbondanza) viene messa in
commercio sul mercato nero e contrabbandata all’estero. La destinazione
principale è il Ciad dove i trafficanti vendono le pietre alle grandi
multinazionali che hanno i propri uffici a Ndjamena, la capitale.
La guerra civile scoppiata nel 2013 non ha modificato
questo sistema, ormai collaudato da anni (cfr. MC ottobre 2013 e luglio 2014).
Anzi, se possibile, l’ha potenziato. Secondo alcune stime (per forza
incomplete), dal dicembre 2013, quando è stato attivato l’embargo
internazionale nei confronti del Centrafrica, sarebbero 140mila i carati di
diamanti, a essere stati contrabbandati fuori dal paese, con un valore pari a
24 milioni di dollari.
Alcuni osservatori inteazionali sostengono addirittura
che Séléka, il principale movimento ribelle di matrice islamica, proveniente
dalle province del Nord, sia stato finanziato da operatori del settore
diamantifero proprio per destituire François Bozizé, allora al potere.
Quest’ultimo aveva infatti siglato accordi con imprese minerarie sudafricane
per lo sfruttamento dei giacimenti di diamanti. Non è un caso che proprio i
soldati sudafricani abbiano difeso fino all’ultimo Bozizé (e che tredici di
essi siano morti).
I proventi di questo traffico vengono utilizzati dalle
milizie, sia i Séléka sia i loro avversari, chiamati anti-Balaka, per
acquistare armi, equipaggiamenti e cibo per i combattenti. Secondo gli esperti
dell’Onu, anti-Balaka e Séléka (o i gruppi che rimangono dopo il suo
scioglimento) impongono tasse sui minerali estratti e addirittura possiedono
centri di smistamento e di rivendita dei minerali preziosi.
Attraverso immagini satellitari, gli esperti hanno
notato che la produzione di diamanti è esplosa specialmente nella zona Nord
orientale controllata dagli ex Séléka, dove non è presente nessuna forza
internazionale. Nella miniera di Ndassima, vicino Bambari, anch’essa nelle mani
dei ribelli, avrebbero anche cercato di organizzare una catena di produzione e
una rete di distribuzione, concedendo licenze minerarie per lo sfruttamento.
Le miniere sono gironi infeali nei quali lavorano a
ciclo continuo uomini, donne e, soprattutto, bambini per pochi spiccioli al
giorno. È un modo per contrastare la miseria dilagante. In Centrafrica, il 60%
della popolazione vive con poco più di un euro al giorno, la metà è analfabeta,
l’Indice di sviluppo umano del paese è inchiodato agli ultimi posti della
classifica mondiale.

I diamanti della guerra
I diamanti della Sierra
Leone sono facili da estrarre. Già in epoca coloniale i britannici ne
approfittavano. Il paese ha poi vissuto una guerra civile molto violenta,
alimentata dal traffico della pietra preziosa. Ma il paese è ricco anche di
altri minerali e oggi il governo vuole investire sul settore. Così molti
giovani diventano minatori, ma le condizioni di lavoro sono terribili.
Quando
si parla di «diamanti insanguinati» balza subito alla mente la tragica guerra
civile che si è combattuta in Sierra Leone dal 1991 al 2002. Un conflitto che
ha fatto centinaia di morti e che si è alimentato con il contrabbando di pietre
preziose (e anche di oro). Sono ormai passati 13 anni dalla fine delle
ostilità, ma quel traffico non è cessato. Prosegue senza sosta e a pagae il
costo sono ancora le fasce più povere del paese e, in particolare, i bambini.
Oggi come allora, possiamo ancora chiamare quei diamanti «insanguinati»,
riferendoci al sangue di chi, tra mille sofferenze li estrae, anche se le armi
tacciono ormai da tempo.
Per comprendere meglio le dinamiche di questo mercato
distorto è forse utile fare un passo indietro risalendo ai tempi del
colonialismo britannico.

La scoperta dei
giacimenti
È negli anni Trenta che i britannici, che allora
controllavano la regione, scoprono ricchi giacimenti di diamanti. Sono pietre
di tipo alluvionale, si trovano cioè quasi in superficie e sono libere dalle
rocce. Estrarli è quindi semplice e non richiede l’impiego di tecnologie
sofisticate come avviene in Sudafrica, dove le pietre preziose si trovano nella
kimberlite e devono essere divise dalle rocce.
Per sfruttare questi giacimenti ricchissimi, Londra
cerca la collaborazione di alcune grandi compagnie minerarie e, dopo vari
contatti a livello internazionale, decide di dare la concessione a una
compagnia angloamericana: la Sierra Leone Selection Trust. Nel momento
in cui viene concesso il monopolio a questa compagnia, ogni altra società
mineraria od ogni altro individuo che estrae diamanti, lo fa in modo illegale.
Ma controllare i bacini diamantiferi è quasi impossibile. Le popolazioni locali
infatti comprendono immediatamente come sia facile estrarre le pietre e quale
grande valore esse abbiano. Quindi prende il via un’attività artigianale di
sfruttamento dei giacimenti che, sebbene contrasti la legge, diventa fiorente.
«In quel periodo – spiega Lorenzo D’Angelo, antropologo,
docente dell’Università Cattolica di Milano – l’estrazione artigianale aveva
anche una valenza politica. Era un modo per danneggiare gli interessi coloniali
perché sottraeva risorse alla potenza occupante. Già in periodo coloniale si
creano tensioni intorno alle miniere e alla loro gestione. Nella regione del
Kono, nasce addirittura un partito che rivendica una partecipazione maggiore
dei sierraleonesi nella gestione delle risorse».
Con l’indipendenza, però, la situazione non muta molto.
La nuova classe politica, legata ancora alla Gran Bretagna, lascia la gestione
dei bacini nelle mani della Sierra Leone Selection Trust. Ma, anche
quando il presidente-dittatore Siaka Probyn Stevens decide di nazionalizzare la
compagnia, lo fa non per favorire la crescita del paese, bensì per accaparrarsi
una fonte di reddito sicuro per sé e il suo gruppo di potere. Non è un caso
che, quando nel 1985 Stevens lascia il potere, il paese è allo stremo. Le
differenze sociali sono stridenti e la povertà dilaga. La Sierra Leone è come
un barile di dinamite pronto a esplodere alla prima scintilla.

La scintilla si accende nel 1991 quando un gruppo di
soldati addestrati penetra dalla Guinea nella regione del Kono (dove si
concentrano i principali depositi diamantiferi) e inizia ad attaccare i
villaggi e a reclutare civili in modo forzato. Il conflitto si infiamma e si
estende a tutto il paese.
La guerra civile sierraleonese diventa famosa in tutto
il mondo per la brutalità con la quale viene combattuta: le stragi di civili
(alla fine i morti saranno 120mila), le mutilazioni di diverse migliaia di
persone, l’arruolamento di bambini soldato, le violenze sulle donne. E anche
per l’estrazione e l’esportazione illegale di diamanti.
«Da molte parti – continua D’Angelo – si sostiene che il
controllo dei bacini diamantiferi fosse la ragione più profonda del conflitto
sierraleonese. Io sono dell’avviso che la causa della guerra civile sia stata
l’ingiustizia sociale, la corruzione, lo sfruttamento. I diamanti servivano
solo ad alimentare il conflitto. Erano la merce di scambio con la quale le
parti acquistavano armi, equipaggiamenti e cibo. Certo, negli ultimi anni,
quando i miliziani hanno perso il senso di ciò che facevano, il controllo delle
miniere era un modo per arricchire i capi, ma all’inizio non era così».
L’esportazione avviene secondo uno schema già collaudato
prima della guerra. I diamanti vengono venduti dalle parti in conflitto all’estero
e da qui verso i mercati inteazionali. I paesi confinanti, Liberia e Guinea,
entrano nel novero dei maggiori esportatori di diamanti, pur avendo un numero
decisamente inferiore di miniere rispetto alla Sierra Leone. I proventi della
vendita delle preziose pietre non alimentano solo la guerra in Sierra Leone.
«Il traffico dei diamanti in Africa occidentale – osserva D’Angelo – viene
controllato in gran parte dalla comunità libanese che, già negli anni Ottanta,
destinava una parte dei proventi dell’estrazione illegale al sostegno delle
milizie che si combattevano in Libano».

La cessazione delle ostilità, dichiarata il 18 gennaio
2002 dal presidente Ahmad Tejan Kabbah, non cambia molto le cose. Il paese è
devastato da undici anni di guerra. Le infrastrutture sono distrutte. Le
attività commerciali devono essere rilanciate. La popolazione ha sofferto
moltissimo per le violenze. Nonostante gli aiuti inteazionali, la Sierra
Leone fatica a riprendersi.
La nuova classe politica scommette di nuovo sulle
risorse minerarie. Il paese, pur essendo molto piccolo, è ricchissimo non solo
di diamanti, ma anche di ferro, rutilio (utilizzato per produrre il titanio),
bauxite (indispensabile per produrre alluminio), oro, platino e cromo.
Molte miniere vengono riaperte. «Il valore del ferro in
piccole quantità è risibile e quindi l’estrazione a livello artigianale non ha
alcun senso – osserva D’Angelo -. Le miniere di ferro, come quelle di bauxite e
di rutilio, devono quindi essere sfruttate con tecnologie in grande scala cosa
che può essere fatta solo da grandi compagnie minerarie. Diverso il discorso
per l’oro e i diamanti».
In un paese dove la disoccupazione è altissima (70%) il
miraggio di diventare ricchi oppure anche solo di trovare un lavoro che
permetta di tirare avanti è fortissimo. Molti ragazzi diventano così minatori
artigianali. Lavorano fino a 20 ore al giorno per una paga che va dai 2 ai 5
euro e che arriva fino a 12 euro se trovano un diamante. I costi sociali sono
elevatissimi. I ragazzi (spesso bambini) abbandonano la scuola consegnandosi a
un futuro di analfabetismo.
Una ricerca dell’Ong Inteational Human Rights
ha denunciato le pessime condizioni di vita e di lavoro. I bambini sono
costretti a portare ogni giorno sulla testa sacchi di 30 e più kg e a vivere
nei giacimenti senza protezioni per gli infortuni. Il cibo è scarso e nei
villaggi non c’è assistenza medica.
Le miniere sono gestite da sierraleonesi che sono
riusciti a strappare una licenza di estrazione. Questi si prendono i minerali
estratti e sottopagano i minatori. I diamanti vengono poi venduti ai
commercianti all’ingrosso, in particolar modo i libanesi. Questi, a loro volta,
li immettono nel circuito internazionale, vendendoli ai centri di taglio
principali (Olanda, Belgio, Thailandia, Israele, Paesi del Golfo, ecc.).
Molto spesso chi dovrebbe verificare le condizioni di
lavoro e di sfruttamento dei giacimenti viene corrotto. Così i funzionari
governativi chiudono gli occhi di fronte all’uso e allo sfruttamento dei bambini.
Una parte di questo sistema alimenta anche il contrabbando. Alcuni minatori
sottraggono i diamanti ai loro capi e li rivendono all’estero. È un’impresa
rischiosa perché se vengono scoperti sono percossi e, talvolta, rischiano la
vita. La guerra non c’è più, ma i diamanti rimangono insanguinati.

![]() Come si muove l’Unione
Come si muove l’Unione
Europea
Una legge sui minerali
Anche l’Unione
europea vuole dotarsi di una legislazione sulla tracciabilità dei minerali
strategici, troppo spesso legati ai conflitti. Un primo importante passo è
stato compiuto lo scorso 20 maggio. Fondamentale è stata l’azione di advocacy
della società civile europea.
Il
20 maggio il Parlamento europeo ha approvato un testo che introduce la
tracciabilità obbligatoria per le 800mila imprese dell’Ue che utilizzano, per
la fabbricazione dei loro prodotti, i minerali provenienti da aree interessate
da guerre. Le imprese dovranno garantire informazioni «su tutte le misure prese
per identificare e risolvere i rischi connessi alla loro catena di approvvigionamento».
In pratica, si istituisce un sistema di tracciabilità dei minerali provenienti
da aree di conflitto. È un risultato positivo, frutto anche della azione di advocacy
della società civile europea, sia quella laica sia quella di ispirazione
cristiana. Però non bisogna illudersi. Il cammino è ancora lungo.

Di tale normativa si parla da anni. Le lobby
industriali, sostenute dalle frange più conservatrici del parlamento, hanno
sempre fatto forti pressioni per evitare l’approvazione di una legge in questa
materia. L’obiezione che veniva (e viene ancora) posta era che una simile
normativa aumenterebbe i costi per le imprese europee (già in difficoltà per la
crisi economica) e le porrebbe fuori dal mercato.
Nel 2010, però, gli Stati Uniti hanno approvato la legge
Dodd Frank (vedi box pag. 40) che impone alle aziende statunitensi quotate in borsa,
e che utilizzano stagno, tantalio, tungsteno e oro nelle loro produzioni, di
certificare che questi minerali non provengono dalla Repubblica Democratica del
Congo e dai paesi confinanti. La legge americana si basa su un approccio di
tipo vincolante per tutte le compagnie quotate, fissa aree geografiche definite
e stabilisce con precisione a quali minerali si rivolge.
L’esempio degli Stati Uniti ha convinto anche l’Europa a
prendere provvedimenti in questo comparto. Così nel marzo 2014, la Commissione
europea ha presentato una proposta di regolamento che prevede un sistema di
autocertificazione per gli importatori di stagno, tantalio, tungsteno e oro. In
base a tale normativa, l’importatore può cioè autocertificarsi come importatore
responsabile, ma non ne ha l’obbligo. Di fronte a questo testo è insorta la
società civile che ha chiesto di introdurre requisiti «obbligatori» di
certificazione, di includere una gamma più ampia di imprese (tutta la filiera,
non solo gli importatori), di aumentare il numero di minerali interessati.

Certificazione
obbligatoria, ma …
All’inizio di quest’anno, il regolamento proposto dalla
Commissione europea è stato vagliato dalla Commissione per lo sviluppo e da
quella del commercio internazionale del Parlamento europeo. La norma è stata
modificata. La certificazione è stata resa obbligatoria, ma solo per le
fonderie e le raffinerie dell’Unione europea (tutti gli altri attori sono stati
esclusi) e anche la lista dei minerali è rimasta limitata a stagno, tantalio,
tungsteno e oro. Il 20 maggio scorso questo testo è poi arrivato in Parlamento
che lo ha discusso in seduta plenaria. Con 400 voti a favore, 285 contro e
sette astensioni, l’aula di Strasburgo ha approvato l’obbligo della
tracciabilità, non solo per le raffinerie, ma per l’intera filiera produttiva.
Il testo rafforza quindi la proposta che era stata avanzata dalla Commissione e
quella discussa da Commissione per lo sviluppo e da quella del commercio
internazionale del Parlamento europeo.
«È Stata una delle più belle battaglie della mia vita
parlamentare. Ringrazio i gruppi che l’hanno condivisa, mi rammarico per chi
non l’ha fatto – ha dichiarato alle agenzie Gianni Pittella, vicepresidente
vicario del Parlamento europeo e capogruppo dei Socialisti democratici -. Un
voto che mi ha emozionato perché è anche etico, rivoluzionario: la maggior
parte dei conflitti viene alimentata dalla produzione di “mineral conflicts”,
con le organizzazioni criminali che sfruttano le popolazioni. Se eliminiamo
questi interessi, eliminiamo questi conflitti o, almeno, aiutiamo a
eliminarli».
Questa normativa potrebbe avere un forte impatto non
solo sui conflitti, ma anche sulle aree di crisi. Il testo di legge infatti
include «le aree affette da conflitto»
ma anche quelle «ad alto rischio» cioè quelle con violenza diffusa,
collasso delle infrastrutture civili, aree in uno stadio di post conflitto,
regioni senza governo. Tra di esse, in particolare, la Repubblica Democratica
del Congo, paese ricchissimo di risorse e, al tempo stesso, caratterizzato da
continue violazioni dei diritti umani.

Il provvedimento ha profonde ricadute anche sulla nostra
vita quotidiana. I metalli presi in considerazione sono infatti molto presenti
negli oggetti che utilizziamo ogni giorno: computer, telefoni cellulari,
apparecchiature elettroniche ed elettriche, strumenti medicali, ecc. È stato
quindi compiuto un primo passo verso un’economia più rispettosa dei diritti
umani e delle popolazioni dei paesi del Sud del mondo.
«Abbiamo vinto una battaglia, non la guerra – osserva
però Nicolas Van Nuffel, presidente di Eurac (Réseau européen pour l’Afrique
Centrale) -. Chiediamo al Consiglio e alla Commissione europea di prendere
in considerazione la posizione del Parlamento europeo per avviare una
discussione approfondita e arrivare infine all’approvazione di una legge». Ora
infatti toccherà ai singoli stati membri esprimere la loro posizione. In seguito
si apriranno negoziati tra Commissione, Consiglio e Parlamento. «Sappiamo per
esperienza – aggiunge Emmanuelle Devuyst del Jesuit
European Social Centre (i gesuiti sono stati molto attivi
in questa campagna) – che il Consiglio dell’Unione europea (che rappresenta i
governi degli stati membri) cercherà di depotenziare i risultati positivi
raggiunti in Parlamento. Dobbiamo convincere i nostri governi a rispettare le
decisioni dell’assise di Strasburgo».
«Gli Stati membri europei – ha aggiunto però più ottimista
Stefan Reinhold, cornordinatore dei lavori di advocacy compiuti da Cisde
(una rete di Ong cattoliche) – avranno ora la possibilità di sostenere e
rafforzare ulteriormente questa legislazione. Ci sono molti esempi provenienti
da tutta Europa, come la legge Due Diligence in Francia o la Mode
Slavery Act nel Regno Unito, che mostrano una netta tendenza nel
regolamentare meglio le attività delle imprese, in modo da evitare il loro
coinvolgimento in violazioni dei diritti umani e dare garanzie ai cittadini di
non essere complici attraverso i propri acquisti».


In Italia, piccoli
passi
Commissione industria, commercio, turismo e quella politiche dell’Unione
europea del Senato hanno approvato una risoluzione nella quale si affermava che
fosse «opportuno rafforzare l’adesione delle imprese europee al regime di auto
certificazione della Due Diligence nella catena di approvvigionamento
dei minerali, prevedendone la obbligatorietà o, in subordine, prevedendo
specifici meccanismi di incentivazione all’adesione volontaria» e si aggiungeva
«che l’accesso all’autocertificazione di “impresa responsabile”, attualmente
prevista solo per le imprese importatrici» fosse «esteso anche alle imprese che
commercializzano prodotti finiti contenenti i minerali contemplati dalla
proposta di regolamento».
Questa risoluzione però è stata approvata sulla base del
testo della Commissione europea oggi superato dal documento passato in
Parlamento. Quindi è necessario che il Parlamento stimoli il governo a prendere
atto delle novità e ad agire di conseguenza nelle sedi europee. «Il nostro
Esecutivo – osserva Lia Quartapelle, deputata del Pd e membro della Commissione
esteri della Camera – deve prendere atto della necessità, evidenziata dal testo
approvato a Strasburgo, di rendere obbligatoria la certificazione. Allo stesso
tempo, il governo deve far sì che le aziende, soprattutto quelle di piccole e
medie dimensioni, possano accedere ai fondi europei che permettano alle imprese
di far fronte ai maggiori costi che la tracciabilità impone». Proprio Lia
Quartapelle ha presentato a giugno un’interpellanza urgente per chiedere conto
al governo della posizione italiana in Europa su questo tema. La risposta è
attesa per i primi di luglio.

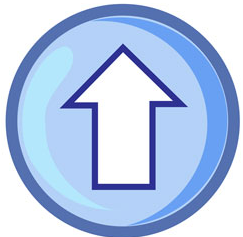 Questo dossier
Questo dossier
Enrico Casale: giornalista, africanista, lavora alla
Fondazione Magis (Ong dei Gesuiti italiani) e collabora con alcune testate
missionarie e Radio Vaticana. Casale è da anni collaboratore di MC sui temi africani.
• In ultima pagina: minatori della Gecamines, nel Kolwezi,
Rdc.
Le foto del dossier sono gentilmente offerte da Fairphone,
in regime di Creative commons, e da IrinNews.
Tags: materie prime, guerre, minerali insanguinati, coltan, traffico materie prime, tracciabilità minerali, minerali, Africa, RD Congo, Centrafrica, Sierra Leone
Enrico Casale
